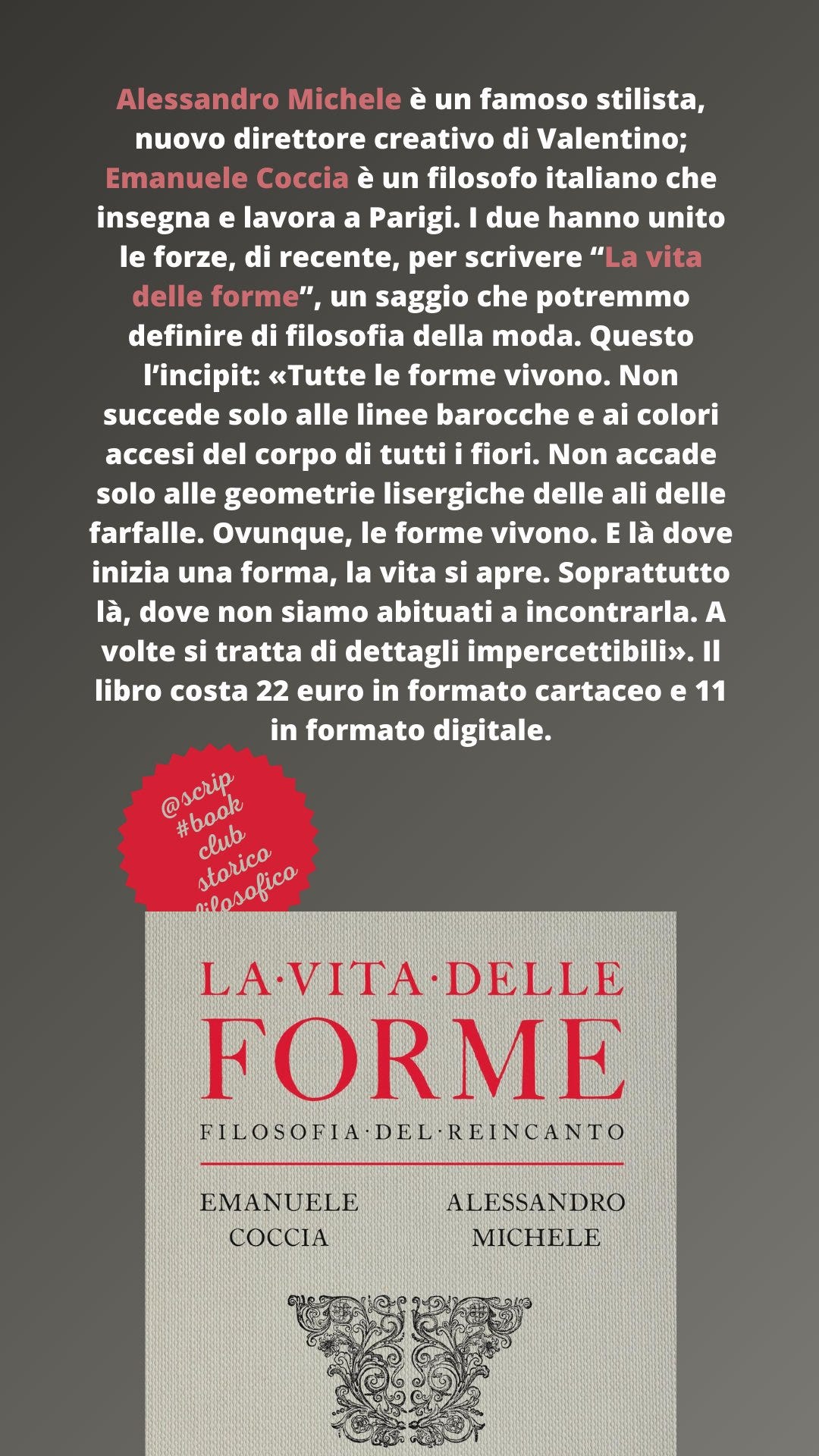Alcuni nuovi appunti sui problemi dello smartphone a scuola (e a casa), ma parliamo anche di Inside Out, Umberto Eco, Simone Weil, Sam Raimi, R.E.M., fascismo eterno, Crashing, Nudge e altro ancora
Dopo un inizio estate perfino un po’ freddino, ormai è arrivato – come una valanga – il gran caldo, e qui in città si boccheggia. Questo non impedisce di pensare alla storia e alla filosofia, ovviamente, e infatti il programma della newsletter di questa settimana, come noterete, è piuttosto vario e completo, e molte altre iniziative sono all’orizzonte per settembre/ottobre, quando tutto il “baraccone” ripartirà a pieno ritmo e il clima (si spera) sarà più mite.
Se volete qualche anticipazione, posso dirvi che stiamo lavorando per organizzare in primo luogo degli incontri in presenza, per parlare del libro e non solo, in alcune zone del nord Italia; posso dirvi che sto lavorando anche ad alcuni progetti più didattici (e impegnativi), che forse in un futuro non troppo lontano vi aiuteranno a studiare meglio (o almeno lo spero) sia la storia che la filosofia; posso dirvi infine che stiamo imbastendo anche delle collaborazioni con enti e istituzioni per parlare di storia e/o di filosofia in canali diversi, rivolgendoci anche a un pubblico diverso da quello che già segue il canale.
Tante piccole o grandi novità, tante piccole o grandi sfide. Anche tanto lavoro, devo dire, ma per ora si riesce a portare avanti più o meno tutto; vedremo quanto durerò. Intanto la newsletter di questa settimana è corposa come sempre, con tanti libri, tanti audiovisivi e fin troppe riflessioni. E direi che è venuto il momento di cominciarla, no?
Ah, un’ultima cosa però prima di dare il via alle parole: come sempre vi devo anche ricordare il mio libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva, ormai uscito da un mese abbondante e sul quale arrivano ottimi riscontri. Se l’avete letto e vi è piaciuto, considerate anche di recensirlo online (sui social, o su Amazon, o su IBS, o su Goodreads o dove volete), in modo che si sparga ulteriormente la voce. Grazie!
Quello che ho letto
Cominciamo prima di tutto con i libri, con in elenco due titoli nuovi (almeno per me, non certo per l’editoria) e uno vecchio. Iniziamo.
Nudge. La spinta gentile di Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein: rimettendo in ordine la libreria questa settimana mi sono accorto che un paio di mesi fa ero arrivato quasi a conclusione di questo libro, ma non l’avevo effettivamente finito. Il segnalibro infatti era fermo sulle ultime 15 pagine e mi sono reso conto insomma che lo avevo distrattamente lasciato lì, convinto ormai di essere giunto a conclusione senza esserci arrivato davvero. L'errore era in parte inevitabile, perché in effetti tutti i temi del libro erano ormai stati sciorinati: l'ultima parte della mia edizione infatti si concentra su una sorta di aggiornamento legato alla crisi economica del 2007, attorno alla quale gli autori hanno provato a fare qualche analisi cercando di ribadire la loro visione. Comunque, per farla breve, ho finalmente finito il saggio e vale forse la pena adesso di trarre qualche veloce conclusione. Come avevo già spiegato tempo fa, l'idea in fondo del volume è originale e piuttosto intrigante: gli autori propongono infatti quella che definiscono una forma di “paternalismo libertario”. Esso consiste essenzialmente in questo: secondo gli autori gli stati non dovrebbero decidere (come a volte fanno) per i cittadini, lasciando invece al singolo l'onere di ogni decisione rilevante; allo stesso tempo, però, quegli stessi stati dovrebbero però dare quelli che potremmo definire dei suggerimenti impliciti, delle indicazioni di massima che possano favorire dei comportamenti sani a scapito di quelli che possono essere previsti come comportamenti dannosi. Per fare un esempio, secondo Thaler e Sunstein lo Stato non dovrebbe proibire certi alimenti zuccherosi e poco sani, ma dovrebbe piuttosto rendere in qualche modo più difficile il loro acquisto, come appunto a dare un suggerimento implicito all'acquirente, che troverà quindi più complesso, anche se non impossibile, seguire una dieta poco salutare. Questo discorso ovviamente vale per il cibo ma vale per tutta una miriade di altre cose: gli esempi spaziano dall'economia ai piani pensionistici, dalla salute pubblica all'istruzione e via discorrendo. L'approccio è sicuramente interessante, perché mette in campo un tentativo di far convivere libera scelta individuale e salute pubblica, con un ruolo in qualche modo attivo da parte dello Stato, che dovrebbe continuare ad aiutare gli individui, soprattutto quelli più incerti e incapaci di controllarsi adeguatamente. Il problema, semmai, è che questo approccio può funzionare meglio in certi ambiti piuttosto che in altri, e che comunque parte dal presupposto che l'individuo, una volta messo davanti con consapevolezza alle principali questioni, possa effettuare scelte non dico razionali ma quantomeno controllate. Detta in altri termini, devo ammettere che leggendo mi sono sorti due dubbi principali: il primo, più banale, è che non sempre uno Stato riesce a decidere con saggezza quale sia la soluzione migliore da suggerire, forse perché in effetti una soluzione migliore di per sé neppure esiste; il secondo, forse più generale, è che comunque gli esseri umani, anche davanti ai migliori consigli, tendono comunque a fare scelte sbagliate, e quindi la teoria della spinta gentile potrebbe rivelarsi comunque inefficace in molti casi anche assai importanti. Il libro, ad ogni modo, è stimolante, ti costringe a fare i conti con molte questioni e di sicuro lo suggerirei come una teoria con cui confrontarsi. Lo potete acquistare – tra l’altro a un prezzo piuttosto basso – qui.
L’isola del giorno prima di Umberto Eco: nonostante abbia letto diversi libri di Umberto Eco sia nell'ambito della narrativa che in quello della saggistica, non avevo ancora mai affrontato quello che è uno dei suoi romanzi più famosi, L'isola del giorno prima. Pubblicato per la prima volta nel 1994, questo libro costituiva alla sua uscita la terza prova dello scrittore piemontese nell’ambito della narrativa, dopo il successo planetario ottenuto all’esordio con Il nome della rosa. E non avevo mai letto questo volume un po’ perché Il nome della rosa, che ho divorato per la prima volta giovanissimo, è uno di quei libri che ti riempie, e a cui non vuoi dare tanto presto un seguito; un po’ perché mi è capitato negli anni di affrontare, invece, gli ultimi romanzi di Eco, come La misteriosa fiamma della regina Loana o Il cimitero di Praga, e entrambi quei libri li ho trovati (in misura diversa) sottotono, interessanti sotto certi punti di vista ma in generale incapaci di suscitare vere emozioni nel lettore. Insomma, il fatto che questi ultimi due libri non mi avessero troppo convinto mi ha fatto desistere dall'affrontare appunto L'isola del giorno prima oppure Il pendolo di Foucault, libri tra l'altro molto impegnativi anche per numero di pagine. Ad ogni modo, per farla breve, qualche giorno fa mi è capitato in mano il primo di questi due romanzi, che comunque avevo comprato parecchi anni fa, e ho deciso di cominciarlo, complice un’estate che dovrebbe darmi un po' di tempo per leggerlo con la dovuta calma. E devo dire che in realtà le pagine stanno filando via molto lisce, visto che in meno di una settimana sono già arrivato oltre la metà del volume. La storia è ambientata nel XVII secolo e il protagonista è un giovane piemontese che, dopo aver partecipato in gioventù alla Guerra dei trent'anni, si trova suo malgrado inviato in una missione in incognito per conto del cardinal Mazzarino e della Francia, missione che ha a che fare con le navi, il calcolo delle coordinate geografiche e vari altri misteri che non vi sto ora a svelare. Come sempre nei romanzi di Eco c'è un preciso gusto per la storia, per il complotto e per le caratteristiche culturali dei secoli in cui la vicenda è ambientata, con riferimenti a volte molto popolari e a volte estremamente dotti, in un mix sempre molto interessante. Il libro tutto sommato mi sta anche incuriosendo e piacendo, anche se è piuttosto evidente che la forza del romanzo non è paragonabile a quella de Il nome della rosa, sia perché qui il protagonista è molto più scialbo e inconsistente sia di Adso da Melk che di Guglielmo di Baskerville, sia perché manca un vero e proprio mistero da risolvere. Le curiosità geografiche su cui Eco ogni tanto si dilunga non sono certo quelle che ti scaldano il cuore, o meglio non riescono a scaldartelo come invece fa una bella serie di omicidi in un monastero medievale. Insomma, anche se è un po’ presto per trarre conclusioni, mi sembra di aver in mano un libro interessante, ben scritto, ma che riesce ad avere mordente forse solo per chi, come il sottoscritto, è un vero patito di storia e si lascerebbe incantare anche da un noioso documento seicentesco. A me piace abbastanza, ma non so insomma se lo consiglierei anche a un neofita. In ogni caso, se vi ho incuriositi, il libro potete acquistarlo qui.
Basta 1 minuto di Carsten Lekutat: come forse si sarà capito quantomeno dall'introduzione di Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, non sono di per sé un grande ammiratore dei libri di auto-aiuto. Penso che quel tipo di saggistica proponga perlopiù soluzioni semplici a problemi complessi, e sia composta di libri scritti in modo da lusingare il lettore, giocando furbescamente sulle sue debolezze e sui suoi bisogni e promettendo facili panacee. Questo non mi impedisce però, di tanto in tanto, di leggerne comunque qualcuno e di scovare anche a volte delle eccezioni al mio discorso, cioè libri che riescono a essere più belli della media e a suggerire qualche strategia efficace. Devo dire che in questo senso, considerando i libri usciti negli ultimi anni, mi è abbastanza piaciuto Piccole abitudini per grandi cambiamenti, il volume di James Clear (noto anche col suo titolo originale di Atomic Habits) che ha venduto molto bene in tutto il mondo. Quel libro, pur nella sua semplicità, riusciva a cogliere un punto effettivamente importante nel nostro comportamento, il ruolo cioè delle abitudini, che riescono, anche in base a quanto ci dicono vari studi scientifici e forse anche l'esperienza personale di ognuno di noi, a incidere profondamente sul comportamento degli esseri umani. Forse proprio per la buona esperienza avuta con quel libro, questa settimana ho cominciato un volume che, almeno nella presentazione, sembra ricalcare quello stesso stile: si tratta di Basta 1 minuto del tedesco Carsten Lekutat. Ne ho letto già quasi un quarto, però in realtà non ne sono per ora troppo soddisfatto: si torna infatti qui al vecchio stile dei libri di auto-aiuto, a questioni che mi sembrano affrontate in modo un po’ semplicistico e soprattutto con quel vecchio vizio di proporre una soluzione facilissima da ricordare, semplicissima da mettere in pratica e che però dovrebbe avere ricadute enormi. In questo caso si insiste molto, infatti, sul cambiamenti del comportamento, soprattutto dal punto di vista dell'attività fisica e dell'alimentazione, che si potrebbero però implementare in appena un minuto di lavoro. Per quanto anch’io sia d’accordo che un minuto è meglio di zero minuti, e che un po' di ginnastica è meglio di nessuna ginnastica, mi pare comunque una strategia decisamente troppo accondiscendente verso il pubblico perché abbia davvero successo. Comunque il libro lo sto leggendo e ve ne riferirò meglio andando avanti. Intanto, se vi interessa, potete acquistarlo qui.
Quello che ho visto
E ora proseguiamo con gli audiovisivi. Come noterete l’elenco questa settimana è molto variegato: ci sono un film, una serie tv e perfino una lunga intervista.
Extended interview: R.E.M. on songwriting, breaking up and their lifelong friendship (2024): non so se l'ho mai raccontato qui nella newsletter, ma c'è stato un tempo in cui non vivevo solo di storia e di filosofia (oltre che un po' di cinema e di serie tv), ma anche molto e forse soprattutto di musica. Oggi ne ascolto meno di quando ero ragazzo, un po’ perché per dedicarsi con dedizione ai nuovi gruppi serve tempo e impegno e io ne ho sempre meno, un po’ perché col nuovo sistema instaurato con Spotify paradossalmente mi sento meno spinto ad affrontare nuove sfide, a provare nuovi geni e nuovi gruppi. E un po’ penso anche, ma forse è una mia deformazione dovuta all’età, che questo sia un periodo storico di scarsa innovazione musicale, senza nuovi grandi artisti che emergano davvero all’orizzonte. Comunque, come dicevo, c'è stato un tempo in cui vivevo letteralmente di musica e il mio gruppo preferito erano sicuramente i R.E.M. (o gli R.E.M., se volete pronunciarli all’inglese), la band americana che tra gli anni '80 e '90 ha praticamente creato da sola un nuovo genere musicale, il cosiddetto alternative, poi frequentato e alimentato da decine di altre band. Dei R.E.M. possiedo tutti i dischi in originale e ho ascoltato praticamente ogni loro produzione decine e decine di volte, tanto è vero che mi capita sovente di svegliarmi la mattina con in testa una canzone magari minore della band, che da ragazzo non sopportavo e che adesso di colpo, a vent'anni di distanza, mi pare straordinaria. Come forse sapete, però, i R.E.M. si sono sciolti ormai più di 10 anni fa, nel 2011, non a causa di particolari divergenze tra i membri del gruppo ma semplicemente perché ritenevano di aver esaurito la loro funzione e volevano ognuno dedicarsi a progetti di altro tipo. Qualche settimana fa comunque la band è stata introdotta nella Hall of Fame degli autori di canzoni in America e in quell'occasione c'è stata una piccola reunion, con tanto di intervista concessa alla CBS, l’emittente televisiva statunitense. YouTube me l’ha consigliata e l'ho guardata con grande interesse, e quindi la consiglio anche a voi: potete ascoltarla qui. Intanto mi ha stupito rivedere i quattro ragazzi di Athens così invecchiati, ma è anche vero che, a parte Michael Stipe, gli altri non li rivedevo da un po’, e soprattutto era parecchio tempo che non vedevo Bill Berry, lo storico batterista, quello che dovette anche lasciare prematuramente il gruppo a causa di un aneurisma che lo colse durante un concerto (l’ultima volta l’avevo visto in azione nel 1995, quando aveva 37 anni, e adesso l’ho rivisto nel 2024, a 66: un bel salto). Ma al di là degli anni che passano, l'intervista è molto bella almeno per due motivi. Primo, perché si vede che i quattro musicisti, pur nella diversità di caratteri e di stili, sono rimasti sempre affiatati e capaci di stare insieme quando serviva e di allontanarsi quando non serviva più, trovando probabilmente un ottimo equilibrio tra lavoro, ispirazione, amicizia e distanza. Secondo, in quell’occasione i quattro hanno condiviso molto riguardo al loro processo creativo, visto che venivano celebrati proprio per la loro capacità di scrivere canzoni, dimostrandosi allo stesso tempo anche modesti e dotati di grande semplicità. Sembrano persone normalissime, musicisti simili a quelli che potresti trovare in un bar di periferia, eppure sono stati davvero un pezzo importante, forse addirittura il più originale della musica americana per almeno un decennio. Tra l'altro, poco dopo aver visto quell'intervista, YouTube si è accorto che sono un fan dei R.E.M. e mi ha proposto quindi tutta una serie di altri contenuti legati alla band: tra i tanti, vi segnalo anche un concerto datato addirittura 1985 che risale quindi a quarant'anni fa, ma che è straordinario anche per l'esecuzione del gruppo, che in live suonava quasi come quando registrava, nonostante l'estrema difficoltà di certi pezzi. Ad ogni modo, l'intervista della CBS, come detto, la trovate qui.
L’armata delle tenebre (1992), di Sam Raimi, con Bruce Campbell, Embeth Davidtz, Marcus Gilbert: come detto, in lista questa settimana c’è un solo film, tra l'altro piuttosto vecchio visto che ha ormai più di trent’anni, e però non lo avevo ancora mai visto (o almeno non ricordavo di averlo visto). Si tratta de L'armata delle tenebre, terzo capitolo della saga de La casa pensata e diretta da Sam Raimi tra gli anni '80 e '90; regista che negli ultimi anni è diventato famoso anche per aver collaborato a diversi progetti della Marvel, dallo Spider-Man con Tobey Maguire all'ultimo Doctor Strange. L'armata delle tenebre risale al 1993 ed è un film originalissimo perché mescola due generi che di solito non vanno molto d'accordo: da un lato l'horror, a sfondo qui tra l'altro molto macabro, con scheletri che combattono, mostri e ambientazioni medievale, e dall'altro la commedia. Il film lo si potrebbe infatti definire una sorta di horror comico, quasi cartoonesco (un po’ alla Scooby-Doo, per intenderci), col protagonista, Bruce Campbell, che sembra uscito direttamente da un cartone animato. La storia è semplice: Ash, protagonista dei primi due capitoli della saga, a causa del Necronomicon si trova catapultato addirittura nel Medioevo. Per tornare a casa deve provare a recuperare il libro maledetto e magari, con l'occasione, anche salvare gli uomini e le donne del tempo dalla famigerata armata delle tenebre. I combattimenti e scene sono spesso al limite dell'assurdo, ma il protagonista, con la sua ironia e il suo apparente machismo, gode decisamente di un certo fascino e strappa anche un paio di risate. Un film insomma che cerca di far paura senza prendersi troppo sul serio, e forse alla fine riesce anche nell'impresa. Lo trovate su Amazon Prime Video.
Crashing episodi 1.05-1.06 (2016), di Phoebe Waller-Bridge, con Phoebe Waller-Bridge, Louise Ford, Jonathan Bailey: nelle scorse settimane vi ho parlato di Crashing, serie tv britannica di qualche anno fa scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, autrice diventata famosa soprattutto grazie all’irriverente e scanzonato show di nome Fleabag. Crashing è in realtà una miniserie e in effetti l'ho finita proprio in questi giorni, con gli ultimi due episodi che, a dirla tutta, lasciano un po’ l’amaro in bocca: la storia infatti manca di un vero e proprio finale, tanto che ho dovuto rivedere l’ultima scena almeno due volte per assicurarmi di non essermi perso una qualche battuta risolutiva. E invece no: finisce proprio così, molto in sospeso, con sicuramente delle novità importanti che avvengono nell’ultimo episodio ma anche senza un completamento complessivo del discorso. In ogni caso la serie è molto interessante, come ho detto anche la settimana scorsa, anche se forse un po’ acerba: si vede il talento della Waller-Bridge nel creare situazioni irriverenti e originali, così come emerge prepotentemente il gusto per la battuta al fulmicotone che ti fa davvero scoppiare in una risata, ma mancano ancora alcuni dettagli che potrebbero impreziosire del tutto il prodotto, come dei personaggi forse meno prevedibili o, appunto, una qualche risoluzione finale dei conflitti. Ad ogni modo, un esperimento molto interessante e che vi consiglio: la trovate su Netflix (anche se solo in lingua originale con i sottotitoli in italiano).
Quello che ho pensato
Permettetemi oggi di ritornare ulteriormente sulla questione della circolare del ministro Valditara riguardo al divieto di usare i cellulari in classe alle elementari e alle medie. Mi vorrei soffermare, più che sui cellulari in sé, su un aspetto forse secondario ma in realtà abbastanza importante di quella direttiva, su cui in questi giorni ho letto cose piuttosto fantasiose: mi riferisco in particolare al ritorno al diario cartaceo, altra cosa che pare sia stata, parallelamente, resa obbligatoria.
Le motivazioni che ho visto in giro per giustificare questa indicazione a volte sfiorano abbastanza il ridicolo: ho sentito Valditara che, per spiegare questo nuovo obbligo, esaltava l'odore della carta; e ho letto, poi, di un pedagogista che invece insisteva sul fatto che i compiti è meglio scriverli sul diario perché così si scopre la vera relazione con l'insegnante, che è costretto a dettarteli e guardarti in faccia mentre lo fa. Queste motivazioni, francamente, non hanno molto senso; però devo dire che ce ne sono altre che pochi hanno citato e che invece sono più valide e meritevoli di attenzione, tanto da dare abbastanza fondatezza all'idea di quel provvedimento (anche se rimango dubbioso riguardo al metodo dell’imposizione dall’alto, come se gli insegnanti non fossero in grado di pensare da soli o di prendere decisioni autonome). E allora vediamole, queste altre motivazioni.
Primo: sui bambini piccoli, soprattutto delle elementari, penso che il registro elettronico per quanto riguarda i compiti per casa abbia avuto e continui ad avere un effetto de-responsabilizzante. Sapere infatti che i compiti si troveranno scritti – tutti, sempre e comunque – sull’app del cellulare di mamma e papà porta il piccolo, nel giro di poco tempo, a non preoccuparsi di segnarli (anche quando la maestra li scrive alla lavagna), e spesso neppure a ricordarsene. Aver cura delle proprie cose e quindi anche dei compiti da fare, invece, è un segno di crescita e maturazione, tanto che penso che in effetti spingere i piccoli alunni ad annotare da soli quello che c’è da fare sia un passo avanti. Certo, questo comporta anche dei rischi: da genitore ero francamente contento di avere, sottomano, sul cellulare, sempre il quadro delle cose da far fare ai miei figli o da studiare, e averlo chiaro, senza pagine scritte male o esercizi segnati nel giorno sbagliato. Però, di nuovo: questo significava anche, implicitamente, spostare l’onere dell’organizzazione dei compiti dal bambino al genitore (o al responsabile del doposcuola), senza coinvolgere davvero il discente.
Secondo: annotare a mano i compiti, volta per volta, ora per ora, sono convinto che dia al bambino e al ragazzo anche un’idea dell’organizzazione del tempo. Quando scrive i compiti, poniamo, sulla pagina del diario di mercoledì, il giovane studente inizia già a pensare che il pomeriggio prima, martedì, ha magari allenamento, e quindi dovrà in qualche modo organizzarsi, portarsi avanti; quando vede che più materie si accumulano in un solo giorno, allo stesso modo, dovrà cominciare – già di mattina, già a scuola, mentre scrive – a pensare a come suddividere il tempo in modo da arrivare abbastanza preparato all’appuntamento. Tutto questo si può fare anche col registro elettronico, ovviamente, ma viene meno spontaneo e soprattutto lo si fa più tardi. Esempio di vita vissuta (che conta quel che conta, ovviamente, ma vale la pena di riportarlo): io ho passato tutta la mia vita di studente iniziando a studiare e a fare i compiti sempre invariabilmente alle 14 precise, subito dopo mangiato, perché in fondo già mentre mangiavo avevo più o meno in mente quello che avevo da fare, e certi giorni c’era bisogno di cominciar presto; i miei figli, tutti, nonostante da piccoli abbiano anche frequentato (almeno in certi giorni, almeno per qualche anno) un doposcuola che dava i tempi in maniera abbastanza rigida, continuano ad essere tendenzialmente anarchici sull’ora in cui cominciare i compiti. E se alle 14 chiedi loro cos’hanno da fare per il pomeriggio, non sempre lo sanno: crescendo sì, lo imparano, e ti sanno rispondere, ma appunto solo crescendo, e grazie a uno sforzo. Non viene spontaneo. Quanti e quali compiti hanno da fare, di solito, lo scoprono aprendo con calma l’app del cellulare di mamma o papà.
Ah, sempre a questo proposito, un’ultima cosa: uno potrebbe obiettare che in fondo, per tenere a mente quello che c’è da fare per casa, il registro elettronico va anche meglio di quello cartaceo, perché lo puoi consultare in ogni momento. Poniamo ad esempio di essere in bagno e avere un dubbio sui compiti di italiano: basta aprire l’app apposita e verificare, mentre col diario cartaceo dovresti aspettare di aver finito, uscire dal bagno e ricordarti di andare a cercarlo dentro allo zaino. Obiezione sensata, ovviamente. Però da un lato questo ci mostra come tutto sia diventato anche troppo facile, tanto è vero che questa perenne disponibilità d’informazioni, sempre a portata di clic, ci spinge a non fissare nella mente certe cose; dall’altro, utilizzare il cellulare anche come diario ci porta più facilmente a distrarci: se ogni volta che dobbiamo consultare i compiti siamo costretti a prendere in mano lo smartphone e sbloccarlo, allora le distrazioni sono dietro l’angolo. Pensate a quello che accade anche a voi stessi: io, spesso, quando devo consultare un dato sul cellulare, rischio di trovarmi perso altrove, rischio di non aprire solo l’app che intendevo guardare ma anche un’altra (spesso un social network) in cui perdo inutilmente tempo. È anche per questo che pratico una rigida “igiene” dell’uso del cellulare, vietandomi l’apertura di certe app in certi momenti della giornata: ma un ragazzino, ovviamente, questo non è in grado di farlo da solo e costringerlo a usare ulteriormente il cellulare può essere un modo per spingerlo involontariamente a perdersi nei meandri di quell’oggetto.
Quindi non è tanto l’odore della carta – cosa che sa di nostalgico, come tre quarti delle cose che vengono dette sulla scuola – a rendere superiore il diario cartaceo, ma gli effetti che esso può generare (e gli effetti a volte malevoli che invece vengono prodotti dal registro elettronico). Ma ci sono altre due motivazioni che vorrei portare e su cui, appunto, pochi si sono soffermati.
La prima riguarda ancora nello specifico il registro elettronico, che è uno strumento potente ma molto problematico, e sono convinto che costituisca uno dei problemi più significativi della scuola di oggi. Mi riferisco in questo caso non tanto ai compiti per casa, quanto ai voti. Se avete dei figli (e se, come nel mio caso, ne avete quattro, avendo avuto l’onere e l’onore di provare anche diverse tipologie di registro elettronico) sapete bene che il motivo principale per cui si usa questo strumento è controllare perennemente le valutazioni. Il ragazzo le ha sempre lì, davanti agli occhi, con la media già calcolata automaticamente, con la freccia in su se sta migliorando e con la freccia in giù se invece sta peggiorando, con la media complessiva di tutte le materie che ti compare perfino in home page, e poi quella disaggregata che puoi andare a consultare tu, giorno per giorno, ora per ora. Noi insegnanti continuiamo a ripetere, incessantemente: «Non siete un numero», «Non siete un voto»; e poi però – anche visivamente – il registro elettronico mette subito in alto un bel numero, in grande, utile a identificare il tuo percorso scolastico.
Certo, se vado a consultare i miei vecchi diari cartacei giù in cantina ritrovo anche lì, annotati, i vari voti presi nelle diverse materie, ma non ci sono grafici a indicare la media, né complicati calcoli per una media complessiva di tutte le materie (che all’epoca non aveva alcun senso: non c’erano i crediti). E soprattutto l’elenco di voti era in ordine cronologico: se volevo sapere quanto avevo in storia dovevo andarmi a trovare, cercandolo riga per riga, il voto dell’interrogazione di ottobre e poi, più avanti, quello di gennaio, e calcolare a mente (o con la calcolatrice, ma con due soli voti ce la facevo anche a mente) la media. Ci voleva insomma un po’ di tempo, e lo si faceva una volta ogni tanto, solo quando si arrivava in prossimità dell’ultima verifica o degli scrutini. Adesso la media è sempre lì, te la trovi davanti ogni volta che apri l’app, ti insegue. E questo ha sicuramente un effetto su questa generazione, o almeno sui ragazzi un po’ più fragili di questa generazione.
Non solo: i voti ora sono sempre disponibili anche per i genitori. E questo, paradossalmente, è un problema. Lo sappiamo bene noi insegnanti, soprattutto quelli come me che hanno assistito già da docenti al passaggio dal registro cartaceo a quello elettronico. Un tempo, ai colloqui scuola-famiglia o al ricevimento mattutino, ti arrivava il genitore e la prima cosa che dovevi fare era fargli sapere i voti del figlio o della figlia; e non era raro che il genitore non li conoscesse (o non li ricordasse, quantomeno). Molti prendevano anche appunti. Oggi non è più così: generalmente, il genitore ti arriva davanti sapendo già tutto. Non vuole sapere come va suo figlio, lo sa già; e quindi vuole sapere, giustamente, altre cose: come si trova in classe, se socializza, o in certi casi cosa può fare per alzare la media. A volte vuole anche contestare i voti, che appunto conosce per filo e per segno da tempo.
Si badi bene: ci sono genitori e genitori, come ci sono alunni e alunni. Ma come tra gli alunni la costante presenza del voto – evidente, angosciante – nell’home page dell’app può generare ansia e frustrazione, così può farlo anche tra i genitori. Ci sono genitori che la vivono male tanto quanto i figli, che guardano i grafici, che pensano continuamente a come si possa alzare quella benedetta media. Questo non è sempre sano, ovviamente. Il registro elettronico sembra uno strumento utilissimo, perché è trasparente, ci dà informazioni e risolve l’annoso problema dei figli che non riferiscono a casa l’esito delle verifiche (o che mentono, o che saltano scuola falsificando la firma dei genitori sul libretto: tutte cose che una volta si facevano ma che ora sono impossibili – o quasi – da farsi), ma questo eccesso di informazioni può risultare deleterio.
Il ragazzo di venti o trent’anni fa – e qui mi riferisco soprattutto al ragazzo delle superiori, ma il discorso a cascata e con le dovute proporzioni si può fare anche con gli studenti più piccoli – era un ragazzo che in un modo o nell’altro imparava ad arrangiarsi. Che poteva ad esempio rimandare di dire ai genitori di aver preso un’insufficienza, provando a farsi interrogare per rimediare; che poteva ad esempio tener nascosto ai genitori di avere un sacco di compiti nel pomeriggio in cui invece voleva andare a incontrare la fidanzatina, rischiando una brutta interrogazione il giorno dopo (ma assumendosene la piena responsabilità); che aveva da tenere tutto in ordine non giorno per giorno, ma una volta ogni due mesi, quando cioè c’erano i ricevimenti dei professori o c’erano gli scrutini. Insomma, in una parola, lo studente di trent’anni fa era chiamato ad assumersi le sue responsabilità senza avere sempre il fiato sul collo del genitore, che controllava tutto per lui. Certo il genitore prima o poi arrivava, la resa dei conti prima o poi arrivava, e a volte arrivava anche in modo tragico; però prima stava allo studente e solo allo studente mettere le cose a posto.
Si dirà: il registro elettronico è uno strumento, e come tutti gli strumenti non è né buono né cattivo in sé; non va quindi demonizzato. E ok, sarei in linea di principio anche d’accordo; ma ormai ci siamo resi tutti conto, credo, che strumenti nuovi richiedono una nuova educazione. Guardate l’effetto che i social network hanno avuto non solo sui giovani, ma anche su noi adulti. Sono solo strumenti anche loro, ma andrebbero usati cum grano salis, avendo piena consapevolezza dei vantaggi e dei rischi ad essi connessi. Il registro elettronico di vantaggi ne ha tanti, ma porta con sé anche dei grossi problemi.
Concedetemi infine di affrontare un ultimo tema riguardo a tutto questo discorso. Il Ministro e molti osservatori si sono soffermati sul divieto di usare il cellulare in classe, divieto che rischia di essere ridondante (io non credo che nessuno alle elementari usi davvero lo smartphone in aula, perché i bambini non ce l’hanno o non lo portano con sé, mentre alle medie è già di fatto severamente vietato, almeno dalle mie parti). Come ho detto la settimana scorsa, a me non piace troppo l’idea che questa indicazione (per certi versi anche sacrosanta) arrivi dall’alto con la forma impositiva della circolare: mi sarebbe piaciuto un altro metodo, anche più rispettoso dell’intelligenza dei docenti (si pensa che non siano in grado di gestire la classe e le regole interne? Che ci debba pensare per forza Valditara?).
Ma al di là di tutto, forse, se proprio si deve vietare qualcosa con la forma rigida della norma dall’alto, ci sarebbero anche altri bersagli da colpire. Perché il cellulare in classe è quasi sempre dannoso, ne sono convinto (tranne in situazioni di DSA o casi particolari, che comunque bisognerebbe tener presenti); ma è dannoso anche a casa, perfino in mano ai genitori.
Quindi concludo con una provocazione: perché non vietare, a questo punto, anche i gruppi WhatsApp ai genitori? Perché, parliamoci chiaro: uno dei più gravi danni che è stato fatto alla scuola nell’ultimo decennio è anche questo, il fatto cioè che i genitori, fin dalla prima elementare, si riuniscano in chat di gruppo in cui a volte si commentano giorno per giorno i compiti assegnati, i voti dati e tutto quello che avviene in classe.
Questi gruppi WhatsApp a volte sono utili, ovviamente: il caso più evidente è quando un bambino rimane a casa da scuola, malato, e c’è bisogno di sapere cosa si è fatto al mattino in classe, magari anche con qualche immagine della fotocopia che la maestra ha consegnato o del disegno che i bambini hanno dovuto fare. Però a volte a questi vantaggi si accompagnano anche dei bei rischi, e in particolare un aumento dell’ansia e della frustrazione.
Siamo nell’epoca dell’ansia e della performance, lo dicono tutti (e lo dico anche io in Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva, giusto per non dimenticarci di fare un po’ di pubblicità). E quest’ansia attanaglia sempre di più i nostri giovani, a scuola e a casa. Siamo sicuri che questi strumenti non peggiorino le cose? Che gli smartphone, i social e le app di messaggistica non ci rendano ancora più frustrati e ancora più ansiosi?
Quello che ho registrato e pubblicato
Ora è il momento di fare il punto sui nuovi video e sui nuovi podcast che sono usciti questa settimana:
Vita e filosofia di Simone Weil: iniziamo un piccolo percorso alla scoperta di una delle filosofe più originali del Novecento
Corso di logica 16 - Chiarimenti sui quantificatori logici: come funzionano nel dettaglio e che particolarità hanno i quantificatori?
Il principio di associazione di Hume (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
Idee e dati di fatto in Hume (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
Il primo anno di governo fascista (per il podcast “Dentro alla storia”)
Le emozioni di Inside Out e la filosofia parte 1
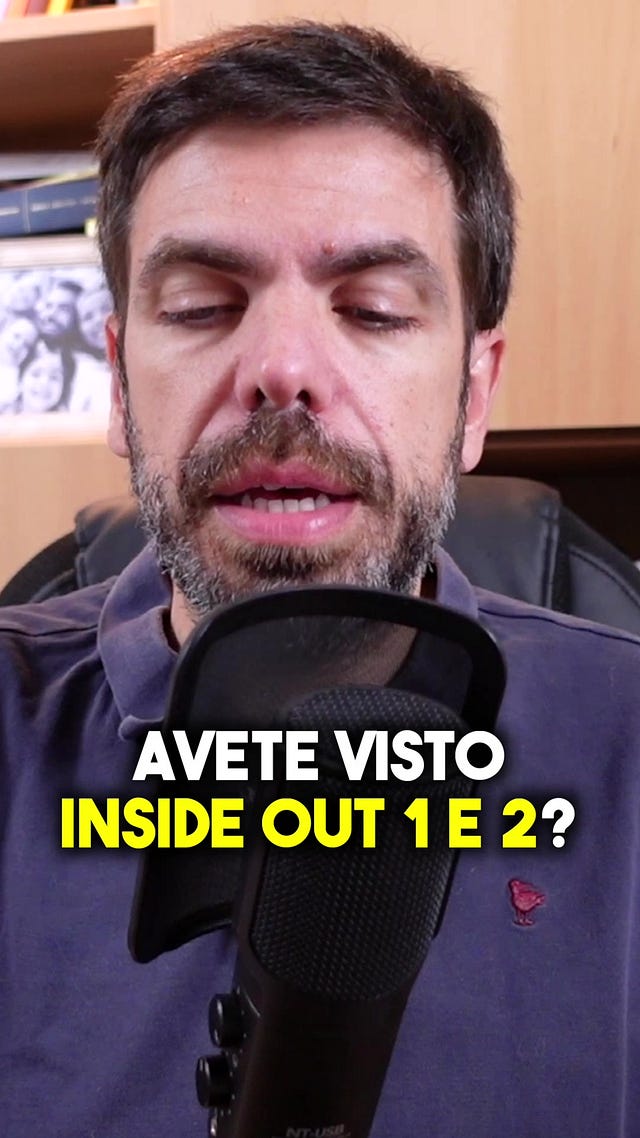 @scrip79La saga di Inside Out ha cercato di dare un volto alle nostre emozioni, mostrandoci anche come sembrano agire. Ma queste emozioni possiamo gestirle? Cosa ci insegna la filosofia al riguardo? Analizziamo insieme i personaggi del primo Inside Out: rabbia, disgusto, gioia, paura e tristezza #filosofia #insideout #pixar #rabbia #disgusto #gioia #paura #tristezza
@scrip79La saga di Inside Out ha cercato di dare un volto alle nostre emozioni, mostrandoci anche come sembrano agire. Ma queste emozioni possiamo gestirle? Cosa ci insegna la filosofia al riguardo? Analizziamo insieme i personaggi del primo Inside Out: rabbia, disgusto, gioia, paura e tristezza #filosofia #insideout #pixar #rabbia #disgusto #gioia #paura #tristezzaTiktok failed to load.
Enable 3rd party cookies or use another browser
Quello che devi fare per seguirmi sui social
Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:
Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads
Quello che puoi fare per sostenere il canale
Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.
Il fascismo eterno di Umberto Eco: ho già parlato di Umberto Eco nelle righe precedenti, ma vale forse la pena di suggerire un suo libro anche per la nostra biblioteca storico-filosofica. E in questo senso mi sembra doveroso partire da uno dei suoi saggi più semplici e agili, ma allo stesso tempo anche interessanti: Il fascismo eterno. Ne ho parlato anche qualche mese fa, perché l’ho riletto da poco: si tratta sostanzialmente della trascrizione di una conferenza, in cui però Eco riesce a delineare alcuni caratteri importanti del fascismo non tanto come formazione politica che dominò in Italia per un ventennio, quanto come “atteggiamento dell’animo”. Il volumetto lo si può acquistare (a meno di 6 euro) qui.
sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):
C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.
Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!
Quello che c’è in arrivo
E chiudiamo anche questa volta con qualche anticipazione riguardo a quello che vorrei pubblicare sui vari canali in questa settimana appena cominciata. Ecco l’elenco:
domani è atteso il podcast storico, con una puntata dedicata all’omicidio Matteotti e alle sue conseguenze;
mercoledì arriverà il secondo video breve su Inside Out, le emozioni e la filosofia: dobbiamo presentare infatti le cinque emozioni del sequel;
giovedì vi proporrò il secondo video su Franz Kafka, in cui inizieremo a confrontare i suoi scritti col pensiero di alcuni filosofi;
venerdì e sabato prossimi torneranno poi di nuovo i podcast, con Hume intento a parlarci del principio di causa-effetto e Mussolini intento a varare le leggi fascistissime;
domenica celebreremo velocemente Karl Popper, nel giorno del suo compleanno;
lunedì prossimo, infine, mi piacerebbe proporvi la seconda puntata della lettura integrale del Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels.
E questo è tutto. Passate una buona settimana, riposatevi e leggete molto. Ci rivediamo qui tra sette giorni esatti, come sempre.