Della divulgazione tramite YouTube, i social network e i libri, ma discutiamo anche di Adolescence, Platone, In the Mood for Love, The Studio, Walter Benjamin, i greci e il Piemonte medievale
Un caro saluto da Praga, cari amici. Sono arrivato nella capitale della Repubblica Ceca oggi nel tardo pomeriggio, dopo un lungo viaggio cominciato all’alba da Rovigo, in corriera, con la mia classe quinta e un’altra classe abbinata, e rimarrò qui in centro Europa fino a venerdì sera, quando rientreremo in Italia.
Questo non toglie, però, che abbia pronta una newsletter, imbastita nei giorni scorsi solo per voi. Ieri e l’altroieri, infatti, ho rivisto quello che un po’ alla volta durante la settimana avevo letto, visto e pensato. Quindi si parte subito, senza indugi (anche perché il tempo stringe: devo controllare che non ci sia casino nei corridoi).
Quello che ho letto
E cominciamo allora dai libri.
Il lessico dei greci di Giulio Guidorizzi: a proposito scuola e studenti, questa settimana ho ripreso in mano un saggio che avevo lasciato da un po’ di tempo sul comodino e che non avevo ancora concluso, nonostante mi fosse piaciuto. Si tratta de Il lessico dei greci, libro che analizza alcune parole chiave della cultura greca, mostrandone in dettaglio il significato, anche grazie a molti riferimenti letterari, da Omero a Platone. Il tono è divulgativo e può secondo me piacere anche a chi non si occupa direttamente di scuola, e men che meno di cultura greca, soprattutto perché è molto chiaro. Insomma, se volete capirne di più di filosofia, ma più in generale del modo di sentire e di vivere degli antichi greci, forse questo è il libro più accessibile che c'è oggi sul mercato. Lo potete acquistare a questo link.
La Repubblica di Platone: la lettura più impegnativa della settimana, però, è stata senza ombra di dubbio La Repubblica di Platone. Come vi ho già raccontato, infatti, questo libro è quello che è stato scelto degli abbonati del canale per il nostro abituale Club di lettura, e sarebbe stato da finire per i primi del mese. Un po' per il fatto che è davvero interessante, e un po' per il fatto che però è anche impegnativo, in realtà il dialogo non l'ho ancora concluso, anche se mi manca pochissimo. E sono fortunato che gli abbonati abbiano deciso di discuterne non prima, ma dopo la mia gita: mi sono infatti portato il libro a Praga e conto di finirlo in questa sera, a patto di non crollare per il sonno dopo un'intera giornata passata in viaggio e a passeggiare per la città. Ovviamente questo libro non è solo complesso, ma, come vi anticipavo, anche molto interessante: leggere un dialogo platonico è sempre un'esperienza unica nel campo della filosofia, ma in più La Repubblica mostra davvero alcuni degli elementi cardine del pensiero occidentale, dallo Stato ideale vagheggiato dal filosofo ateniese fino anche a molti miti che hanno fatto la storia del pensiero. A leggerlo oggi, inoltre, il testo pare anche estremamente chiaro: sarà per via del fatto che Platone voleva qui affrontare una questione concreta e vitale come l'organizzazione dello Stato, ma i suoi ragionamenti sono quasi sempre lineari e facili da seguire, anche in quei casi in cui non appaiono sempre del tutto convincenti. Insomma, è un libro che, prendendosi un po' di tempo, prima o poi tutti gli appassionati di filosofia dovrebbero leggere. Se vi interessa, lo potete acquistare qui.
La via dei lupi di Carlo Grande: vi ho parlato proprio la settimana scorsa anche di La via dei lupi, romanzo per la verità anche breve uscito pochi anni fa e scritto dal giornalista torinese Carlo Grande. Questa settimana sono andato un po' più avanti con la lettura, arrivando già a un quarto del volume. L'ambientazione è tardomedievale, visto che siamo all'inizio del Trecento; ci muoviamo tra l’aristocrazia piemontese del tempo, con le sue caratteristiche peculiari, con tratti effettivamente nobili (a volte coraggiosi, a volte leali) e però anche con tratti molto bassi, molto umani (con uomini a tratti volgari, infingardi e così via). Si respira proprio l'aria di un’atmosfera storica, anche se per la verità finora non è ancora accaduto molto: vedremo. Ve ne parlerò ancora nelle prossime settimane. Intanto, se vi interessa, potete acquistarlo qui.
Quello che ho visto
E passiamo ora ai film e alle serie tv.
In the Mood for Love (2000), di Wong Kar-wai, con Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Ping Lam Siu: nonostante abbia ormai vari anni sulle spalle, e la critica l'abbia esaltato anche a lungo (rendendolo uno dei film orientali più noti in Occidente), non aveva ancora mai visto In the Mood for Love, pellicola di Wong Kar-wai del 2000. L’ho scovata però quasi per caso navigando sui siti di streaming e ho approfittato subito dell'occasione, imbattendomi in una pellicola piccola ma straordinaria. La trama si svolge nella Hong Kong degli anni '60: un uomo e una donna, entrambi sposati ma con i coniugi spesso lontani per questioni di lavoro, si trasferiscono contemporaneamente nello stesso stabile, prima guardandosi da lontano e poi, un po' alla volta, stringendo una vaga amicizia. A un certo punto, però, entrambi iniziano a sospettare che i rispettivi coniugi abbiano tra loro una relazione, e di conseguenza anche l’amicizia dei due protagonisti rischia di trasformarsi in qualcosa di più serio. A questo spunto iniziale, si aggiungono però via via anche le varie circostanze della vita. Il film non presenta nessun moralismo, nessun intento didascalico, ma semplicemente mostra come gli incroci e le piccole scelte quotidiane finiscano per disegnare vite sempre particolari e sempre diverse, che si intrecciano e si separano a volte anche solo per inezie. L'aspetto più bello del film non è infatti, di per sé, la trama, che comunque coinvolge abbastanza bene lo spettatore, quanto la messa in scena: la regia è delicata, piena di ellissi che rendono il film ancora più interessante; in più il procedere nelle vicende è anche accompagnato da un'ottima colonna sonora, scelta con cura e attenzione. Infine è molto ben guidata anche la recitazione degli attori e la scelta delle inquadrature, che spesso si soffermano su dettagli più significativi di quanto ci si aspetterebbe. Insomma, un piccolo capolavoro, senza dubbio. L’ho visto (ma in realtà non so se sia ancora disponibile) su RaiPlay.
Adolescence episodio 1.04 (2025), di Jack Thorne e Stephen Graham, con Stephen Graham, Owen Cooper, Ashley Walters: tutti parlano di Adolescence, alcuni con toni enfatici, altri con grande preoccupazione. Segno, certo, che la serie è molto efficace e non lascia indifferenti, ma anche, temo, delle difficoltà del nostro tempo, quando basta una storia ben fatta per mandare in crisi ogni nostra sicurezza; ovvero: abbiamo davvero bisogno che sia una serie di Netflix a darci un’immagine degli adolescenti (o almeno di certi adolescenti, magari borderline) che abbiamo attorno? E capisco che questa difficoltà ci possa anche essere per chi non vive a stretto contatto coi ragazzini, ma mi sorprende che a lanciare allarmi improvvisi siano insegnanti, psicologi e genitori, che cose del genere – anche se certo rare, perché dobbiamo ricordarci che il caso rappresentato nella serie non è la normalità – dovrebbero più o meno conoscerle. Adolescence, comunque, è molto bella, davvero: mi ha incantato, soprattutto per la forza della resa, degli attori, dei vari piani sequenza imbastiti dai registi. È una storia molto umana, perché ci mostra tutte le nostre fragilità: famiglie che non riescono a comunicare a dovere, ragazzi che non riescono a gestire la loro crescita e la loro emotività, un mondo che non riesce a relazionarsi con le difficoltà di un’intera generazione. Raramente ho visto una serie tanto efficace su Netflix, quindi un plauso a Jack Thorne e Stephen Graham. Da vedere.
The Studio episodio 1.01 (2025), di Seth Rogen e Evan Golberg, con Seth Rogen, Catherine O'Hara, Martin Scorsese: non so bene come funzionino gli accordi tra piattaforme di streaming, ma mi pare evidente che ormai siano troppe per esistere senza incrociarsi. Netflix, Prime Video, Disney+, Apple+, Sky Go, Infinity, TIMVision e via discorrendo: visto che nessuno può sostenere tutti questi abbonamenti, arriverà anche il momento in cui ci verranno offerti a pacchetti, oppure in cui una serie andrà in anteprima su una piattaforma e poi però arriverà, a distanza di qualche settimana, anche sulle altre. Questo mi pare lo si inizi a vedere anche con The Studio, nuova – e molto interessante – serie prodotta da Apple+, il cui episodio pilota è però visibile anche su Prime Video. E visto che io sono abbonato a quest’ultimo servizio ma non al primo, questa settimana ho potuto vedere solo la prima puntata di questa nuova serie, puntata che però si è rivelata, appunto, molto interessante. Tutto ruota attorno al personaggio interpretato da Seth Rogen, produttore cinematografico che viene improvvisamente promosso al vertice della società per cui lavora. Lui, innamorato di cinema d’autore, vorrebbe produrre grandi pellicole, ma dall’alto gli impongono un film iper-commerciale su Kool-Aid, bevanda storica degli Stati Uniti. La serie è dolceamara e ironica, e vi compaiono guest star d’eccezione (nel primo episodio si vedono, tra gli altri, Martin Scorsese, Charlize Theron, Steve Buscemi e Bryan Cranston): insomma, merita un po’ del vostro tempo, soprattutto se poi avete l’abbonamento con Disney+ e il modo di vedere le puntate successive.
Quello che ho pensato
Nelle scorse settimane mi sono trovato più volte a dover parlare di didattica della storia, ma anche di didattica in generale. Come sapete, infatti, è in uscita proprio in queste settimane il nuovo manuale La storia in scena, edito da Garzanti/Deascuola, a cui ho collaborato realizzando video e podcast in gran quantità. Nella fase di promozione di questo manuale, mi è stato chiesto di tenere qualche incontro sia in giro per l'Italia, sia online, e così ho avuto modo di confrontarmi anche con altri insegnanti delle superiori, provenienti da diversi ordini di scuola e da diverse regioni italiane.
Ovviamente da questi confronti sono emerse molte domande, molti spunti e anche molti modi di vedere l'insegnamento. Ma c'è stata una domanda che mi è stata posta sia lì, sia al di fuori di questi tavoli tecnici, una domanda che ogni tanto ritorna e che, secondo me, vale la pena di approfondire. Il quesito è questo: non è che la didattica tramite i video e i podcast rischia di togliere importanza al libro? Non è che rischia di essere in realtà, a lungo termine, inefficace? Non è che rischia, insomma, di instupidire i ragazzi?
È una domanda molto importante, che in realtà non mi è mai stata fatta troppo direttamente, perché devo anche dire che, a onor del vero, i miei video risultano di solito ben apprezzati anche dei grandi cultori dei libri. Però il problema esiste, soprattutto in quest'epoca di social network sempre più veloci e sempre più accattivanti: perché c’è la possibilità che anche la storia e la filosofia finiscano per essere divorate da questa velocità. Le mie due materie, infatti, hanno bisogno di una certa lentezza, di una certa riflessione, di un'analisi approfondita e ponderata… tutti elementi che i social network e i video sembrano non sempre riuscire a dare.
Di queste questioni ho provato a discutere e riflettere proprio assieme alle persone e agli insegnanti che mi offrivano lo spunto, e poi ci ho riflettuto un po' anche per conto mio in questi mesi, visto che io stesso, un tempo, ero dubbioso sulla reale efficacia di questo tipo di divulgazione. Per ora, sono arrivato a queste conclusioni.
In primo luogo, come premessa necessaria, ritengo che dovremmo ben definire cosa intendiamo per divulgazione e cosa intendiamo per social network: ci sono infatti importanti differenze tra un video e l'altro e tra un mezzo di comunicazione e l'altro. Un contenuto su YouTube, come ad esempio quelli che realizzo io, è capace di durare tranquillamente 40, 50 o perfino 60 minuti, ed è estremamente diverso da uno short su TikTok della durata di un paio di minuti scarsi. Tentare di spiegare Kant in un minuto può – se il video è ben fatto – dare uno stimolo, uno spunto, ma nulla più, e certo non può sostituirsi neppure al più scarso dei manuali, mentre spiegarlo tramite sette o otto video di 50 minuti ciascuno può assomigliare molto, nel migliore dei casi, al frequentare una lezione universitaria. E quindi, appunto, bisognerebbe distinguere e non far di tutta l’erba un fascio.
Ma, in secondo luogo, bisogna anche trattare della differenza tra una comunicazione scritta e una invece uditiva e visiva. Non c'è il rischio, mi è stato chiesto, che i nostri studenti, sempre così stimolati dall’immagine, disimparino a stare sui libri, a conquistare lentamente la conoscenza che deriva dalla carta stampata?
Il problema secondo me esiste, è reale, ma non va eccessivamente esagerato. E lo sostengo per due motivi: primo, perché stiamo proponendo, in senso uguale e contrario, una vecchia polemica che risale addirittura ai tempi di Socrate e Platone; secondo, perché secondo me non sono i video divulgativi ad allontanare dal libro, ma casomai questi sono strumenti che almeno in parte cercano di fare il contrario, resistendo all’andazzo di tutta l'intera società. Concedetemi qualche minuto, e proverò ad argomentare e a spiegarvi meglio cosa intendo.
Ricordate cosa dicevamo a suo tempo quando spiegavamo il pensiero di Socrate, anche appunto sui video? Nelle lezioni preliminari (potete recuperarle anche qui, se volete) sottolineavamo che quello che diciamo su Socrate potrebbero non essere del tutto vero o del tutto preciso, principalmente per un motivo: non abbiamo fonti originali scritte dal grande filosofo ateniese. Quel che sappiamo su Socrate, infatti, deriva sempre da altri: da Platone, da Aristofane, da Senofonte e da altri autori a lui contemporanei; ma di cose scritte di suo pugno non ne abbiamo nemmeno una. E la spiegazione non è neppure troppo misteriosa: era lo stesso Socrate che non voleva scrivere.
A spiegarcene il motivo fu in primo luogo Platone, che ad esempio nel famoso Mito di Theuth, contenuto nel Fedro, si lanciava in un elogio dell'oralità vista come superiore alla scrittura. È solo con la parola che si può fare davvero filosofia, è solo con la parola che il discorso procede, si approfondisce, entra nel vivo del dibattito. La parola scritta è morta, la parola detta, invece, è viva. Socrate e Platone, anzi, finivano per lamentarsi sostenendo che, a furia di scrivere i discorsi, si sarebbe perduta la grande cultura greca, la sua forza, la sua originalità. È paradossale che oggi attribuiamo questi rischi alla tendenza esattamente opposta, cioè a un nuovo passaggio dalla cultura scritta a una cultura orale.
Questo a mio avviso ci dovrebbe far capire che, prima di tutto, i “cambi di regime” sono sempre avvenuti: dall'epoca orale si è passati all'epoca della scrittura, con una scrittura che però inizialmente era riservata solo ai dotti; poi perfino la scrittura si è fatta democratica, e anche in quel caso il mondo culturale dell’epoca pullulava di Cassandre che annunciavano la fine della civiltà; ora, da una cultura scritta ampiamente diffusa si sta in parte tornando a forme di oralità, anche se tramite i video e podcast. Forme di oralità che non sappiamo neppure se siano destinate a durare, visto che potrebbero costituire solo una breve moda momentanea. In ogni caso, la voglia di cultura, la voglia di civiltà degli esseri umani ha sempre superato queste fasi di passaggio, ha sempre trovato un modo per esprimersi e svilupparsi anche con mezzi diversi. Non mi starei quindi a strappare i capelli se il video inizia (molto parzialmente) a soppiantare il libro: certo si può perdere qualcosa, ma non è detto che la nostra civiltà non sia in grado di recuperare qualcos’altro in altri modi.
Ma poi, sostenevo che in fondo non siano tanto i video divulgativi a creare tutto questo meccanismo, ma che sia l'evoluzione generale della nostra società a spingere in quella direzione. YouTube non ce lo siamo inventati noi divulgatori, esiste da ben prima che noi iniziassimo a metterci davanti a una videocamera; e anzi noi divulgatori, all'interno di quel grande sito, rappresentiamo più un’eccezione che una regola; per non parlare di TikTok, dove i contenuti culturali sono probabilmente lo 0,1% del totale. Difficile, insomma, imputare a noi la crisi della nostra cultura, che ha iniziato a spingersi verso il visivo e l’uditivo già da più di un secolo, con l’irruzione del cinema, della televisione, della radio, della musica pop, di internet.
Anzi, direi che il lavoro dei divulgatori, sia di quelli più bravi che di quelli più scarsi, in fondo è un tentativo di sfruttare l'efficacia di questi nuovi mezzi di comunicazione, la loro pervasività, per proporre comunque qualcosa di culturale, qualcosa di interessante, qualcosa di diverso da ciò che va per la maggiore. Se togliete quel po' di filosofia, di arte, di letteratura, di storia, di musica classica, di divulgazione scientifico-tecnologica che qua e là si trova in questi mezzi di comunicazione, rimangono solo balletti, gag comiche e ragazzi e ragazze che mostrano compulsivamente la loro bellezza esteriore: il nostro è quindi in fondo un tentativo di salvare il salvabile, forse destinato, perfino, a uno scarso successo.
In più – ed è qui che voglio veramente arrivare – penso anche che lo scopo che noi divulgatori dobbiamo porci sia quello di integrare i nuovi mezzi con i vecchi. Vi sarete accorti, spero, che sotto ad ogni mio video è sempre presente una bibliografia per approfondire. Vi sarete accorti, spero, che alla fine di ogni video o podcast reclamizzo i libri che scrivo o a cui collaboro, perché ho fin da subito cercato di passare dal video alla carta. Vi sarete accorti, spero, che sui miei social network ogni due o tre giorni segnalo un nuovo saggio in uscita in libreria che mi pare degno d'attenzione. Insomma, gli spettatori che catturiamo su YouTube o sui social network visivi cerchiamo (o almeno io cerco), un po' alla volta, di riportarli anche verso un approfondimento, un'analisi ulteriore che passi anche molto tramite i libri.
Noi divulgatori, almeno quelli dell'ambito storico-filosofico, non ci mettiamo in competizione con l'editoria, ma cerchiamo di fare spesso da ponti, da traghettatori da un modo di comunicare all'altro. Se i ragazzi di oggi sono più abituati ai video, non è insomma per colpa nostra; ma noi cerchiamo di usare questa loro abitudine per farli crescere, riportandoli anche al libro.
E in generale, in realtà, è questo quello che secondo me dovrebbe fare una buona divulgazione, ed è questo che un po' manca in Italia. Proprio rispondendo a una domanda del genere, durante una presentazione di Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, ho spiegato che secondo me questo in particolare è uno dei problemi maggiori della nostra offerta culturale odierna: che siamo troppo polarizzati tra l'alta cultura e la mancanza completa di cultura. Che siamo o grandissimi lettori, o gente che non apre un libro da vent’anni; che ci manca, insomma, la via di mezzo. E, per suffragare la mia tesi, ho portato l'esempio di Topolino, la celebre rivista a fumetti con i personaggi disneyani.
Come molti della mia generazione, ho in pratica imparato a leggere con quel settimanale: ricordo benissimo che i miei genitori iniziarono a comprarmelo quando avevo sette anni, e continuarono a comprarmelo per tutti gli anni delle elementari, delle medie e forse anche del liceo, anche se a quel punto probabilmente non lo leggevo più con la stessa fedeltà. E, come me, moltissimi altri bambini compravano una rivista che trenta o quarant’anni fa era assai diffusa e popolare. Perché con Topolino non si imparava solo a leggere: ci si avvicinava anche a un primo barlume di cultura.
Ricordo come se le avessi ancora davanti agli occhi le storie ad esempio della serie della macchina del tempo, quelle avventure in cui Topolino e Pippo, grazie all’aiuto di due scienziati un po' bislacchi, tornavano indietro nel passato, conoscendo grandi personaggi del Rinascimento o dell'età moderna. Quelle storie credo abbiano influito non poco nello stimolarmi un certo amore per la storia, anche perché erano sia accattivanti dal punto di vista narrativo e grafico, sia tutto sommato precise dal punto di vista storico, molto più precise delle normali fiction per adulti della Rai.
Ma ho conosciuto anche fior di professori universitari che mi hanno confessato di aver visto nascere il loro amore per la storia antica, ad esempio, grazie ad Asterix, il loro fumetto preferito quand’erano bambini; o appassionati di cinema d’autore che si sono avvicinati per la prima volta a questo mezzo narrativo solo dopo averne letto delle citazioni sui fumetti della Bonelli come Dylan Dog o Nathan Never.
Il fumetto, insomma, è stato a lungo in Italia un mezzo popolare ma allo stesso tempo, spesso, di elevazione: perché, quando era ben fatto, riusciva a catturare l'attenzione di ragazzini ancora poco istruiti e annoiati, portando almeno una parte di loro, un po’ alla volta, verso uno studio più serio. È questo che dovrebbe fare ancora oggi la buona divulgazione: non convertire tutti in esperti o in grandi studiosi, ma stimolare la voglia di saperne di più, di andare a leggersi qualcos'altro, di non accontentarsi di quello che già si è letto o visto.
Il guaio è che Topolino è in crisi da tempo: si è rinnovato, ha cercato di adattarsi ai tempi, e forse in parte c’è pure riuscito, ma non vende più come allora. Quand’ero bambino io, durante le settimane estive la rivista vendeva 1 milione di copie a numero: il che vuol dire che, considerando che all’epoca quasi tutti avevamo dei fratelli o delle sorelle, praticamente in ogni casa italiana in cui erano presenti dei bambini c’era una copia del settimanale. Oggi leggo che vende attorno alle 50mila copie, un ventesimo di quelle di allora. Il che non è neppure poco, visti i tempi che corrono; ma vi fa anche capire che qualcosa è cambiato, che questi mezzi di divulgazione e intrattenimento popolari sono stati sostituiti da altro, probabilmente dai giochi sui cellulari o dai social network, da Brawl Stars o da TikTok. Ma né Brawl Stars – che sarà anche fatto bene, per carità –, né TikTok ti danno in genere quello che ti dava Topolino.
D’altra parte, TikTok, proprio per come è progettato, rende molto difficile competere coi fumetti d’allora, perché appena vedi un video anche interessante, subito la piattaforma te ne propone un altro, in un vortice infinito di stimoli. Appena trovi uno spunto o una notizia vieni inondato da altri spunti, altre informazioni, e non riesci nemmeno a pensarci o a cercare approfondimenti all’esterno: non ne hai il tempo. Perché lo scopo dei social network non è in realtà quello di divertirti né, men che meno, di farti pensare, ma solo di trattenerti il più a lungo possibile sullo schermo, costringendoti a scrollare compulsivamente fino ad arrivare a qualche pubblicità.
L’unica speranza è che chi realizza i video e i podcast (e tutti gli altri strumenti che abbiamo a disposizione) cerchi di ribellarsi a questo sistema, facendo diventare i vari contenuti dei mezzi per veicolare messaggi di qualità e magari anche culturali, stimolando la voglia di saperne di più. È proprio questo, credo, l'intento che anima me e vari altri divulgatori che operano sulla rete: la voglia di far conoscere ma anche di trasmettere una certa passione per la conoscenza.
Quindi, per farla breve, non credo che di per sé l'uso di mezzi audio e video svilisca la cultura o metta a rischio il valore del libro: la cultura e il libro sono già a rischio di per sé, indipendentemente da quello che facciamo noi divulgatori. Casomai, il nostro lavoro, se ben fatto, può essere un tentativo di metterci una pezza e sperare che magari un qualche colpo da noi assestato possa andare a segno. Su 10.000 persone che guardano un video, magari 10 o 20 saranno spinte ad approfondire, a comprare per la prima volta un libro di storia o di filosofia. E questo sarà comunque un successo, perché 10 o 20 è sempre meglio di 0.
Certo, anche noi divulgatori però dobbiamo stare ben attenti. Perché un rischio, quando si svolge quest’attività, in realtà c'è, ed è anche piuttosto evidente: quello di innamorarci delle nostre parole, di innamorarci dei complimenti che riceviamo e di smettere di essere al servizio dell’appassionato, trasformandoci in guru, in “vati” che dispensano saggezza dall'alto della loro cattedra. Questo sarebbe l'errore: perché implicherebbe smettere di stimolare davvero le persone a pensare con la loro testa e passare a una mera trasmissione di idee preconfezionate che qualcun altro ha pensato per loro. Perché video e audio certo sono efficaci nell'arrivare alle persone, ma presentano anche un effetto che il libro fa più fatica a generare: quello della mitizzazione, o più in generale dell'estremizzazione del valore di chi sta davanti alla telecamera. Agli occhi dello spettatore, una volta che appari in video diventi un mito o un cretino, un genio o un imbecille, senza più vie di mezzo, e anche in questo caso bisogna stare attenti a non farsi travolgere da queste dinamiche.
Perché, nonostante fruiamo di questi strumenti da parecchi decenni, ancora tendiamo a lasciarci incantare da un viso che vediamo alla tv, ancora ci lasciamo imbambolare dai pifferai, e riversiamo sulle persone che parlano su YouTube fin troppe speranze o, al contrario, fin troppe critiche. E allora noi divulgatori ricordiamoci pure di difendere il senso critico, sano e ponderato, di chi ci guarda, anche nei confronti di noi stessi.
Quello che ho registrato e pubblicato
Diamo un’occhiata, ora, a tutto quello che ho pubblicato nei giorni scorsi:
Il Giappone prima della Seconda guerra mondiale: parliamo del paese del Sol Levante e di come si avvicinò alle potenze dell’Asse
Marsilio da Padova: un grande pensatore dell’ultima fase del Medioevo, ingiustamente sottovalutato
L'idea di Stato per i liberali: continua il nostro percorso nella filosofia liberale analizzando la concezione dello Stato
La filosofia di Hutcheson e Mandeville (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
La tragedia dell'8 settembre italiano (per il podcast “Dentro alla storia”)
La guerra partigiana in Italia (per il podcast “Dentro alla storia”)
"Born in the USA" di Bruce Springsteen
Email dall'oltretomba: Simone de Beauvoir scrive al legislatore
Email dall'oltretomba: Adam Smith scrive al Dipartimento del Commercio USA
Quello che devi fare per seguirmi sui social
Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:
Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads
Quello che puoi fare per sostenere il progetto
Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter Benjamin: nel campo dell’estetica, cioè della filosofia dell’arte, questo breve libro di Walter Benjamin è considerato, e giustamente, un capolavoro, un saggio imprescindibile. Noi nel canale YouTube qualche anno fa lo abbiamo letto per intero (trovate qui la playlist), ma, anche per quello che ci siamo detti nella sezione Quello che ho pensato, non posso non consigliarvi anche la versione cartacea, che vale sicuramente la pena leggere. Lo si può comprare qui.
sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):
C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.
Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!
È inoltre da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:
Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:
Quello che c’è in arrivo
E chiudiamo, infine, anche con qualche anticipazione su quello che ho preparato per voi (e che dovrei riuscire a postare da Praga) nei prossimi giorni:
domani, martedì, arriverà un video sull’illuminista francese d’Holbach;
mercoledì e venerdì torneranno i podcast, con una puntata dedicata a introdurre Adam Smith e un’altra ad avviarci verso la conclusione della Seconda guerra mondiale;
giovedì, in mezzo, uscirà invece uno short incentrato su Guglielmo di Ockham;
sabato, appena tornato in Italia, vorrei proporvi poi un video su Cusano, che in effetti sul canale manca;
domenica prossima, se tutto va bene vi convocherò per una diretta aperta a tutti, secondo un nuovo formato che vorrei sperimentare (ma di cui vi dirò di più nei prossimi giorni, sia sui social che su YouTube);
lunedì prossimo, infine, si svolgerà la riunione del Club del Libro dedicata alla Repubblica di Platone.
E questo è tutto. Vado a dormire, ragazzi, o meglio a controllare che i diciottenni e i diciannovenni qui con me non facciano disastri nell’hotel. Ci rivediamo tra sette giorni!




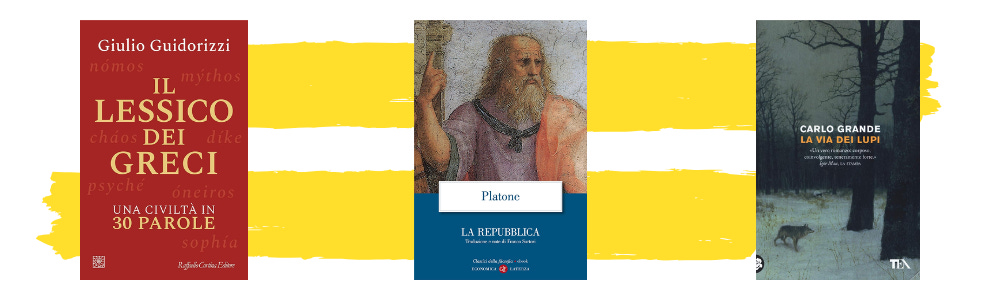

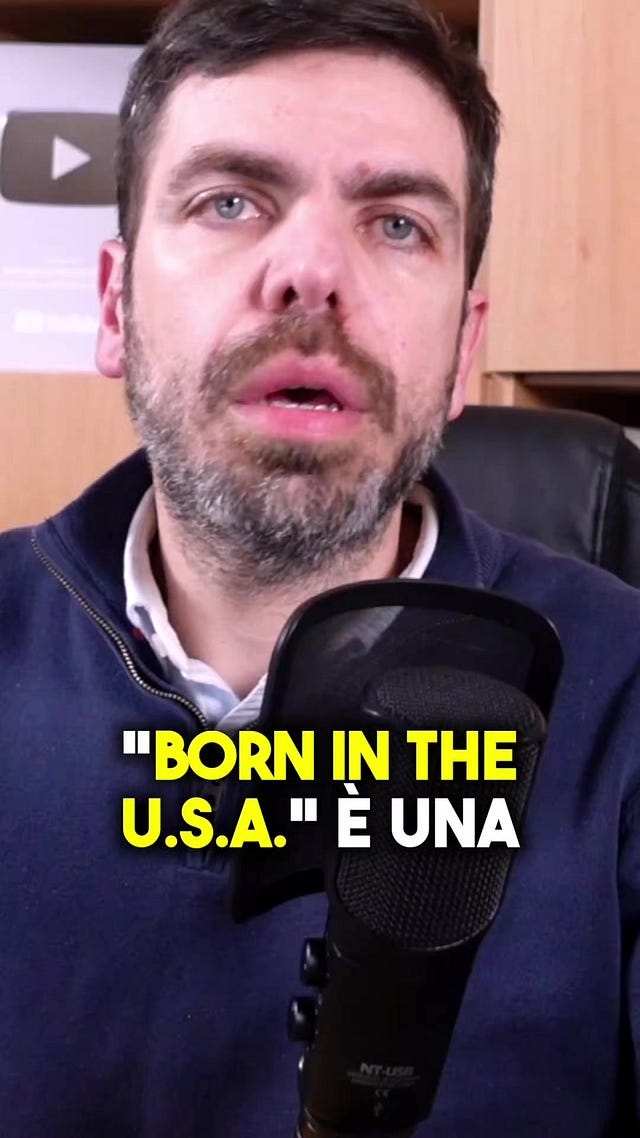





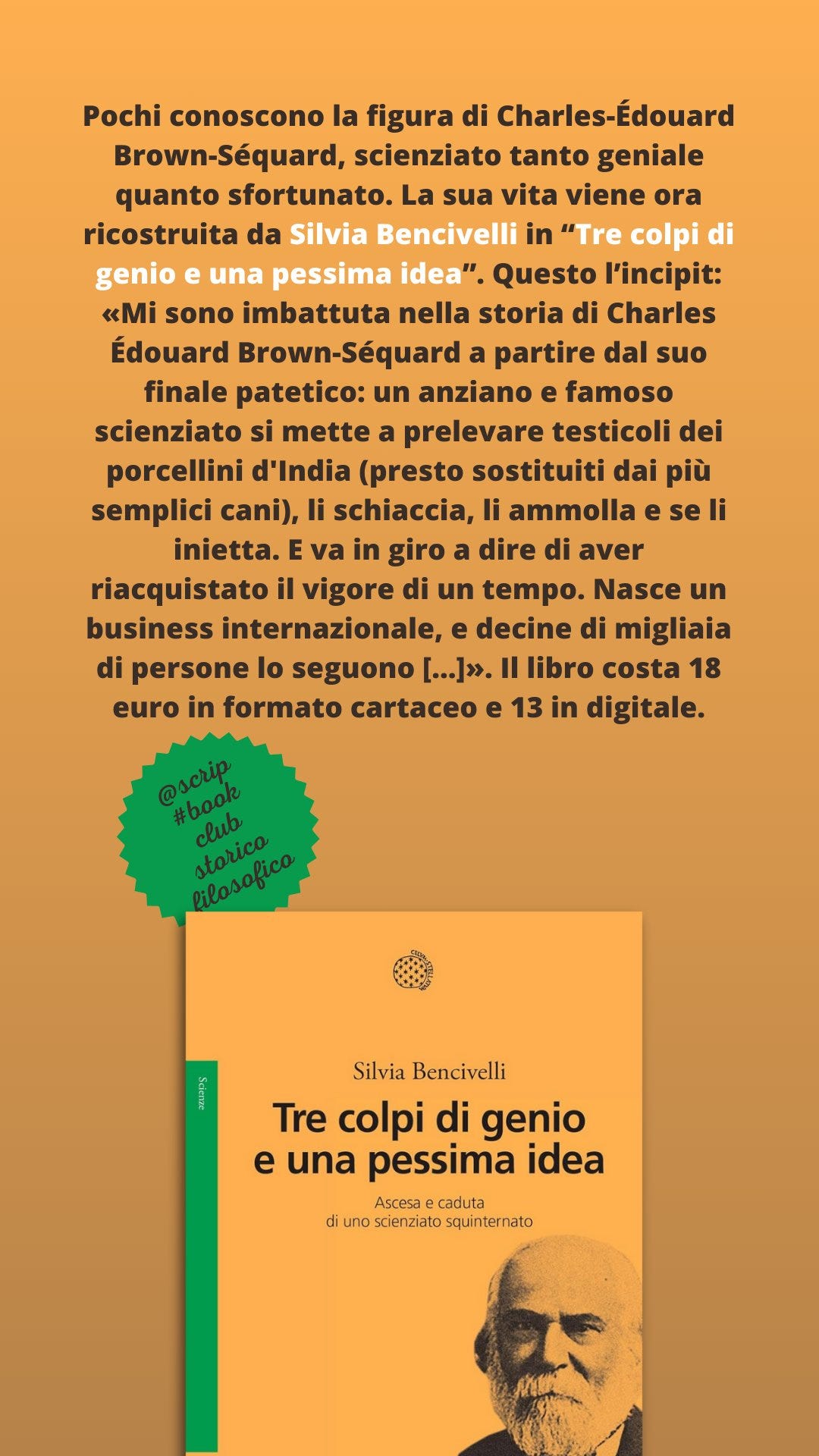
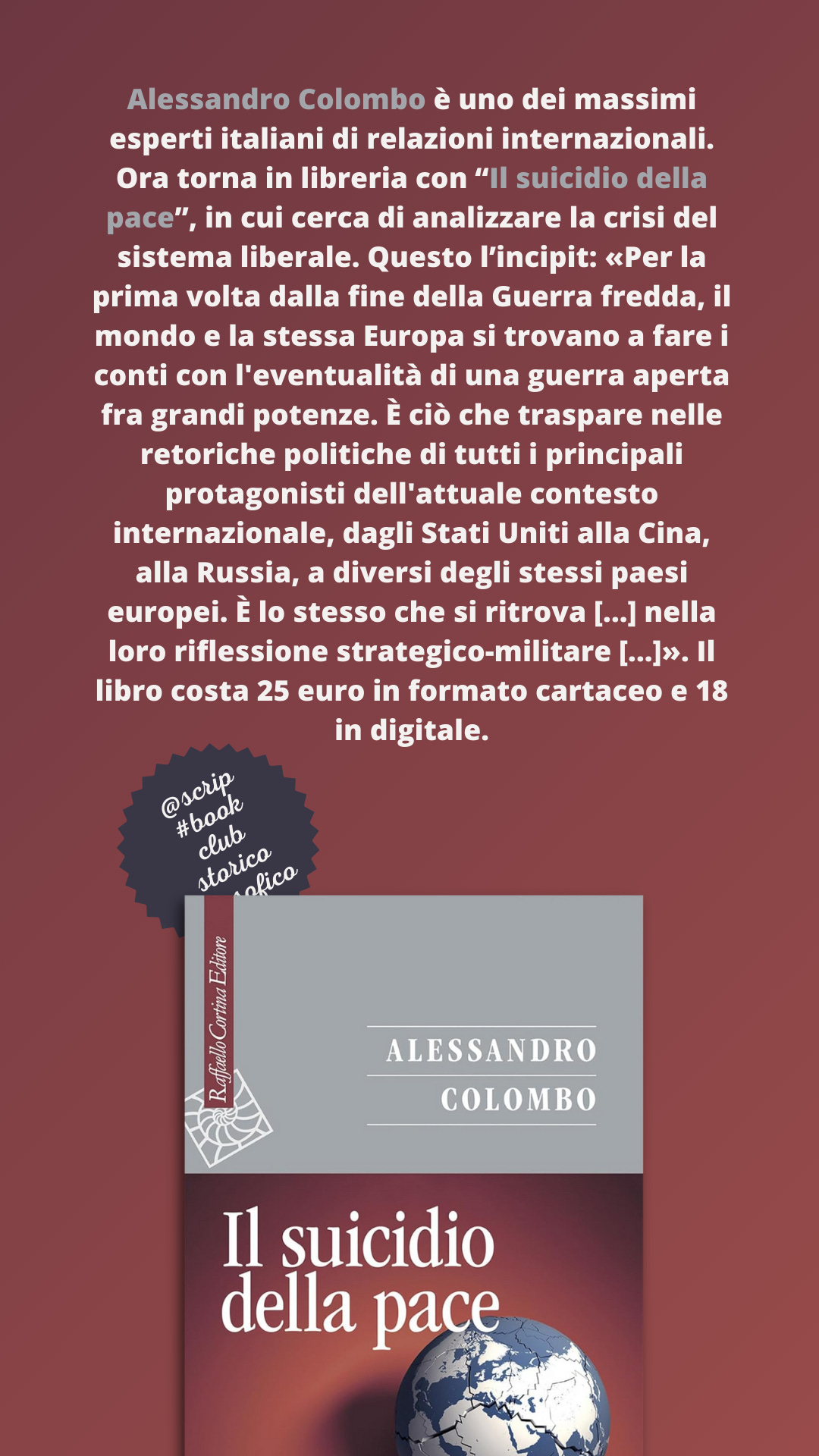
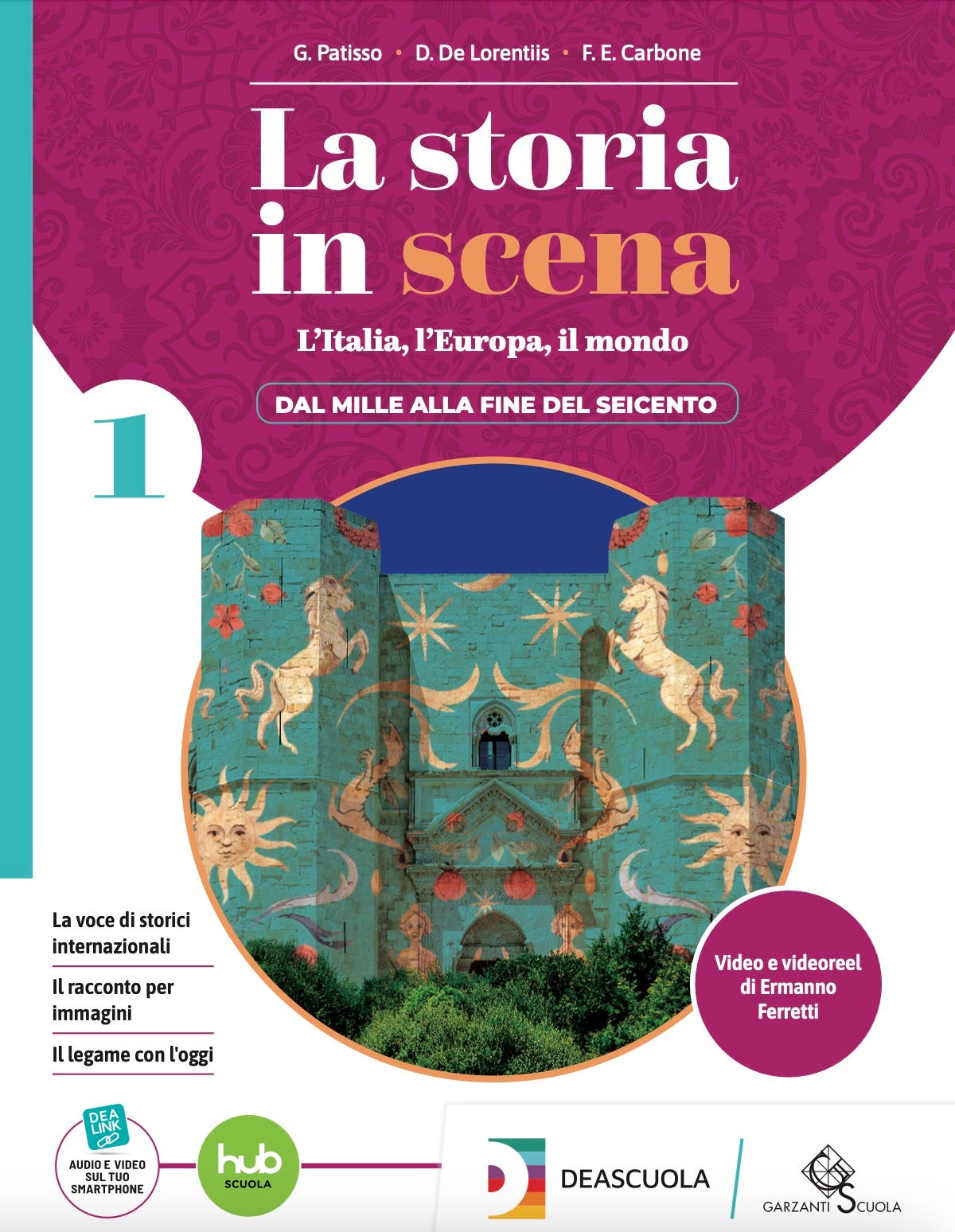
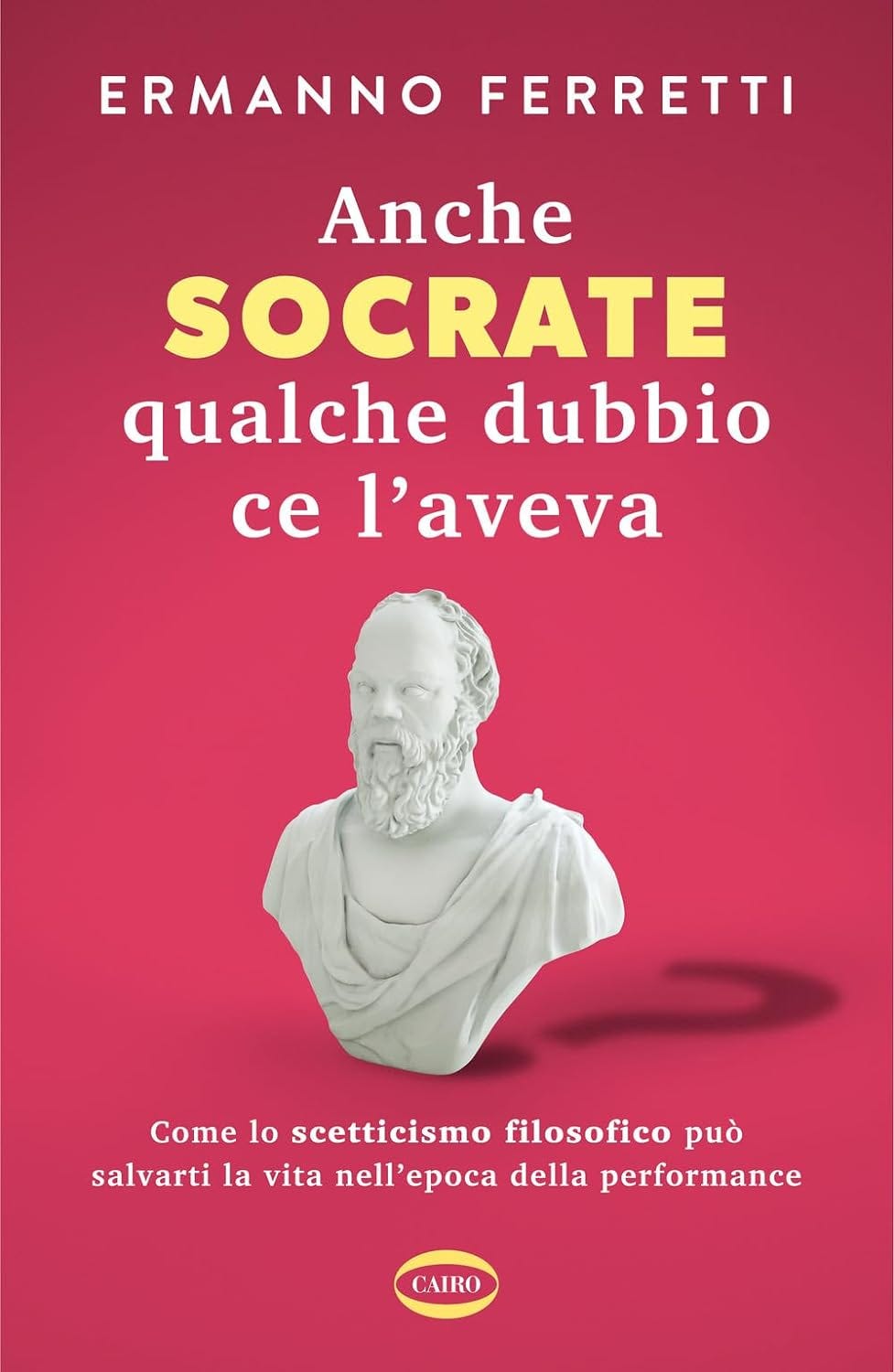
Io mi sono avvicinato alla filosofia grazie a Lei che mi ha dato l’opportunità di ascoltare le sue lezioni. A dire il vero le ho divorate, riascoltate più volte, mi hanno sbloccato la mente e mi hanno aiutato a capire l’importanza di come la storia del pensiero fosse per me fondamentale, aumentata la capacità di analisi e soprattutto mi ha rilevato quanto io sia ignorante. Ho letto il suo libro e ne ho letti altri, apprezzo molto i suoi suggerimenti per la lettura. Questo post è un elogio al suo lavoro ma solo perché è il primo che faccio.
Eh si , prof . Io mi ricordo che la mia lettura piu' difficile e' stata la lettura di 'Topolino' quando , a sei anni , avevo imparato l alfabeto . Un mal di testa , a leggere l intero albo!
Mi ricordo ancora la trama : durante una gita , Topolino , cade in un pozzo che e' una macchina del tempo e torna al tempo degli antichi Celti . Quella e' stata la mia lettura piu impegnativa , poi sono venuti gli scacchi e la Semiotica.