Di cosa abbiamo paura quando parliamo di intelligenza artificiale, ma parliamo anche di Kierkegaard, Mr. Bean, Anatomia di un omicidio, Thomas Hobbes, Memorie di Adriano e Jacob Burckhardt
Siamo arrivati all’ultimo appuntamento di novembre, cari amici: ormai ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e al Natale, e quindi è quasi il momento di fare i conti su come sia andato questo 2024.
Personalmente è stato un anno intenso, forse perfino troppo: mentre il canale continuava inesorabilmente a crescere, ho scritto Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva, ho iniziato la collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi per LibSophia e nelle ultime settimane ho lavorato anche ad altri progetti che presto annunceremo (già domani dovrebbe sbarcarne uno sul web, mentre l’altro ve lo annuncerò tra qualche settimana).
E poi ovviamente ci sono stati tanti viaggi, presentazioni, incontri. Ho contato tutto: solo da luglio ad oggi, sono stato a Roma (due volte), a Genova, a Lignano Sabbiadoro, a Trieste, a Parma, a Verona, a Pisa, a Bologna e in svariate località vicino a Rovigo, sempre per presentare il libro o per parlare di filosofia. E, per non farci mancare niente, sono stato anche a Londra con la famiglia e in Germania con uno scambio culturale. E poi ho fatto sei incontri in teatro o locali, tredici videocall di lavoro, una manciata di videointerviste. Senza contare che tante altre cose sono già in programma per gennaio, febbraio, marzo. Insomma, sono arrivato a fine novembre un po’ col fiatone, a essere sincero, ma sono qui. E per fortuna ci siete anche voi.
Dicembre, per fortuna, dovrebbe essere più tranquillo, un mese da dedicare alla famiglia e alla scrittura, oltre che, come sempre, ai video e ai podcast. Ma proprio a proposito di scrittura, cominciamo con quello che probabilmente vi interessa di più, cioè con le rubriche della nostra solita newsletter. Procediamo.
Quello che ho letto
E allora diamo il via ai nostri soliti discorsi partendo come sempre dai libri.
Memorie di Adriano di Margerite Yourcenar: la settimana scorsa vi avevo raccontato di aver iniziato a leggere Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. A dire la verità, questa settimana non sono stato proprio un lettore modello, perché a questo libro ho dedicato una sola serata: gli altri giorni mi sono concentrato sugli altri volumi dell’elenco, di cui troverete notizia andando avanti. Però quella serata è stata davvero particolare. Giovedì scorso, infatti, sono stato invitato a partecipare qui a Rovigo, nella mia città, a una reading night dedicata ad Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva. Si è trattato di un evento molto speciale: il gruppo di lettura che organizza queste serate, e che si riunisce ogni mese, ha creato infatti un format unico, che consiste sostanzialmente in una serata incentrata sulla lettura condivisa. Gli aderenti si ritrovano in una saletta privata all’interno di un bar del centro e, al suono di una campana, si mettono in rigoroso silenzio, dedicando un’ora intera alla lettura di un libro a propria scelta. Al termine dei 60 minuti, si apre poi una discussione, che questa volta era dedicata proprio al mio libro. È stato un evento particolare, dunque: un’ora di lettura immersiva e un’ora di chiacchierata. Da quanto mi hanno detto i presenti, sembra che sia venuto molto bene. Io personalmente durante quell’ora, com’è ovvio, non ho riletto il mio libro, che conosco già fin troppo bene, ma mi sono dedicato a Memorie di Adriano, che avevo appunto portato con me. Ed è stata un’ora che è volata via, come spesso accade quando ci si immerge nella lettura, senza distrazioni. Il romanzo della Yourcenar, come forse già sapete, è bellissimo, anche se sono ancora agli inizi; ha un fascino particolare perché non solo immagina i pensieri del grande imperatore romano, ma lo fa con quel distacco e quella lucidità che solo l’età può dare. Ve ne parlerò ancora. Intanto, se vi interessa, il libro potete trovarlo qui.
Aut Aut di Søren Kierkegaard: nelle settimane scorse vi ho parlato a lungo di Aut Aut di Søren Kierkegaard, una lettura impegnativa, lunga e, a tratti, persino estenuante. Ebbene, questa settimana sono finalmente riuscito a concludere anche il quinto tomo dell’edizione Laterza. Devo ammettere che la mia è stata una lettura un po’ affrettata, forse persino superficiale, dato che ho sottolineato pochissimo, molto meno di quanto faccia di solito, e sono stato sospinto soprattutto dal desiderio di finire il libro il prima possibile. Però, almeno, il saggio alla fin fine l’ho letto tutto: un traguardo che non ero mai riuscito a raggiungere nei tentativi precedenti. In passato avevo letto infatti solo alcuni brani dell’opera di Kierkegaard, soprattutto per via di un esame in cui avevo dovuto portare Il diario del seduttore, senza però mai completare l’intera opera. Stavolta, invece, ce l’ho fatta, e devo dire che sono piuttosto orgoglioso dell’impresa. È quindi il momento di tirare qualche somma. Cosa si può dire di questo classico della filosofia ottocentesca? Intanto, che è sicuramente un libro intenso, ricco di stimoli e spunti di riflessione. Ma anche che è un’opera diseguale, con parti davvero interessanti e altre francamente noiose. Tra i passaggi più coinvolgenti metterei la lunga lettera del giudice Wilhelm, dove si esaminano i due principali stili di vita presentati nel saggio. Tra quelli meno riusciti, invece, citerei i saggi sul Don Giovanni di Mozart, che, a mio avviso, sono forse evitabili. Un’altra caratteristica di Aut Aut, d’altronde, è la sua estrema ripetitività: anche nei passaggi migliori, Kierkegaard tende a ribadire fino allo sfinimento gli stessi concetti, riformulandoli con parole diverse ma tornando sempre sugli stessi punti. La scrittura, di per sé, non è particolarmente ostica, né i concetti eccessivamente complessi. Anzi, se il testo fosse stato sfoltito e alleggerito, il libro sarebbe risultato sorprendentemente accessibile, soprattutto per un saggio filosofico di due secoli fa. Tuttavia, questa ridondanza mette davvero alla prova la pazienza del lettore: non vi nascondo che, se non fosse stato per la mia volontà di finirlo, probabilmente avrei abbandonato la lettura prima della fine. Ad ogni modo, se anche voi volete cimentarvi in questa impresa, potete acquistare l’edizione Laterza qui.
Insieme ma soli di Sherry Turkle: come avrete ormai notato, la lista dei libri che ho letto questa settimana coincide esattamente con quella della settimana scorsa. A mia difesa posso però dire che sono andata avanti un po' con tutti i titoli e, tra questi, quello a cui ho dedicato più tempo è stato Insieme ma soli, un saggio che esplora le difficoltà e le solitudini della vita online. Il tempo che ho dedicato a questo libro è, in un certo senso, paradossale, soprattutto considerando ciò che scrivevo sette giorni fa: allora mi ero detto un po’ deluso dall’inizio del volume, perché dall’introduzione avevo scoperto che il libro non è proprio recente. E, quando si tratta di temi così attuali e in continua evoluzione, temevo potesse dire poco sui problemi della nostra quotidianità. Invece, andando avanti, mi sto gradualmente ricredendo. È vero che i riferimenti della Turkle non riguardano i social network più recenti, ma le dinamiche legate alla psicologia, al digitale e alla rete sono analizzate in modo sorprendentemente profondo e attuale. Questo saggio sembra insomma meritare almeno una possibilità, perché offre spunti interessanti e riflessioni che possono ancora insegnarci qualcosa. D’altra parte Sherry Turkle, da come scrive, sembra decisamente una che sa il fatto suo, con molte cose da comunicarci. Vedremo come prosegue. Intanto, se vi interessa, potete trovarlo qui.
Quello che ho visto
E passiamo ora ai film, o meglio a un film molto serio e a due serie TV invece decisamente comiche.
Anatomia di un omicidio (1959), di Otto Preminger, con James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara: come forse avrete notato se seguite questa newsletter da un po’ di tempo, ho un debole per i vecchi film, soprattutto quelli in bianco e nero ingiustamente dimenticati. Così questa settimana, quando ho scoperto che Anatomia di un omicidio era disponibile su Amazon Prime Video, mi sono affrettato a rivederlo. Onestamente, non me lo ricordavo più o, forse, non l’avevo proprio mai visto. Si tratta di una pellicola del 1959 diretta dal solido Otto Preminger, un regista austriaco trasferitosi in America negli anni ’30. Ma, soprattutto, è un film significativo per la sfida che lanciò allora alla censura e al perbenismo americani. Anatomia di un omicidio è infatti un dramma giudiziario incentrato sull’omicidio commesso da un soldato statunitense, reduce della Guerra di Corea, nei confronti di un uomo che aveva appena stuprato sua moglie. Negli anni ’50 questi temi venivano raramente affrontati, e tutto ciò che girava attorno alla sfera sessuale era comunque trattato con eufemismi e ipocrisie. Invece Anatomia di un omicidio affronta il tema in modo diretto e senza filtri, parlando esplicitamente di sperma, mutandine strappate e varie forme di violenza, cosa che all’epoca poteva suonare come scandalosa; d’altronde, il film si distingue per il suo stile crudo e diretto, che certamente ebbe un certo impatto sugli spettatori degli anni '50. In questo modo, però, contribuì a far emergere certi temi nella società americana, senza più nascondere la polvere sotto il tappeto. Fa ancora impressione, in ogni caso, vedere come certe colpevolizzazioni della vittima di stupro, che già allora venivano presentate come assurde, si ripropongano ancora oggi, quasi settant’anni dopo, più o meno nella stessa maniera («Com’era vestita sua moglie quando fu stuprata?», «Era sobria o brilla?», «Era provocante?»). È un segnale che i progressi su questi temi sono stati decisamente troppo lenti. Un film saggio, importante e tra l’altro anche molto ben interpretato da tutti gli attori: il protagonista assoluto è il veterano James Stewart, ma sono molto convincenti anche Lee Remick, nella parte della giovane moglie, Ben Gazzara, in quella dell’imputato, George C. Scott, come avvocato dell’accusa, e, soprattutto, Joseph N. Welch nei panni del giudice. Concedetemi una breve nota a margine proprio su Welch: questi non era un attore professionista, e Anatomia di un omicidio fu il suo unico film, che comunque gli fruttò una candidatura ai Golden Globe. Venne scelto per questa parte perché, pochi anni prima, era diventato famoso in tutta l’America per aver tenuto testa al senatore Joseph McCarthy durante una delle udienze della sua famigerata Commissione per le Attività Anti-Americane. Welch, irritato dai toni eccessivi del senatore, lo interruppe in diretta televisiva con la frase: «Non ha proprio nessun senso della decenza, signore?» Quello sfogo contribuì a incrinare la popolarità di McCarthy e a porre fine alla “caccia alle streghe” che stava imperversando negli Stati Uniti. Se il film vi interessa, potete trovarlo su Prime Video.
Mr. Bean episodi 1.01, 1.02 e 1.03 (1990-1991), di Rowan Atkinson, Richard Curtis e Robin Driscoll, con Rowan Atkinson: credo che il personaggio di Mr. Bean non abbia bisogno di presentazioni, sia che siate giovanissimi, sia che abbiate qualche anno in più. È il più celebre personaggio creato da Rowan Atkinson, comico britannico di fama mondiale, ed è stato il protagonista di una fortunata serie televisiva degli anni ’90, serie a cui poi sono seguiti anche un paio di film e persino una serie animata. A ben vedere, gli sketch originali con protagonista questo strambo personaggio non sono moltissimi, eppure sono entrati nell’immaginario collettivo di molti europei, italiani inclusi, tanto che Mr. Bean è ormai un personaggio leggendario. Questa settimana, scorrendo la home page della mia piattaforma di streaming, mi è capitato di vedere lo show tra i suggerimenti, e così l’ho proposto ai miei due figli più piccoli, che conoscevano il cartone animato ma non avevano mai visto le puntate originali dello show televisivo. Insieme ci siamo così guardati i primi tre episodi, autentici classici dei primi anni ’90, con alcuni sketch iconici: quello in cui Bean cerca disperatamente di copiare durante un esame di matematica, quello al ristorante, e quello al cinema con la fidanzata mentre guardano un film horror. In ogni sketch, Bean non è solo un perfetto idiota, ma anche un personaggio fastidioso, invadente, falso, bugiardo e, ovviamente, terribilmente imbranato. Eppure, ridiamo soprattutto dei suoi difetti e delle conseguenze assurde che ne derivano. Rowan Atkinson, poi, ci mette anche molto del suo: la sua mimica è incredibile, e il suo volto così unico rimane impresso immediatamente. Insomma, un mix di scrittura brillante e grande abilità attoriale, che rende queste gag irresistibili anche a distanza di tanti anni. Se avete voglia di rivedere alcuni vecchi ma ancora spassosi episodi, li trovate su Amazon Prime Video.
C’è sempre il sole a Philadelphia episodi 2.02 e 2.03 (2006), di Rob McElhenney, con Charlie Day, Glenn Howerton e Rob McElhenney: sarà capitato sicuramente anche a voi di imbattervi in personaggi – sui giornali, in televisione o sul web – che si lamentano costantemente del politicamente corretto, di una supposta censura ideale, del fatto che oggi “non si possa più dire nulla”. Personalmente, mi sembra che il più delle volte esagerino, anche se magari nelle loro lamentele c’è anche un fondo di verità. È vero, infatti, che in giro si sente a volte l’eco di un moralismo fastidioso, che sembra tarpare le ali a chi voglia esprimere pensieri originali; tuttavia, credo che questa tendenza sia tutto sommato minoritaria e che ci si lamenti molto più di una censura percepita che di una reale. A riprova di quanto dico, possiamo notare che ogni tanto sui principali mezzi di informazione o di intrattenimento compaiono opinioni che rappresentano l’esatto opposto del politicamente corretto: discorsi sgradevoli, provocatori, sicuramente poco educati e non adatti ai benpensanti, che trovano comunque ampio spazio sui nostri mass media. Alcuni di questi sono semplicemente di cattivo gusto, ma, quando sanno usare con intelligenza l’arma dell’ironia, possono risultare anche molto efficaci. A mio avviso, questo è il caso di C’è sempre il sole a Philadelphia, o almeno delle sue prime stagioni. Questa serie, che oggi potete recuperare su Disney+, fece anzi del politicamente scorretto la sua cifra stilistica, affrontando in ogni puntata temi divisivi e controversi, mettendo in scena le situazioni più fastidiose e irriverenti possibili e cercando, soprattutto, di far ridere il pubblico. Questa settimana ho rivisto due vecchi episodi della seconda stagione, il secondo e il terzo, particolarmente cattivi e crudeli, ma proprio per questo anche molto divertenti. Una delle due puntate è dedicata al tema dell’assistenza sociale negli Stati Uniti, con i protagonisti che tentano di mettere in piedi una truffa ai danni del sistema americano; ma l’altra, ancora più forte, tocca lo scabroso tema dell’antisemitismo. L’episodio in questione, intitolato La jihad della gang, fu trasmesso nel 2006, in un’epoca non troppo diversa dalla nostra: quell’anno, ad esempio, c’erano stati intensi scontri tra Israele e Hezbollah, non troppo dissimili da quelli che si stanno verificando oggi nel sud del Libano. E la puntata affronta il tema con una ferocia che colpisce in ogni direzione, come ogni buona satira dovrebbe fare. La trama è semplice: i tre ragazzi protagonisti, proprietari di un pub a Philadelphia, ricevono la visita del nuovo padrone dello stabile in cui ha sede il loro locale, un israeliano appena trasferitosi negli Stati Uniti, che li invita a lasciare l’immobile, dando loro lo sfratto. Seguono, da parte dei tre, commenti infelici, come: «Chi è questo ebreo che vuole cacciarci dalla nostra terra?», a cui l’israeliano risponde sarcasticamente, ricordando che gli americani furono i primi a cacciare i nativi dalle loro terre. Da lì si susseguono eventi assurdi, battute di dubbio gusto, razzismo a go-go in un senso e nell’altro, ma non vi svelo come finisce l’episodio: dovete assolutamente guardarlo. Quello che colpisce è come la puntata riesca a essere feroce verso tutti: i protagonisti – tre idioti patentati – non si limitano ad atteggiamenti antisemiti, ma si mostrano anche razzisti, anti-islamici, stupidi, ignoranti e approfittatori. Insomma, un concentrato di tutti i difetti dell’uomo medio racchiusi nelle loro personalità. Ed è proprio qui che risiede il valore della serie: attraverso questi personaggi grotteschi e orribili, lo show ci permette di ridere di loro e, in fondo, anche di noi stessi, mostrandoci però anche la loro bruttezza interiore. Perché, volenti o nolenti, un po’ di quelle indegnità e ipocrisie appartengono anche a noi. Se siete curiosi, potete recuperarla su Disney+.
Quello che ho pensato
Più leggo articoli e saggi sui computer, l'era dell'informazione e l'intelligenza artificiale, più mi convinco che non stiamo ancora affrontando queste questioni nella giusta prospettiva. O, meglio, mi sembra che siamo talmente intimoriti, seppur inconsciamente, dalle novità che stanno lentamente ma inesorabilmente venendo fuori, che preferiamo concentrarci su alcuni problemi ignorandone altri, forse più rilevanti, e fingendo che non esistano nemmeno.
Il tema centrale, infatti, di molti dibattiti portati avanti anche da eminenti studiosi negli ultimi mesi è che le macchine, per quanto abili nella computazione e nel calcolo, non siano in grado di pensare o provare sentimenti come l’essere umano. Anzi, molti sottolineano come i computer apparentemente intelligenti non facciano altro che imitare il pensiero umano, simulando di fatto la capacità di pensare. Detta in altri termini, le macchine non pensano, ma fanno finta di pensare. Allo stesso modo, si sostiene che non provino sentimenti, ma che siano semplicemente capaci di riprodurre una simulazione di emozioni umane: non amano, non si arrabbiano, non si intristiscono, ma fanno semplicemente finta di amare, arrabbiarsi, intristirsi. Da un certo punto di vista, mi trovo abbastanza d’accordo con questa visione.
Le macchine, infatti, non provano sentimenti, soprattutto perché non hanno un corpo che possa veicolarli. Non possono davvero arrabbiarsi, perché non sentono la rabbia montare nel loro corpo; non possono davvero amare perché non sentono il cuore battere a mille e così via. D’altro canto, non pensano neppure in maniera autonoma: le risposte che forniscono, per quanto possano apparire intelligenti, sono il frutto di calcoli computazionali basati su frequenze statistiche e associazioni di parole. In altri termini, i computer possono fingere di esprimere sentimenti e di ragionare, ma in realtà non capiscono ciò che sostengono e non ne hanno consapevolezza, come già mostrava il celebre esperimento mentale della "stanza cinese" di Searle di cui abbiamo parlato tante volte (se volete una spiegazione, guardate qui).
Dando per scontato tutto questo, però, credo sia il caso di porsi un’altra domanda, che invece sembra trascurata: se è vero che le macchine sono in grado solo di simulare pensieri e sentimenti, qual è la reale differenza con noi? Perché, mi vien da chiedermi: siamo sicuri di funzionare in maniera diversa rispetto alle macchine? Siamo sicuri di provare davvero dei sentimenti? Siamo sicuri di pensare davvero? O non è forse che anche noi ci convinciamo di provare dei sentimenti, ci illudiamo di provare dei sentimenti, e quindi in buona misura fingiamo? Pensiamo o fingiamo di pensare? Se la risposta è scontata nel caso delle macchine, non mi pare così banale nel caso degli esseri umani.
Detta così, la mia potrebbe sembrare una provocazione fine a se stessa, ma cercherò di spiegarmi meglio, pur consapevole del fatto che non sia per nulla semplice. Partiamo dai sentimenti. A volte noi esseri umani ci arrabbiamo, proviamo attrazione fisica, sentiamo invidia e così via. Sappiamo bene che le macchine non possono vivere queste sensazioni, e ciò sembrerebbe implicare una nostra superiorità rispetto alle intelligenze artificiali.
Ma cosa accade davvero quando proviamo un determinato sentimento? Pensiamo alla rabbia: sentiamo il sangue salire alla testa, il cuore battere più velocemente, un’energia strana attraversarci i muscoli. A quel punto, cerchiamo di gestire questa energia, sfogandola in qualche modo o lasciandola svanire dentro di noi. In altre parole, proviamo a razionalizzare e ad adottare un certo comportamento. Ma questa gestione della rabbia è qualcosa che creiamo sul momento, oppure è il frutto di comportamenti acquisiti, di abitudini e sequenze mentali interiorizzate nel corso degli anni?
Anche quella rabbia montante, d’altra parte, non è forse il risultato di reazioni biochimiche, di flussi energetici completamente involontari che attraversano il nostro corpo? A mio avviso, nella gestione di un’emozione come la rabbia c’è ben poco di pensato o deciso tramite la volontà: c’è molta chimica e ci sono molte abitudini, molte reazioni automatiche. La chimica riguarda ovviamente l’essere umano, ma anche gli animali, e persino le piante. E non è impensabile che in futuro si possano replicare simulazioni di impulsi chimici anche nelle macchine.
Se ci riflettiamo, ciò che accade quando ci arrabbiamo non è insomma altro che un riflesso condizionato: interpretiamo una frase come un’offesa, e senza neppure rendercene conto il nostro corpo reagisce con una scarica di adrenalina. Allo stesso modo, non è impossibile pensare che in futuro si possano programmare i computer per interpretare un’offesa e simulare una reazione simile a quella biologica. La reazione emotiva, dunque, sarebbe perfettamente replicabile.
A questo punto potreste obiettare che, mentre l’impulso chimico è comune a tutti gli esseri viventi ed è qualcosa di, in un certo senso, meccanicamente determinato, la razionalizzazione è ciò che contraddistingue l’essere umano e lo rende superiore. Il corpo reagisce in automatico, ma la mente interviene col suo libero arbitrio, pensiamo, e riesce a frenare e scegliere. È questo a renderci umani e a distinguerci dagli automi, sosteniamo. Ma siamo davvero sicuri di reagire sempre in modo razionale? Siamo davvero sicuri di riuscire a decidere qualcosa, davanti agli stimoli? E se, invece, ci comportassimo secondo schemi abitudinari introiettati? Se non scegliessimo, ma applicassimo schemi di reazione mentali già presenti in noi?
La vera domanda da porci, insomma, potrebbe in un certo senso essere questa: noi ci innamoriamo davvero o ci immaginiamo di innamorarci? Ci arrabbiamo davvero o simuliamo di arrabbiarci? Pensiamo davvero o simuliamo di pensare?
Se riflettete, la differenza tra il fare qualcosa e fingere di farla è sottile, quasi impercettibile. I nostri sentimenti sono così ondivaghi, i nostri pensieri così fluttuanti che a volte sembra che non ci appartengano davvero, che li abbracciamo solo temporaneamente per poi lasciarli andare via.
Gli esperti ci ricordano che ChatGPT e i bot simili lavorano associando parole secondo modelli statistici. Ma pochi si accorgono che anche la nostra mente funziona almeno in certi casi in modo simile: parliamo spesso per frasi fatte, per espressioni ricorrenti, combinando blocchi di parole già presenti nella nostra coscienza, senza nemmeno pensarci davvero. Tante volte procediamo col pilota automatico, non creando davvero frasi ma semplicemente associando tra loro elementi preesistenti.
L’intelligenza artificiale è meno intelligente di quanto sembri, su questo sono d’accordo con molti osservatori; ma forse anche noi siamo molto meno intelligenti di quanto ci piaccia credere. Più ci penso, insomma, più mi sembra evidente che non siano tanto le macchine ad assomigliare a noi, quanto noi ad assomigliare alle macchine.
Quante persone agiscono senza pensare, senza avere consapevolezza di ciò che stanno dicendo o facendo? Quanti si convincono di provare sentimenti grazie a frasi fatte che hanno nella testa? Quanti reagiscono quasi sempre d’istinto, rinunciando a usare davvero la propria libertà, trasformandosi in automi prevedibili?
In questo grande sforzo collettivo di dimostrare che le macchine non sono poi così intelligenti, ci stiamo dimenticando una cosa: nemmeno noi lo siamo davvero. Facciamo spesso un pessimo uso della nostra mente, agiamo perlopiù senza pensare, trascinati da schemi e pregiudizi che minano la nostra libertà di pensiero e di azione.
Non dico che le intelligenze artificiali siano la panacea di tutti i mali o che dobbiamo affidare loro la gestione delle nostre società. Per ora, preferisco – come credo tutti voi – che a scegliere siano sempre e solo gli esseri umani. Ma mi chiedo se questa fiducia in noi stessi non sia forse un po’ esagerata, considerando che la stragrande maggioranza di noi è molto meno intelligente di qualsiasi intelligenza artificiale ben progettata.
Se mettiamo il guinzaglio a ChatGPT, forse dovremmo metterne uno anche a noi stessi, ricordandoci che siamo molto meno bravi di quanto vorremmo credere.
Quello che ho registrato e pubblicato
E diamo ora un’occhiata a tutto quello che è uscito sul canale negli ultimi sette giorni:
Tutto Hobbes in 45 minuti: un grande riassunto del pensiero di uno dei più importanti pensatori del Seicento
John Locke: continua il progetto LibSophia, con un video dedicato al padre nobile del liberalismo politico
Quando e dove si sviluppa l'Illuminismo (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
La ragione e l'ottimismo illuministi (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
Verso la Seconda guerra mondiale (per il podcast “Dentro alla storia”)
L'ironia di Voltaire nel Candido
Quello che devi fare per seguirmi sui social
Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:
Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads
Quello che puoi fare per sostenere il progetto
Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.
La civiltà del Rinascimento in Italia di Jacob Burckhardt: La civiltà del Rinascimento in Italia di Burckhardt è un’opera fondamentale per comprendere uno dei periodi d’oro della storia italiana attraverso la sua arte, la sua cultura e la sua società. Pubblicato nel 1860, il saggio ha influenzato tutta la storiografia successiva ed è quindi una lettura imprescindibile per ogni appassionato. Oggi lo si trova in due volumi: il primo può essere comprato qui.
sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):
C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.
Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!
Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:
Quello che c’è in arrivo
Siamo ormai giunti alla fine. Ma cosa ci aspetta in questa settimana appena cominciata? Facciamo il punto su quanto ho programmato per voi:
domani si comincia con il podcast storico e una puntata sul fascismo degli anni '30;
mercoledì vorrei riuscire a proporvi un video della serie Cosa direbbero i filosofi, incentrato sul tema del cambiamento climatico;
giovedì arriverà poi la consueta diretta mensile riservata agli abbonati del canale;
venerdì sarà quindi la volta del podcast filosofico, in cui analizzeremo i pensieri degli illuministi riguardo alla religione;
sabato vi proporrò poi uno short incentrato sulla figura di Woody Allen, visto che ricorrerà il suo compleanno;
domenica infine sarà nuovamente la volta del podcast storico, in cui discuteremo di totalitarismo e fascismo;
lunedì prossimo, infine, vorrei concludere la lettura del Candido di Voltaire, con l’ultimo capitolo della serie.
E questo è quanto. Per gli abbonati, ovviamente, a fine novembre arriveranno i soliti “omaggi”, quindi non perdeteveli. E noi ci vediamo sempre qui tra sette giorni esatti. Ciao!









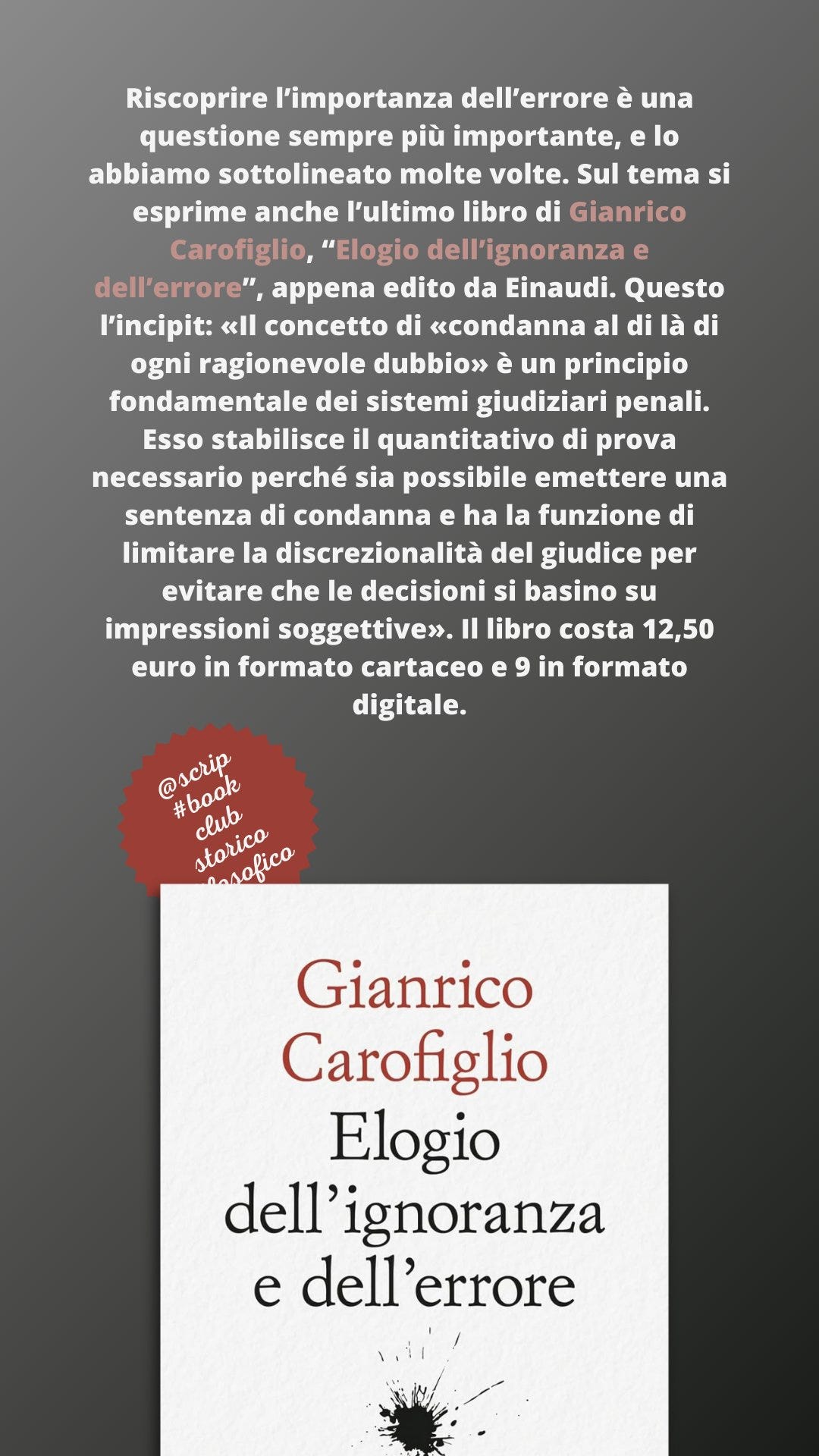


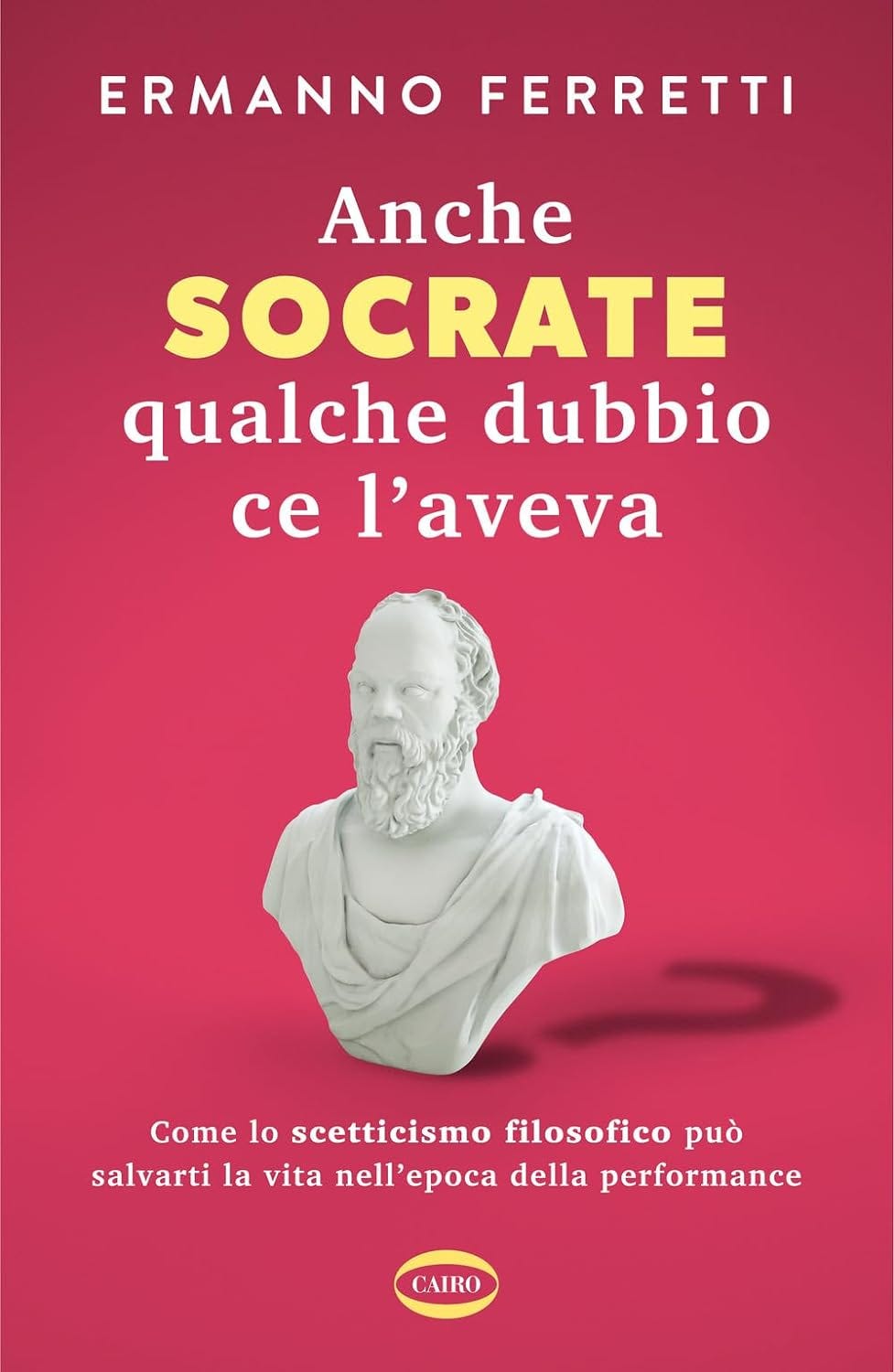
Interessantissimo ed originale il punto di vista sull'intelligenza (artificiale)!