Di ritorno da Londra parliamo di rivolte, Brexit, autonomie e "glocal", ma c'è spazio anche per Kafka, Scorsese, Eco, Schopenhauer, Diabolik, i Monty Python, Bauman e Carolina Invernizio
Eccomi qui, di ritorno da Londra. Sono atterrato a Bologna sabato a tarda sera, dopo sei giorni nella capitale britannica. Ero completamente distrutto, tanto che mi ci è voluta tutta la domenica per riprendere un minimo il ritmo. Oggi però, per la newsletter, siamo pronti a elencare come al solito libri, film e riflessioni varie.
Prima di cominciare, però, due parole su Londra. Alcuni di voi mi hanno chiesto che clima si respirava in questi giorni in cui – come avrete letto sui giornali – la Gran Bretagna è stata messa a ferro e fuoco da gruppi di estrema destra, aizzati contro gli immigrati. Devo dire che nel centro di Londra tutto questo non si sentiva. Certo, c’erano anche lì i giornali che aprivano a tutta pagina sugli scontri e sui razzisti, mostrando estrema preoccupazione; ma credo che il problema riguardasse le città lontane da Londra o la periferia della capitale, non il centro, sempre pieno di turisti, di affaristi e gente aperta al mondo. Londra e il resto dell’Inghilterra sono luoghi molto diversi, come abbiamo visto anche con la Brexit.
Quindi la vacanza è stata tranquilla e piacevole. Anzi, devo dire che è andata anche meglio del previsto. L’ultima volta che ero stato in Gran Bretagna, nel 2014, esattamente dieci anni fa, mi era sembrato di sentire, qua e là, un po’ di ostilità verso gli stranieri: certo, era una cosa molto aneddotica, basata solo su qualche colloquio a caso, ma perfino all’aeroporto i poliziotti erano stati maleducati e ostili. A me era sembrato di percepire una certa insofferenza verso i turisti o gli stranieri. Questa volta, invece, la percezione è stata completamente diversa: gentilezza sempre e comunque, disponibilità, nessun nervosismo. Anche molti italiani residenti, che però facevano finta di non essere italiani (ti accorgevi che sapevano l’italiano solo se captavi qualche conversazione tra loro, ma con te – nonostante noi parlassimo italiano tra di noi – nessuna concessione). Certo, Londra è Londra, come detto: un mondo a parte. Però mi è sembrato un cambiamento interessante.
Per il resto, è stata una vacanza molto culturale: abbiamo visitato tanti musei, visto per la prima volta Stonehenge, trovato un tempo discreto (poca pioggia, freschino, ma assolutamente niente caldo) e ci siamo divertiti. Ormai i musei si visitano soprattutto per Instagram, cosa che da un lato è preoccupante e dall’altro però anche interessante: la gente mira a farsi fare la foto in posa (e ho visto di quelle pose…) vicino ai Girasoli di Van Gogh solo per postare quell’immagine sui social, ma è anche vero che proprio grazie a Instagram (e più ancora a WhatsApp) è più facile portare i ragazzini a visitare musei e magari ad appassionarsi all’arte. I miei figli non sono mai stati interessati come quest’anno a scoprire gli artisti (soprattutto quelli che devono ancora studiare), anche per parlarne con i compagni: il bello è che con WhatsApp si può inviare un’immagine immediatamente dall’altra parte del mondo e scherzarci sopra come se si stesse visitando il museo assieme.
Ora però basta con le chiacchiere: passiamo subito al classico menù della nostra newsletter. Cominciamo.
Quello che ho letto
E partiamo, come sempre, dai libri. In elenco ci sono due romanzi storici molto diversi tra loro e un saggio.
Carolina dei delitti di Lia Celi: era da un po’ che avevo questo romanzo nello scaffale, scritto dalla brava Lia Celi e pubblicato l’anno scorso da Salani. Non so se conoscete Lia Celi, ma probabilmente sì: è una comica e scrittrice che ha mosso i primi passi importanti nella redazione di Cuore, il noto settimanale satirico dei primi anni '90, che con le sue battute fulminanti ci accompagnò nella transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica. Dopo quell’esperienza, ha fatto un po’ di tutto: conduttrice radiofonica e televisiva, scrittrice e narratrice, perfino storica, con saggi di divulgazione molto interessanti scritti anche assieme ad Andrea Santangelo. Carolina dei delitti rientra nel genere del romanzo storico, essendo ambientato nella Torino del 1911, e devo dire che si rivela fin da subito molto godibile. Le protagoniste sono due: Carolina Invernizio e sua sorella Vittorina. La prima è una scrittrice popolare e affermata, realmente esistita, anche se oggi dimenticata: ebbe un grande successo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, soprattutto tra il pubblico femminile che cominciava a leggere e farsi strada. La sua carriera letteraria, nella realtà come nella finzione di questo romanzo, si basava sul racconto di delitti truculenti, storie a tinte forti, e perfino una vaga attrazione verso il paranormale. Sua sorella Vittorina, nel romanzo di Celi, è invece la sua assistente zitella, che cerca di metterla almeno un po’ al riparo dal mondo. Nel romanzo, le due scrivono molto ma, alle soglie dell’Esposizione Universale di Torino, vengono coinvolte in un caso raccapricciante di cronaca: il suicidio (anche questo realmente accaduto) del celebre Emilio Salgari, il 25 aprile 1911. Non vi rivelo altro, perché si tratta di un giallo e le cose vanno scoperte un po’ alla volta; ma già così la faccenda appare intrigante, in un mix di fatti storici e invenzione letteraria. Lo stile è dinamico, leggero e godibile: vi basti sapere che l’ho iniziato e letto tutto in appena una settimana, grazie anche ai due voli in aereo e al fatto che a Londra non mi ero portato lavoro da fare. Se vi interessa, potete acquistarlo qui.
L’isola del giorno prima di Umberto Eco: finito! Dopo tutto sommato pochi giorni, ma davvero intensi, di lettura, ho concluso L’isola del giorno prima, romanzo di Umberto Eco che consta di quasi 500 pagine. Segno che il libro mi è piaciuto, altrimenti non l’avrei divorato con questa foga, considerando anche che altre volte faccio molta più fatica a terminare volumi anche più brevi. E sì, posso confermare che il libro mi è effettivamente piaciuto, anche se faccio fatica a dire quanto e in che modo. In due parole, la trama: siamo nel Seicento, e un giovane del Monferrato, Roberto, fa naufragio trovando riparo su una nave olandese vicina al meridiano del cambio di data. Un po’ alla volta, attraverso flashback e dialoghi con un altro passeggero della nave, scopriamo la sua storia, e soprattutto anche quella del suo gemello immaginario, Ferrante, sul quale Roberto ha fantasticato fin da bambino, creando interi romanzi basati sulle sue avventure. Ecco, la trama la si può riassumere onestamente tutta qua: sulla nave non succede quasi nient’altro (a parte il finale, che ovviamente non vi svelerò). Ma va bene così: il fascino di questo libro non sta in quello che vi avviene (anche se il contesto fa pensare ad avventure piratesche), ma in quello che vi si dice. E di discorsi se ne fanno tantissimi. I più attenti vi troveranno anche riferimenti costanti alla filosofia, alla storia e alla letteratura del Seicento: vi compaiono come personaggi Cyrano de Bergerac, Blaise Pascal, Richelieu, Mazzarino, fior di gesuiti e altri ancora, ma indirettamente vengono spesso tirati in causa anche Galileo, Cartesio, Spinoza, Gassendi, i libertini e altri ancora. Può essere utile e bello leggerlo? Penso di sì, alla fin fine, anche se bisogna essere pronti: è un romanzo da eruditi, non certo d’avventura, che ti insegna tantissimo sul Seicento e racconta poche vicende. Lo potete comprare qui.
Per tutti i gusti di Zygmunt Bauman: in questi giorni ho continuato a leggere Per tutti i gusti di Bauman, di cui vi ho già parlato nelle settimane scorse. Mi sono anzi reso conto che nelle scorse menzioni sono stato forse un po’ troppo severo nella mia analisi, rimproverando a questo libretto di perdersi in parte in polemiche interne al mondo intellettuale, senza andare troppo al cuore delle questioni. Questo rimane in parte vero, ma devo anche correggere il tiro: Bauman è un pensatore importante e, anche quando non si è del tutto d’accordo col suo approccio o la sua tesi, è in grado di dare suggestioni importanti o aprirti a riflessioni a cui non avevi mai pensato. Il guaio di questo libro, semmai, è che mi sembra un po’ disorganico e altalenante: giusto per fare un esempio, ci sono pagine in cui sottolineo righe e righe di parole, e interi capitoli che rimangono intonsi. Comunque, come sempre, tireremo le somme solo alla fine: intanto, se il saggio vi interessa, potete acquistarlo qui.
Quello che ho visto
Per quanto riguarda invece i film, questa settimana voglio parlarvi di un classico che ha appena compiuto quarant’anni (ma è ancora estremamente attuale), di un film italiano recente e di una serie molto british, come si conviene dopo una vacanza a Londra.
Diabolik (2021), dei Manetti Bros, con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea: nonostante la mia giovanile passione, a tratti anche smodata, per i fumetti, non ho mai avuto un gran rapporto con il personaggio di Diabolik. Probabilmente per motivi anagrafici, l'ho sempre sentito legato a una generazione precedente alla mia, e quando ho letto le sue storie non mi hanno mai colpito troppo. Certo, il personaggio ha un fascino tutto suo, anche per quel clima quasi di rievocazione delle spy story degli anni ‘60, ma direi allo stesso tempo che si tratta di un fascino anche un po’ circoscritto, legato a un certo specifico stile. Forse per questo motivo non ho avuto troppa fretta di recuperare il recente adattamento cinematografico dei Manetti Bros, che ha avuto anche un discreto successo visto che sono già stati realizzati due sequel; comunque questa settimana l'ho trovato su RaiPlay e ho deciso di dargli una possibilità. Nonostante le recensioni, a mia memoria, non fossero state a suo tempo particolarmente lusinghiere, il film non mi è affatto dispiaciuto: sia per la precisione nel rievocare quelle atmosfere che caratterizzano così tanto il fumetto, sia per le interpretazioni dei personaggi, soprattutto di quelli di contorno, con Valerio Mastandrea e Miriam Leone particolarmente incisivi. Certo, si tratta ovviamente di puro intrattenimento (ma il discorso vale anche per i fumetti originali), ma è un intrattenimento ben condotto e, mi sembra, onesto. Lo trovate, come detto, su RaiPlay.
Re per una notte (1983), di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Jerry Lewis, Sandra Bernhard: probabilmente avete visto il film Joker, che qualche anno fa ha conquistato sia il pubblico che i critici, ottenendo ottimi risultati al botteghino. I più attenti, però, si accorsero subito che quel film sembrava omaggiare in modo piuttosto esplicito una pellicola di quasi quarant'anni prima, in cui recitava sempre Robert De Niro, anche se in un certo senso a ruoli invertiti. In Joker, infatti, Joaquin Phoenix interpretava lo psicopatico di turno, mentre De Niro vestiva i panni di un affermato presentatore di talk show serale; nel film che ha ispirato il tutto, invece, un ben più giovane De Niro interpretava lo psicopatico, mentre l'affermato conduttore aveva il volto di Jerry Lewis. Sicuramente avrete già capito che sto parlando di Re per una notte, capolavoro del 1983 di Martin Scorsese che, da un certo punto di vista, potrebbe anche essere considerato, a sua volta, una sorta di sequel di Taxi Driver. In quest'ultima pellicola, infatti, la cinepresa di Scorsese seguiva le disavventure di un tassista reduce del Vietnam che faceva fatica a reinserirsi nella vita quotidiana degli americani degli anni '70, finendo per corteggiare una ragazza forse al di sopra delle sue possibilità e compiendo qualcosa di molto stupido e violento per conquistarla. In Taxi Driver, però, l'inquietante Travis Bickle diventava alla fine un eroe davanti a un’opinione pubblica che fraintendeva completamente il senso di ciò che aveva fatto. Non troppo dissimile è la trama di Re per una notte: anche qui abbiamo Robert De Niro, solo un po' più maturo, che interpreta un altro personaggio alienato. La sua aspirazione è quella di sfondare nel mondo dello spettacolo, in particolare come comico, e tende a sognare letteralmente a occhi aperti, facendo molta fatica a distinguere la realtà dalla fantasia. Questo lo porta rapidamente a fissarsi su Jerry Langford, un apprezzatissimo conduttore di un seguito talk show serale, tanto da tormentarlo per ottenere un provino. Davanti all'ennesimo rifiuto di Langford, Rupert, il protagonista, finisce addirittura per rapirlo e ricattare il network televisivo pur di andare in onda, anche solo per una notte. Meno violento di Taxi Driver, ma più sarcastico, il film è una piccola gemma, ottimamente interpretato da De Niro, che non manca di concedersi una virata sulla commedia (nera), e ottimamente diretto anche da Scorsese, molto a suo agio con queste atmosfere inquietanti e vagamente paradossali. Tra l'altro, a rivederlo oggi si nota anche quanto sia stato influente per il cinema successivo: e non mi riferisco solo a Joker, ma anche a centinaia di altre pellicole che gli devono qualcosa. Quando ad esempio si vede Rupert nella sua cameretta intanto a urlare ad una madre che non compare mai sulla scena, non può non venire in mente la serie The Big Bang Theory, in particolare per quello strano rapporto che c'è tra il personaggio di Howard e sua madre. Se vi interessa, il film lo potete recuperare su Disney+.
Monty Python's Flying Circus episodi 2.12 e 3.01 (1970-1972), con Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin: negli ultimi mesi vi ho parlato spesso dei Monty Python, perché, un po’ alla volta, sto recuperando tutte le puntate del loro storico show andato in onda sulla BBC tra la fine degli anni '60 e l’inizio degli anni '70. E ovviamente, dopo questa settimana londinese, non potevo non dedicare di nuovo un po’ di spazio a questa serie comica così innovativa e così profondamente britannica. E ho fatto bene, anzi benissimo: perché tra l’altro sono incappato in due puntate particolarmente riuscite, al limite del capolavoro. La prima di cui vi parlo è la dodicesima della seconda stagione, intitolata Spam. Sì, proprio come la posta indesiderata che vi intasa la casella email. Anzi, forse non lo sapete, ma noi chiamiamo in quel modo la posta proprio a causa dei Monty Python. Cerco di spiegarvi brevemente la faccenda. Spam era una marca di carne in scatola economica che ebbe una certa diffusione in Inghilterra durante la Seconda guerra mondiale. All’interno della puntata che ho appena visto, i Monty Python, nel 1970, prepararono un gustoso sketch in cui due avventori si recano in un locale e chiedono cosa prevede il menù; lo strano gestore inizia a elencare, quindi, diversi piatti, tutti sostanzialmente a base di Spam. Ad esempio dice che si possono ordinare "uova e spam", "uova pancetta e spam", "uova pancetta salsiccia e spam", "spam uova spam spam pancetta e spam", fino a piatti a dir poco paradossali. Lo spam inizia insomma a togliere spazio a tutto il resto, proprio come avviene per la posta elettronica; ed è proprio ricordando questo sketch che, parecchi anni dopo, gli informatici hanno cominciato a chiamare così la posta indesiderata. Questo solo per dire dell’impatto culturale che quella gag e quel programma hanno avuto. Ma le due puntate che ho visto – la 2.13 l’ho saltata perché l’avevo già vista in anticipo, come ricorderanno i più attenti – sono memorabili anche per altre questioni: ad esempio sempre nella 2.12 c’è una gag gustosissima in cui si ritrovano, all’interno di uno studio televisivo, i massimi esponenti dell’ideologia comunista, da Marx a Lenin, da Mao a Che Guevara; ma quando sembra che stia per cominciare un dibattito filosofico-politico, il conduttore inizia a fare domande sul calcio, rivelando che i grandi comunisti stanno partecipando a un gioco a quiz a cui non sanno però rispondere (l’unico che se la cava un po’ è Mao, mentre Marx fa una figura barbina). Nella prima puntata della terza stagione, poi, c’è la gag più divertente che abbia mai visto sulla polizia e sulle violenze ingiustificate di cui evidentemente nei primi anni '70 le forze dell’ordine britanniche erano spesso accusate: non ve la rivelo, perché vi toglierei il gusto della sorpresa, ma guardatela. Senza dimenticare, infine, che la puntata si chiude con una parodia nientemeno che di Jean-Paul Sartre. Divertentissimo. Trovate tutto su Netflix.
Quello che ho pensato
Questa settimana ho avuto modo, per motivi diversi, di riflettere su un paio di cose che in un certo senso sono collegate tra loro, perché derivano da un medesimo problema: da un lato la Brexit nel Regno Unito, dall'altro la questione dell'autonomia differenziata in Italia.
I motivi per cui mi sono imbattuto proprio su questi temi sono, credo, facilmente intuibili: come vi ho già raccontato nell’apertura, ho passato gli ultimi sei giorni a Londra, dove non tornavo da prima della Brexit; nel frattempo ho però anche pubblicato sul canale un video in cui ho cercato di descrivere gli aspetti più importanti della nuova riforma italiana sull'autonomia differenziata. Sembrano argomenti molto diversi, anche geograficamente, ma secondo me derivano entrambi da uno stesso problema di fondo: il difficile equilibrio tra locale e globale, tra identità locale e globalizzazione.
È evidente a tutti che il mondo sta cambiando a una velocità incredibile: le distanze si accorciano ogni giorno di più, le identità personali tendono a mescolarsi e mischiarsi, i punti fermi, anche quelli psicologici e valoriali, sembrano sempre più fragili e pronti a crollare di fronte a nuove sfide. Non mi sto riferendo solo all'economia, che rappresenta solo l’ambito più superficiale della globalizzazione, quanto piuttosto proprio al tema dell’identità: il mondo ci chiede di cambiare costantemente idea su molte cose, e non è raro che ciò che era accettato venti o trent'anni fa oggi finisca per sembrare inaccettabile.
Non credo ci sia mai stato un cambiamento così rapido nella storia, una rivoluzione simile nell’ambito dei valori occidentali. Forse l'ultima volta che abbiamo assistito a un mutamento così veloce è stato quando si è diffuso il cristianesimo all'interno dell'Impero romano, religione che rappresentava qualcosa di estremamente innovativo: si trattava di un nuovo culto che metteva in discussione tutto quello in cui avevi creduto fino a quel momento, che ti diceva che tutto quello che avevi professato come buono fino ad allora era sbagliato e andava sottoposto a una pesante critica. E quale fu l'esito, pertanto, delle prime predicazioni dei cristiani? Contrasti, lotte, persecuzioni. Quando i cristiani riuscirono a imporre i loro nuovi valori, finirono poi, nel giro di poco tempo, per perseguitare a loro volta chi invece voleva rimanere attaccato alle credenze antiche. Fu uno scontro – anche assai violento, in alcune fasi – di culture, di prospettive.
Oggi non siamo davanti a una nuova religione che cerca di sostituirsi a quella vecchia, ma il meccanismo è simile: i valori su cui si è fondata la civiltà occidentale sembrano aver bisogno di una revisione, e quelli che vorrebbero prenderne il posto vengono a volte sostenuti con fare moralista o aggressivo, secondo alcuni perfino fanatico, lasciando poco spazio alla mediazione.
Questo porta a uno stato di costante tensione tra gli individui, che si sentono minacciati nella loro storia, perfino nei propri privilegi, mentre il resto del mondo bussa alla porta in maniera sempre più forte, chiedendo una revisione degli standard, sia morali che economici. Mi rendo conto di star mettendo insieme tante cose che potrebbero sembrare diverse, ma da un certo punto di vista mi pare che questa dinamica sia generale e abbracci tutte queste componenti: dall'identità di genere alle lingue, dalla produzione agricola locale ai rapporti tra Stato e chiesa, dalle tasse al politicamente corretto. In tutti questi temi, c'è una dialettica sempre più forte tra l'antico, il locale, il tradizionale, valori spesso difesi dalla destra politica e, dall'altro lato, il nuovo, il globale, il progresso, a loro volta spesso difesi dalla sinistra.
Questa dinamica si manifesta anche in situazioni che non riguardano direttamente l'oggetto reale del contendere: pensate anche solo al caso della pugile algerina Imane Khelif, che durante le Olimpiadi è stata bersaglio di attacchi feroci da parte della destra mondiale (da ambienti vicini a Putin, da Orbán, Meloni, Salvini, Elon Musk e J.K. Rowling) per una questione che c’entrava poco con lo sport. A nessuno interessava davvero il regolamento della boxe, ma a tutti premeva cavalcare l’onda della fake news secondo cui Khelif fosse in realtà un uomo, agitando quindi lo spettro del transgender, che stuzzica molti politici. Anzi, molti di loro paiono ritenerlo un argomento che può facilmente aizzare le folle. «Dove andremo a finire, signora mia, ora che fanno lottare i maschi con le femmine, che fanno arrivare gli immigrati sui barconi e che nessuno fa più figli o va più a messa?» Questo potrebbe essere lo slogan di molti partiti attuali, e risulterebbe più sincero di altri che ci vengono propinati per mascherare quello che, di fatto, è un razzismo diffuso.
Razzismo che riesce ad emergere perfino nei momenti più lieti: se ieri avete seguito la finale olimpica di pallavolo femminile, stravinta dalle nostre ragazze, forse avrete anche letto dei commenti al limite del disgustoso rilasciati da alcuni personaggi assai discutibili, in primis il nostro nuovo europarlamentare Roberto Vannacci. Gente così poco furba che non capisce nemmeno quando sarebbe meglio, per carità di patria, tacere.
Apparentemente, in questi casi la questione tra locale e globale non c'entra nulla, ma in realtà la radice ultima del problema è sempre quella: c'è una propaganda che spinge sulla paura e il rancore delle persone, convincendole che il mondo, la globalizzazione, i poteri forti o chi volete voi stia lavorando per cancellare ciò che era buono e giusto fino a poco tempo fa. Il mondo sta andando a rotoli, ed è colpa ovviamente di Soros o di altri malvagi deus ex machina che tramano nell’ombra.
A questo proposito, permettetemi una veloce digressione. Paura e rancore sono due tra i sentimenti peggiori di cui si può inondare l’animo umano; e lo sono per due motivi: primo, perché hanno carattere distruttivo; secondo, perché spesso non si basano su fatti. La paura per il futuro – soprattutto quando viene costantemente alimentata – ha un effetto paralizzante, ti blocca, ti fa sentire impotente e ti fa credere di non poter cambiare le sorti della tua vita. Ti fa vivere credendo che una forza sovrumana (Soros, l’ideologia woke, il mondo LGBTQ+… gli esempi sarebbero molti) governi la tua esistenza e la minacci, facendoti sentire impreparato a rispondere e resistere. Il rancore, forse, è ancora peggiore, perché ti fa desiderare solo vendetta, e non certo una risoluzione del problema. Paura e rancore sono sentimenti che caratterizzano la vittima, l’indifeso, lo sfruttato, non chi tiene in mano la propria vita, ma chi la subisce. Inoltre, come dicevo, spesso non hanno neppure troppo fondamento: sono sentimenti che certo possono nascere da fatti concreti, ma che poi si alimentano anche di fantasie. Una persona paurosa e vendicativa non valuta le situazioni con obiettività, ma le ingigantisce; medita progetti di rivalsa credendo che il mondo la prenda di mira, quando in realtà al mondo, di quella persona, probabilmente non interessa proprio nulla. Spinoza e Nietzsche probabilmente direbbero (in modi diversi, ma forse ritrovandosi in linea di massima sulle stesse idee) che quei sentimenti sono negativi e dicono no alla vita: e il politico che li alimenta non fa certo il vostro bene, perché sostanzialmente vi invita all’infelicità perenne.
Dietro a questa propaganda della paura e del rancore, d’altra parte, ci sono sempre più o meno i soliti soggetti: la Russia di Putin, l'estrema destra italiana ed europea, Elon Musk e J.K. Rowling. Sempre gli stessi perché per loro non si tratta di avere un'opinione libera e serena su una questione specifica, ma di condurre una vera e propria campagna, portata avanti con mezzi non convenzionali per mettere in crisi questa spinta verso la globalizzazione, verso il mutamento dei valori, verso “le nuove religioni arrembanti”. Avrete letto, forse, che Musk, davanti ai disordini in Inghilterra – nati sempre dal rancore, tra l’altro alimentato a suon di fake news –, ha perfino evocato la guerra civile; il nuovo premier britannico Keir Starmer gli ha replicato dandogli dell’irresponsabile, ma purtroppo questa è l’agenda di Musk (e di Trump, come abbiamo visto quattro anni fa con l’attacco al Campidoglio): non gli importa se crollano alcune istituzioni, perché tanto così qualcuno potrà danzare sulle macerie.
Ci sono, tra l’altro, molte incongruenze e contraddizioni in queste strategie. Musk ha fatto i soldi grazie alla globalizzazione e opera su mille mercati; J.K. Rowling ha venduto milioni di copie dei suoi libri lavorando su una linea che all’inizio si poteva definire progressista (pur con qualche distinguo); Trump è un capitalista che fa affari in mezzo mondo. Ma queste contraddizioni non devono stupire: al di là di qualche normale cambiamento d’idea, è proprio l’aria a essere cambiata, e Trump, Putin e soci sono persone che fiutano l’aria e cercano di cavalcarla.
Cosa intendo dire? Fino a vent’anni fa, anzi direi prima del 2007, il clima era quello di un generale ottimismo: la globalizzazione sembrava dare buoni frutti, la Cina e l’India (e parliamo di miliardi di persone) uscivano dalla povertà a ritmi velocissimi e i problemi (come il terrorismo, di cui parlavamo costantemente) sembravano affrontabili. Poi è arrivata la sfiducia, soprattutto perché le promesse di quella globalizzazione si sono dimostrate difficili da mantenere, soprattutto in Occidente, dove si partiva già da una posizione di vantaggio. E in quella sfiducia hanno proliferato quelli che puntano a distruggere tutto: muoia Sansone con tutti i Filistei!
In altre parole: se il mondo non ci regala più quello che ci aveva promesso, mandiamo a quel paese il mondo (gli immigrati, le tendenze woke che arrivano dall’estero, tutte le questioni sull’identità di genere che riguardano gruppi che non vogliamo riconoscere come nostri, perfino il femminismo) e richiudiamoci in noi stessi, nelle nostre tranquillità quotidiane. Ritorniamo a quando stavamo bene, a un passato mitico (e in realtà mai davvero esistito) in cui non c’erano tutte queste questioni.
Da qui nasce tutto quel culto per la tradizione che è anche a tratti posticcio. Pensate alle Madonnine esposte e baciate da politici che con la Chiesa non hanno mai avuto nulla a che fare (anzi, che fino a qualche anno fa si vantavano di condurre culti quasi pagani), o all’esaltazione della famiglia tradizionale da parte di chi di famiglie ne ha tre o quattro: non è importante il succo di quello che si sostiene, basta che siano valori tradizionali, visti (o presentati) come un’ancora di salvezza davanti alla deriva del mondo.
Quale equilibrio si può trovare, allora, davanti a queste spinte opposte tra globale e locale, tra nuovo e vecchio? Serve, mi pare, una qualche forma di compromesso, possibilmente al rialzo. E forse la via può essere quella di far sentire protetto chi si sente minacciato, di far sentire ascoltato chi si sente trascurato, di far sentire accompagnato chi si trova lasciato indietro. Impresa non facile, ovviamente, ma che deve coinvolgere soprattutto la politica. Mi verrebbe da dire che serve una politica di rilancio dei servizi rivolti alle classi medio-piccole e umili, tramite una scuola più efficiente e più gratuita, un servizio sanitario potenziato, un sostegno al lavoro più efficace: cose per cui ovviamente servono grandi risorse, che non è mai facile ottenere.
Quali strade sembrano percorribili? Qualcuno dice che si deve tassare i ricchi, e forse ha ragione, perché i divari tra super-ricchi e poveri in questi anni sono aumentati; e d’altronde, Elon Musk vorrà volentieri contribuire a risanare queste ingiustizie, visto che si erge a paladino dei vecchi valori. Il guaio però è che Elon Musk – come tutti i veri super-ricchi – sposta i suoi affari dove ha più convenienza, e non è un caso che in Europa riesca ad attirarli e crescere chi può offrire tasse particolarmente basse. Insomma, lo slogan tax the rich è bello ma, temo, efficace solo fino a un certo punto: qualcosa può fare, ma dubito risolva la situazione.
L’altra strada sarebbe aumentare la progressività delle imposte: far pagare meno a chi ha meno e più a chi ha un po’ di più. Il problema è che in Italia la tassazione è già molto alta, e a risentirne sarebbero quelle classi medie che già adesso sono le più scontente (e incattivite). Non si risolverebbe forse niente, a meno di aumentare in modo molto forte quella progressione, cosa che però avrebbe anche un certo peso politico, in termini di voti e di consenso.
C’è chi dice che una soluzione può essere l’autonomia, tema a cui accennavo all’inizio. E in effetti, in linea di principio, l’idea avrebbe delle frecce al proprio arco: una politica più vicina al cittadino, un uso locale di buona parte delle tasse versate, servizi a portata di mano e con una qualità facile da tenere sotto controllo. Anche qui c’è però un guaio, o meglio un rischio: che questa soluzione funzioni bene al nord, alleviando quel malcontento diffuso, ma molto meno al sud, generando un’Italia che viaggia ancora di più a due velocità, rispetto a quanto già non faccia ora.
Altre soluzioni che mi vengono in mente sarebbero più di carattere culturale. Ad esempio, uno studio della storia più consapevole e maturo, volto a capire che ogni pensiero e ogni tendenza si sviluppa in una data epoca e va contestualizzato in quella epoca storica, e che allo stesso tempo ogni epoca può essere sottoposta a critica sulla base di valori condivisi. Uno studio della storia, insomma, che non serva a fare il processo al passato o al presente, ma a comprendere, anche, ogni tanto, senza giudicare; perché noi tendiamo a giudicare prima di aver capito, quando sarebbe molto più importante invertire l’ordine dei fattori, e capire prima di tutto, e giudicare solo in un secondo momento, e non per forza.
Ci dovrebbe essere un recupero della tradizione, senza esaltarla acriticamente, ma anche capendo che in fondo siamo figli di quella tradizione; e allo stesso tempo un’educazione e un’apertura al domani che dovrebbe essere portata avanti a tutti i livelli, a scuola, nella società, nella televisione, negli uffici. Siamo un paese in cui il nuovo spaventa: negli uffici pubblici e perfino nella scuola si tende a reagire con paura a ogni innovazione, perfino quelle tecniche, formali, quando il dinamismo (saggio) dovrebbe essere una delle tipicità del nostro paese.
E però mi fermo qui, sia perché la sto facendo troppo lunga, sia perché mi rendo conto che tutte queste soluzioni sono, in ultima istanza, assai difficili da realizzare. D’altronde, da dieci anni viviamo in questa perenne tensione, in questa faida continua tra vecchio e nuovo, e se nessuno ha risolto questo problema è perché è ben difficile da risolvere. Certo, c’è poi chi ci marcia sopra e ci costruisce intere carriere politiche o professionali; e a quelli dovremmo rivolgere meno attenzione, perché sono persone che scommettono sulla rovina: ne abbiamo già avute in passato, di persone così, ed è meglio perderle che trovarle.
Quello che ho registrato e pubblicato
Diamo un’occhiata anche ai video e ai podcast che ho pubblicato questa settimana:
Cos'è l'autonomia differenziata: cerchiamo di chiarire i termini di una delle questioni politiche più calde dell’ultimo periodo in Italia
Kafka e i filosofi di inizio Novecento: terzo (ma non ultimo) video dedicato alla filosofia in rapporto alla letteratura di Franz Kafka
Il Manifesto del Partito Comunista - audiolibro spiegato parte 3: ci avviamo verso la fine del capolavoro di Marx e Engels
La morale per David Hume (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
Gli Stati Uniti degli anni '20 (per il podcast “Dentro alla storia”)
Gli Stati Uniti prima del crollo del 1929 (per il podcast “Dentro alla storia”)
Horkheimer, Adorno e l'epoca della performance
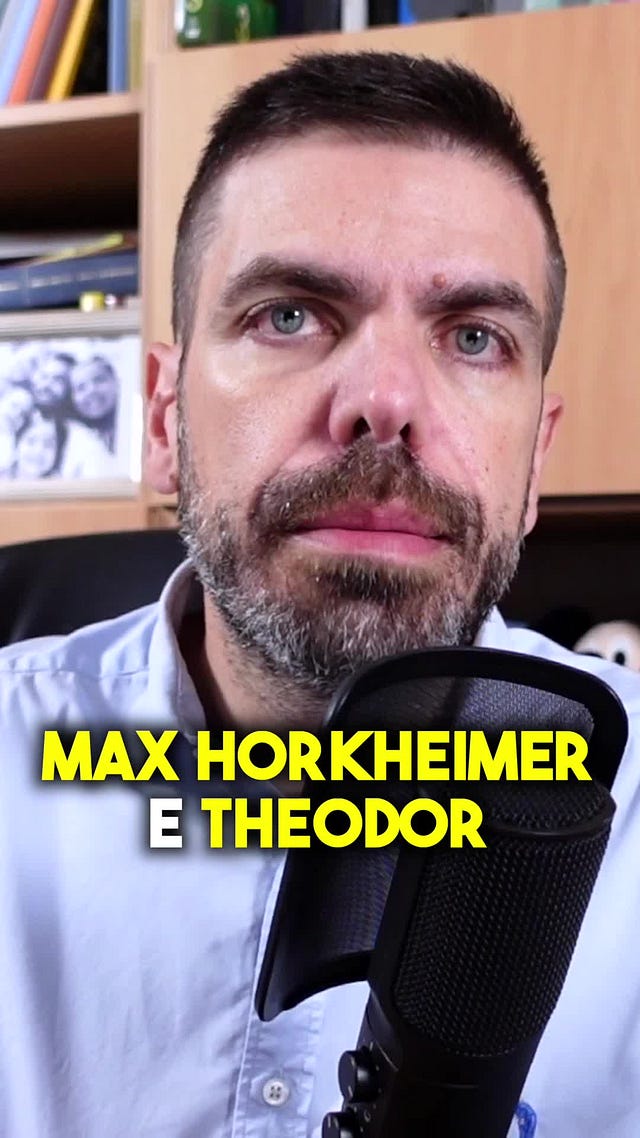 @scrip79In "Dialettica dell'illuminismo", i filosofi tedeschi Max Horkheimer e Theodor Adorno presentarono la loro visione del lavoro nella società contemporanea, un lavoro privo di spazio per il piacere. Ma esiste un modo per affrontare tutto ciò? #filosofia #horkheimer #adorno #DialetticaDellIlluminismo #performance #AncheSocrateQualcheDubbioCeLAveva #ScuolaDiFrancoforte
@scrip79In "Dialettica dell'illuminismo", i filosofi tedeschi Max Horkheimer e Theodor Adorno presentarono la loro visione del lavoro nella società contemporanea, un lavoro privo di spazio per il piacere. Ma esiste un modo per affrontare tutto ciò? #filosofia #horkheimer #adorno #DialetticaDellIlluminismo #performance #AncheSocrateQualcheDubbioCeLAveva #ScuolaDiFrancoforteTiktok failed to load.
Enable 3rd party cookies or use another browser
Quello che devi fare per seguirmi sui social
Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:
Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads
Quello che puoi fare per sostenere il progetto
Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.
Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer: quando si studia la storia della filosofia e si arriva al pensiero di Arthur Schopenhauer, ci si rende facilmente conto di quanto questo filosofo tedesco sia stato innovativo. Con lui si apre decisamente una fase nuova, con un’apertura all’irrazionale che prima tutti i filosofi avevano evitato di compiere davvero. In questo senso, la sua opera più importante (anche se complessa) è sicuramente Il mondo come volontà e rappresentazione, libro che non potevamo non consigliare prima o poi anche qui, come parte integrante della biblioteca di qualsiasi appassionato. Come detto, non è un libro semplice, ma vale davvero la pena di affrontarlo. Tra l’altro, lo si può acquistare a pochissimi euro qui.
sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):
C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.
Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!
Quello che c’è in arrivo
Chiudiamo con qualche anticipazione su quello che dovrebbe uscire la prossima settimana, tenendo presente però che a Ferragosto anche il canale farà festa e quindi non arriverà nulla:
domani è previsto l’incontro del Club del Libro riservato agli abbonati del canale: discuteremo de Il signore delle mosche di William Golding;
mercoledì, dopo una lunga assenza, tornerà la serie dedicata alla storia dei consumi, con una puntata sull’Asia e il consumismo in Giappone, Cina e India;
giovedì sarà appunto Ferragosto, quindi faremo vacanza;
venerdì e domenica usciranno i podcast, con una puntata ancora su Hume per terminare la sua morale e un’altra invece sullo scoppio della crisi del 1929 negli Stati Uniti;
sabato, a inframezzare i due podcast, ci sarà un video breve (uno short) addirittura su Robert De Niro (e vedendolo capirete perché);
lunedì prossimo, infine, potrebbe arrivare l’ultimo video su Kafka, anche se è tutto da decidere perché potrebbe esserci anche il Simposio filosofico.
E questo è tutto per questa intensa settimana. Passate un buon Ferragosto con le persone a cui volete bene, create qualche bel ricordo (che è sempre la cosa più importante) e poi non mancate di tornare qui tra sette giorni esatti per la nuova newsletter. Ciao!







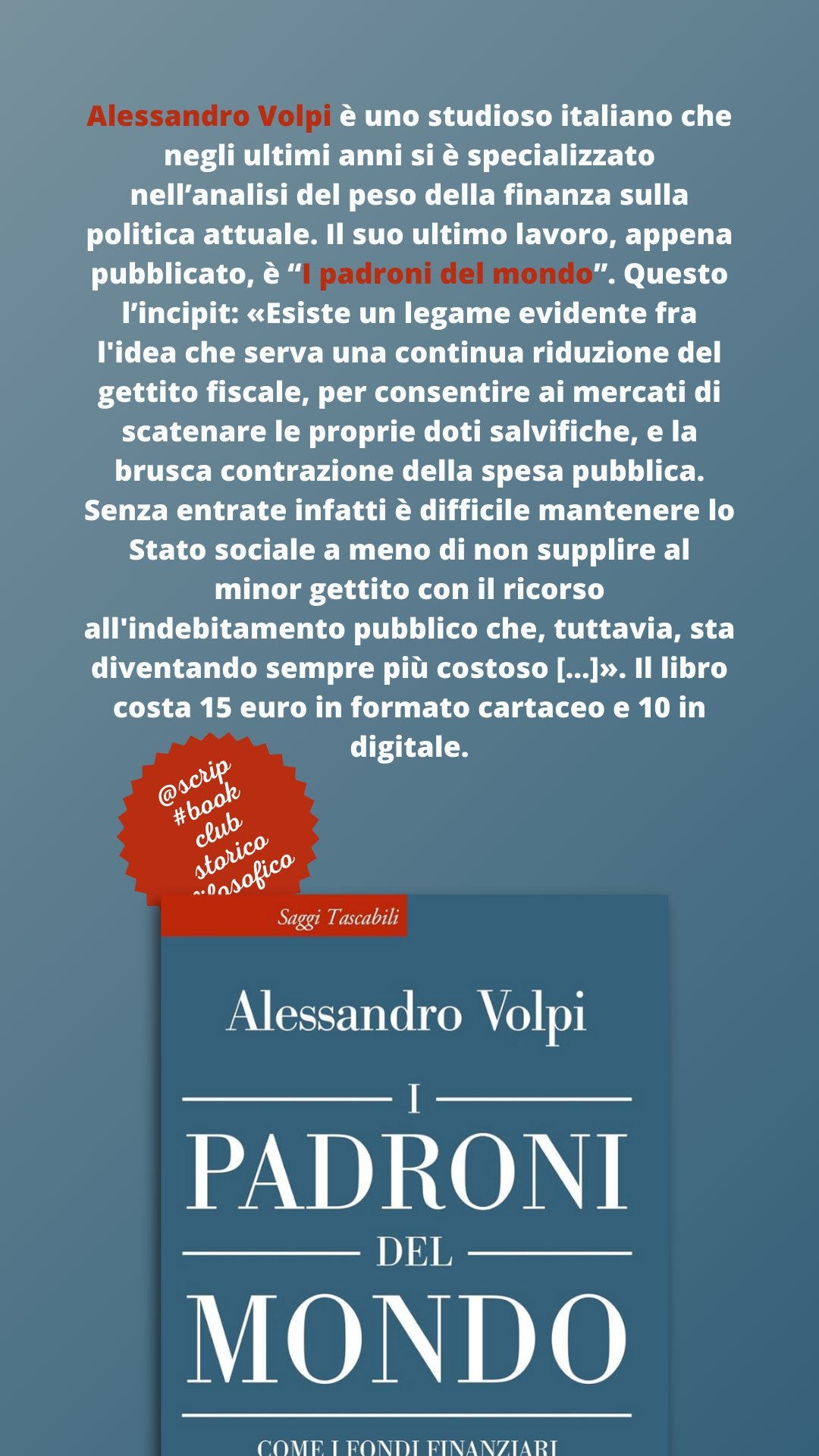


Quello che hai pensato è fantastico.
Grazie