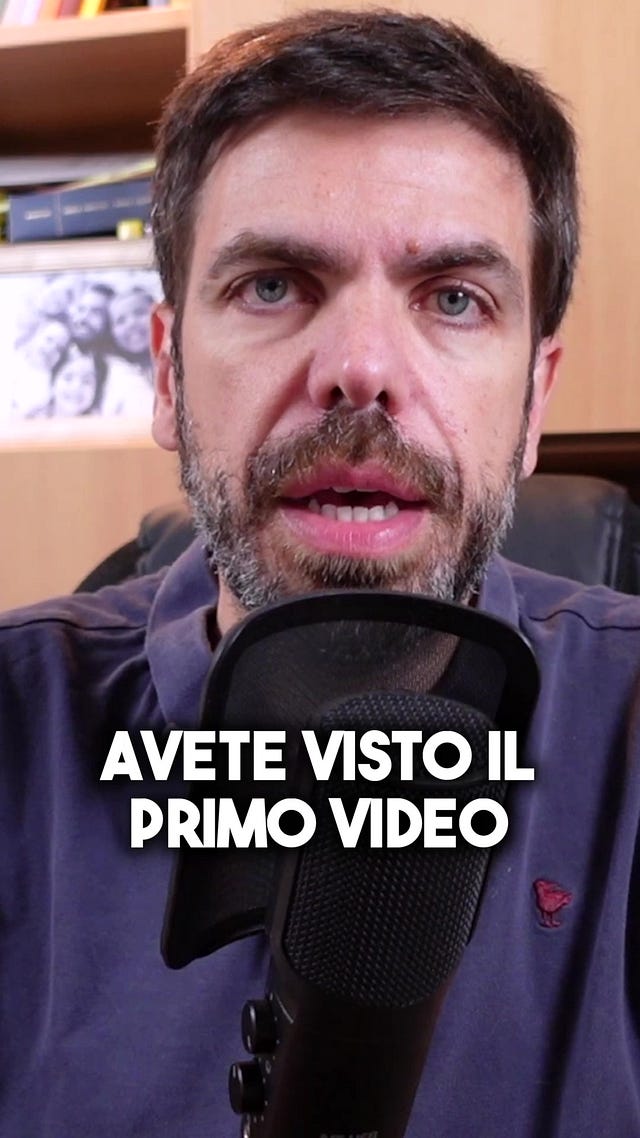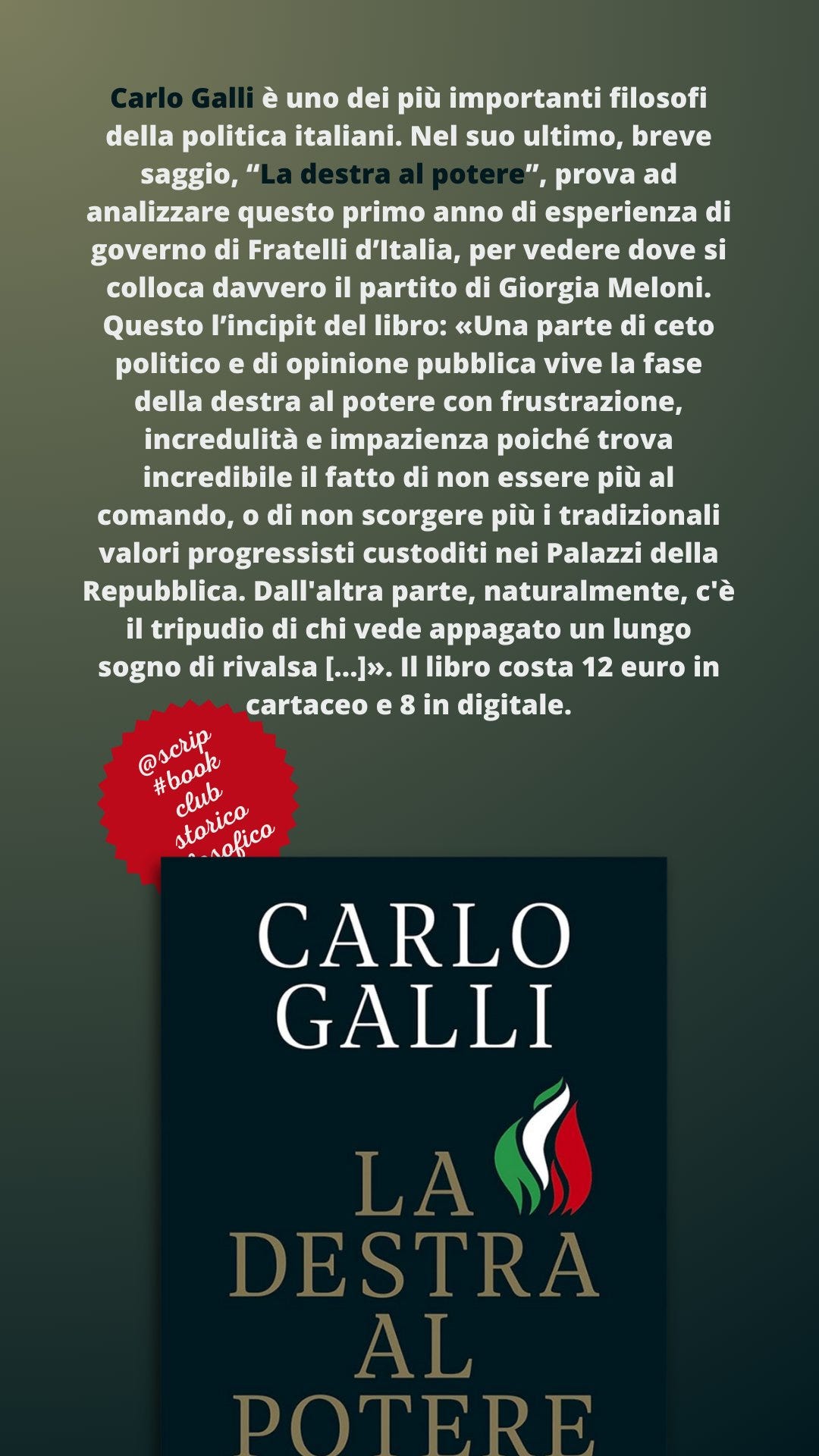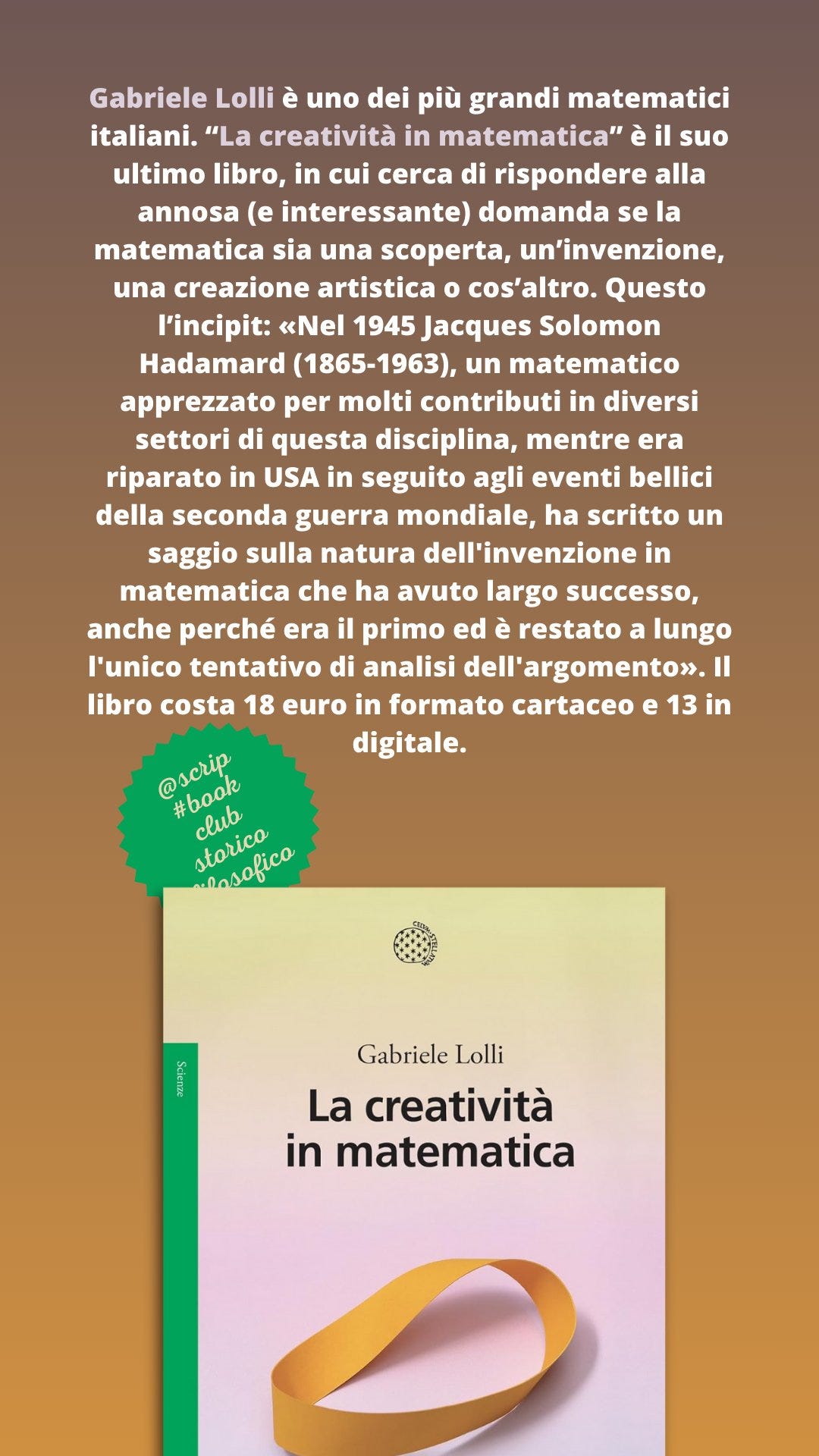È ora di porci qualche domanda sul futuro della democrazia, ma anche di parlare di Deadpool & Wolverine, Renzo Piano, Franz Kafka, L'allenatore nel pallone, Umberto Eco, Juliet Naked, Bauman e Lyotard
Anche luglio sta finendo, non senza qualche ultimo scossone, sia a livello globale che personale.
Noi puntavamo gli occhi sull’Europa, sulla Francia (tra elezioni e Olimpiadi), e perfino sulla nostra Italia, ma la vera scossa di questo mese è arrivata dall’America, come probabilmente vi sarete già resi conto. Prima c’è stato l’attentato a Trump, con tanto di orecchio ferito; poi, quasi come se fosse una risposta a quell’evento, l’addio di Biden e la sua sostituzione, nella corsa per la Casa Bianca, con la sua vice Kamala Harris, su cui si sono focalizzati negli ultimi giorni tutti i riflettori.
Anche personalmente, questa settimana ci sono state alcune novità interessanti, come ad esempio quello che mi è successo proprio oggi: sono partito di prima mattina per Genova per incontrare – insieme ad altri, ben più importanti di me – il senatore a vita Renzo Piano. Come ho già avuto modo di raccontarvi più volte, negli ultimi due anni ho seguito per conto della mia scuola un progetto sviluppato dal gruppo G124, ovvero dei giovani architetti che – tramite una borsa di studio messa a disposizione proprio da Piano – si occupano di riqualificare alcune aree periferiche in giro per l’Italia; e una di queste aree, negli ultimi anni, è stata individuata proprio a Rovigo.
Se volete sapere di più riguardo alla filosofia che sta dietro a questi progetti, vi consiglio di dare un’occhiata al video che feci a suo tempo per presentare l’iniziativa (qui), ma anche al video del flashmob su Giacomo Matteotti che abbiamo realizzato proprio in quella piazza, ormai riqualificata, poche settimane fa (qui). E di seguire ovviamente i progetti del G124, soprattutto tramite il loro account Instagram.
In ogni caso l'incontro con un personaggio come Piano è stato entusiasmante: nonostante i quasi 87 anni, l'architetto è ancora attivissimo e attentissimo, molto preso da ogni iniziativa. Abbiamo parlato proprio del flashmob su Matteotti e mi ha posto pure una complicata domanda che definirei di etica della costruzione. Domanda a cui, da buon dubbioso, non saprei mica tanto rispondere. In ogni caso, ecco la foto ufficiale dell’evento (io sono all’estrema destra, in mezzo ci sono Renzo Piano e il nuovo sindaco di Bari, Vito Leccese).
Tra l’altro, l’iniziativa di Renzo Piano e dei suoi ragazzi si lega benissimo anche al discorso che facciamo questa settimana riguardo al futuro della democrazia e al tema della partecipazione. Ne riparliamo più avanti.
Ora è però il momento di cominciare con la nostra solita lista degli argomenti.
Quello che ho letto
E cominciamo allora dai libri. In elenco questa settimana non ci sono novità rispetto all'ultima volta, ma ho letto parecchio e con tutti e tre i libri sono quasi in dirittura d'arrivo.
Per tutti i gusti di Zygmunt Bauman: ho sempre pensato che Zygmunt Bauman fosse uno dei sociologi più attenti e acuti della nostra epoca. La sua visione della società liquida, anche se non particolarmente innovativa, risulta comunque molto efficace, perché è facile da ricordare e incisiva. La sua capacità di trovare la parola giusta per descrivere i vari fenomeni sociali emerge anche da questo piccolo libretto che sto leggendo da un po', Per tutti i gusti, incentrato sul tema dell’industria culturale nell'epoca contemporanea. Devo dire, però, che il saggio, dopo un inizio incoraggiante, nell’ultima parte che ho letto mi ha un po’ deluso: ci ho ritrovato infatti alcune tesi trite e ritrite che derivano dalla Scuola di Francoforte, ripetute almeno all'apparenza senza che Bauman ci aggiunga qualcosa di suo o particolarmente incisivo. L’interpretazione è insomma la solita: l’industria culturale è un modo che il sistema ha elaborato per tenere sotto controllo il proletariato. Una tesi che aveva sicuramente un senso negli anni '40 e '50, ma che oggi andrebbe almeno in parte rivista e aggiornata: ci sono ancora i proletari, nel senso classico del termine? E guardano Netflix? Forse qualche idea nuova su questo versante sarebbe stata utile, anche se certo non la si può chiedere a Bauman, che è ormai morto da qualche anno e, anche quando scriveva questo libretto, aveva tranquillamente superato l’ottantina. Ad ogni modo, se vi interessa, il volume può essere acquistato qui.
L’isola del giorno prima di Umberto Eco: più leggo questo romanzo, più mi chiedo come il filosofo piemontese abbia potuto ottenere un successo così popolare durante la sua vita. Non metto in dubbio l'enorme erudizione di Eco né la sua simpatia; l'ho sempre trovato uno degli intellettuali italiani più ironici e piacevoli da leggere. Tuttavia, mi rendo conto che la sua produzione non ha praticamente nulla di ciò che teoricamente dovrebbe servire per raggiungere un grande successo popolare. Da un lato, c'era la sua produzione filosofica e di critica letteraria, piena di rimandi, citazioni e teorie pensate per un pubblico di specialisti; dall'altro, ci sono i romanzi, che dovrebbero essere più accessibili e piacevoli per lettori generalisti, ma anche in questo caso spesso ci si imbatte in un livello di difficoltà non dissimile da quello dei saggi. Prendiamo ad esempio proprio il romanzo che sto leggendo in questi giorni, L'isola del giorno prima: se, dopo centinaia di pagine, dovessi riassumerne la trama, mi basterebbero probabilmente due righe, perché su questa benedetta nave di nome Daphne non succede sostanzialmente niente. La maggior parte del racconto è dedicata ad approfondire temi tipici della cultura seicentesca, con riferimenti a Cyrano de Bergerac, il libertinismo, Cartesio, Galileo, Tycho Brahe e molti altri scienziati e filosofi dell'epoca, senza ovviamente dimenticare i gesuiti, la presenza più ingombrante. E mi chiedo, dunque, come un romanzo del genere, che più che un romanzo sembra un saggio e anche molto dispersivo, possa aver incontrato i favori del pubblico. Certo, ad aiutare Eco fu probabilmente il successo de Il nome della rosa, romanzo che lui considerava il più brutto della sua produzione, ma che in realtà è l'unico con un po' di movimento e che riesce a trovare un sano equilibrio tra narrazione ed erudizione. Proprio l'eccezionale efficacia di quel libro ha probabilmente permesso a Eco di prendersi altre libertà nei volumi successivi; in altri termini, se non ci fosse stato Il nome della rosa, forse con la produzione posteriore non sarebbe stato considerato anche un grande narratore, ma solo un grande studioso. Poco male, verrebbe da dire: in un mondo in cui il successo di Temptation Island porta alla chiusura, o almeno alla sospensione, dei programmi culturali della Rai, noi, che rappresentiamo una minoranza, possiamo comunque goderci storie totalmente prive di sex appeal e di ammiccamenti al lettore. Il libro, se vi interessa e se volete far parte di quella minoranza attiva, lo potete comprare qui.
Basta 1 minuto di Carsten Lekutat: vi ho già parlato di questo breve libro del medico tedesco Carsten Lekutat. Il suo scopo è suggerire alcune pratiche veloci per abituarsi a uno stile di vita più sano, sia a livello alimentare che ginnico. E vuole farlo tramite soluzioni rapidissime, da un solo minuto. A livello teorico sembra ovviamente una gran cosa: impegnarsi in attività lunghe è ciò che scoraggia molti dall’iniziare a fare qualcosa di positivo per la propria salute, mentre una modalità semplice e diretta può essere una prima, parziale soluzione. Il problema è che forse le soluzioni proposte da Lekutat non sono così efficaci. Lavarsi i denti con la mano sinistra (o comunque con quella debole) può essere simpatico e interessante, ma temo non cambi radicalmente l’esistenza; stare in piedi su una gamba sola anche; già meglio fare qualche flessione o addirittura praticare l’hula hoop, ma anche qui mi pare si tratti di soluzioni molto diverse tra loro. Quando poi si passa ai succhi di verdura, il mix diventa davvero strano. Insomma, non mi ha convinto del tutto: certo, molte cose sono condivisibili, ma l’idea che questa lettura possa cambiare lo stile di vita delle persone in modo davvero efficace per la salute mi lascia piuttosto incerto. Comunque, è un volumetto breve e rapido, e l’ho già quasi finito, pur leggendolo di sfuggita. Se vi interessa, può essere acquistato qui.
Quello che ho visto
Passiamo ora ai film. Sì, finalmente parliamo di film, perché questa settimana in elenco ci sono in effetti tre pellicole vere e proprie e non le solite serie tv.
L’allenatore nel pallone (1984), di Sergio Martino, con Lino Banfi, Camillo Milli, Gigi & Andrea: di sicuro conoscete tutti L’allenatore nel pallone, un film tanto banale quanto di culto. È stato realizzato nel 1984, nel momento in cui il calcio italiano cominciava davvero a decollare (erano gli anni in cui arrivavano nel nostro paese Maradona, Platini, Zico, Falcao e molti altri), come una sorta di parodia sguaiata e prevedibile del nostro campionato, secondo un canovaccio tipico della commedia popolare di quei tempi. Nonostante personaggi stereotipati e gag comiche trite e ritrite, il film riuscì a conquistare un nutrito gruppo di ammiratori che persiste ancora oggi. Questa settimana l’ho riguardato anch’io, dopo molti anni dalla prima visione, curioso di vedere l’effetto che può fare a quarant’anni di distanza dalla sua realizzazione. Devo dire che il film me lo ricordavo onestamente peggiore di quanto non sia. Certo, ci sono molte pecche – a partire dalla trama prevedibilissima e dalla recitazione di alcuni attori secondari non proprio riuscita – ma ci sono anche alcune scene e battute ben congegnate. Il merito va dato anche a Lino Banfi, sempre immerso nella sua macchietta pugliese ma capace di sostenere al meglio la parte, e agli sceneggiatori: l’invenzione, ad esempio, del 5-5-5 è un tocco di genio che viene ancora oggi citato molto spesso. Insomma, a voler essere oggettivi è un film scontato e forse addirittura brutto, ma, se si guarda al cuore e al culto, è un film che resta negli annali. Lo trovate su Netflix.
Deadpool & Wolverine (2024), di Shawn Levy, con Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin: di solito non riesco quasi mai a guardare un film appena uscito, perché sono sempre sommerso da troppe questioni per potermi permettere una fuga al cinema. Questa settimana, però, sono riuscito a fare un'eccezione e a vedere, quasi subito, Deadpool & Wolverine, forse l'unica uscita degna di nota degli ultimi giorni, il terzo capitolo dedicato alla saga cinematografica del personaggio interpretato da Ryan Reynolds. Devo dirvi subito che il film non mi ha convinto del tutto: da un lato, il fascino della novità di un personaggio scurrile e autoironico – che aveva fatto la fortuna dei primi due Deadpool – mi sembra essersi un po' esaurito; dall'altro, la trama di questo film in particolare mi è sembrata fin troppo cervellotica. La Marvel, lo sappiamo tutti, non se la sta passando troppo bene: dopo i grandi successi degli anni Zero e soprattutto degli anni Dieci, nell'ultimo decennio ha affrontato una serie di flop o comunque passaggi poco convincenti, che hanno intaccato nettamente la sua fama. Il motivo di questo vistoso passo indietro è da ricercare, da un lato, nel naturale esaurirsi dei personaggi “più forti”, che hanno dovuto lasciare spazio a eroi minori e quindi dotati di minor fascino, ma dall'altro anche in un eccesso di trame e sottotrame che ha portato all'esistenza di fin troppi universi paralleli. Deadpool & Wolverine cerca di affrontare tutto questo a modo suo, scherzandoci sopra e mostrandone gli eccessi; ma l'operazione – per quanto intelligente e non priva di qualche momento riuscito – è destinata a rivelarsi difficile e a rendere inutilmente complessa la trama. Deadpool & Wolverine mi sembra un film che aveva delle buone potenzialità, ma che spesso non riesce a sfruttarle: l'alchimia tra Reynolds e Hugh Jackman è palpabile, ma il film alterna infinite scazzottate (decisamente troppe) e infiniti spiegoni (anche questi eccessivi), senza una via di mezzo, senza un naturale sviluppo dei personaggi. O troppo o troppo poco, insomma, e in mezzo un gran caos: questa è l'impressione che mi ha lasciato il film. La trama, a dirla tutta, si può riassumere molto brevemente: un demotivato Deadpool cerca di salvare il mondo con l'aiuto di un Wolverine tornato in vita, ma per farlo dovrà affrontare una serie di scarti dell'universo narrativo della Marvel. Lo trovate al cinema.
Juliet, Naked - Tutta un’altra musica (2018), di Jesse Peretz, con Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O’Dowd: ve ne ho forse parlato qualche mese fa quando stavo leggendo Proprio come te, uno dei suoi ultimi lavori, ma ho un debole, non del tutto spiegabile, per i libri di Nick Hornby. Se non lo conoscete, non è un autore che presenta nei suoi scritti qualcosa di storico o filosofico; piuttosto, lo definirei un abile narratore, capace di imbastire ottime trame partendo spesso da situazioni e problemi comuni dei nostri giorni. Tuttavia, nei suoi romanzi mi sembra che spesso manchi, in un certo senso, l'ultimo passo. In altri termini, va spesso vicino a sfornare il capolavoro, ma alla fine i suoi libri risultano più che altro carini e discreti, perché non riescono, almeno a mio avviso, a fare quel piccolo salto di qualità che servirebbe per convincere davvero. Ovviamente, questo discorso ha qualche eccezione: ad esempio, due suoi romanzi degli esordi, Un ragazzo e Alta fedeltà, sono molto riusciti e si stagliano sul resto della sua produzione. Altri libri sono comunque estremamente godibili, come ad esempio Febbre a 90°, dedicato al calcio e all’Arsenal. In ogni caso, è difficile imbattersi in un suo libro che almeno un po' non ti catturi, che almeno un po' non riesca a tenerti incollato alla pagina. Così, finisco spesso per convincermi a leggere uno dei suoi nuovi lavori oppure a guardare uno dei film tratti dalle sue opere. Così è andata anche con Juliet, Naked, un film di qualche anno fa tratto dal romanzo Tutta un'altra musica, che non avevo ancora visto. Gli interpreti sono molto interessanti: la protagonista è Rose Byrne, ma attorno a lei gravitano da un lato Ethan Hawke e dall'altro Chris O'Dowd. Anche la storia è curiosa e abbastanza originale: Duncan e Annie sono i membri di una coppia in cui entrambi si avvicinano ai 40 anni, abituati ormai alla routine quotidiana di una vita di provincia. L'unico tratto un po' particolare della loro vita è la passione di Duncan per un oscuro cantante americano, Tucker Crowe, autore di un unico disco pubblicato vent'anni prima e poi completamente scomparso dalle scene. Duncan tiene un blog su questo artista e si interfaccia spesso con altri fan sparsi in tutto il mondo, fino a sviluppare una sorta di mania per il cantante. In compenso, Annie inizia a sentire il passare degli anni e scopre l’esigenza di avere un figlio, mal sopportando i perenni rigurgiti adolescenziali del compagno, che tra l'altro ad un certo punto finisce anche per tradirla con una collega. In tutto questo si inserisce Tucker Crowe, il musicista scomparso che, a sua volta, vive una vita molto tranquilla (nonostante i molti figli sparsi per l'America) e sta attraversando anche lui una sorta di crisi di mezz'età. Non vi dico poi come va a finire il film, perché è meglio che ve lo godiate sequenza per sequenza, anche perché offre in effetti qualche momento molto divertente. Anche in questo caso, però, non siamo di fronte a un capolavoro: ci sarebbero spunti per approfondire e per fare un'analisi più seria, ma il regista, come a volte lo stesso Hornby, sceglie di non affondare la lama fino in fondo. Bravi comunque gli interpreti, e in particolare O'Dowd in un ruolo non facile. Se vi interessa, lo trovate su RaiPlay.
Quello che ho pensato
Giusto una settimana fa, con gli abbonati del canale, abbiamo svolto il nostro consueto Simposio filosofico, che aveva però un tema diverso da quelli che affrontiamo normalmente. La tematica scelta dagli abbonati questa volta è stata tipicamente politica: il titolo recitava "La democrazia è in crisi? E se sì, cosa possiamo fare?"
Il dibattito è stato, come sempre, molto interessante e vivace, e ognuno di noi ha espresso la propria opinione sia su quanto sia realistica e profonda questa crisi della democrazia, sia, soprattutto alla fine della serata, su quali potrebbero essere le possibili soluzioni al problema. Anch'io, ovviamente, ho parlato, un po' per rispondere ad alcune sollecitazioni degli abbonati, un po' perché in realtà il tema mi sta piuttosto a cuore e ci rifletto da tempo. Vorrei approfittare di questo spazio e della settimana trascorsa da quella serata per condividere con voi alcune di quelle riflessioni e ampliare un po' lo sguardo, visto che il tema mi ha in un certo senso “tormentato” in questi giorni.
In primo luogo, mi sembra che sì, la democrazia sia in parte in crisi, anche se non dobbiamo esagerare con questa analisi. Sono anni che vari osservatori affermano che la democrazia sia con l'acqua alla gola, che stia tirando i suoi ultimi respiri prima di essere travolta dal populismo, dalla democrazia diretta o da chissà quale altra nuova forma di governo. Eppure, nonostante le mille sollecitazioni, una pesantissima crisi economica e una pandemia, siamo ancora qui, con istituzioni tutto sommato solide.
Pensate solo al caso italiano. Abbiamo, per la prima volta nella storia repubblicana, un governo guidato da una donna, ma anche da un'erede della tradizione post-fascista. Fratelli d'Italia ha al suo interno personaggi molto ambigui e porta ancora nel suo simbolo e nella sua storia un legame abbastanza forte con l'esperienza del Movimento Sociale Italiano, che a sua volta rimandava all'esperienza della Repubblica Sociale di Salò: cose che trenta o quarant’anni fa avrebbero fatto accapponare la pelle ai nove decimi degli italiani e avrebbero fatto urlare ai grandi pericoli per la democrazia. Certo, ancora oggi molti si dicono preoccupati per questa nostra democrazia, ma siamo onesti: dopo un anno e mezzo di governo Meloni, possiamo tranquillamente dire che i rischi per la democrazia sono stati sostanzialmente nulli. Attenzione, non sto dicendo che Giorgia Meloni abbia governato bene, che i suoi ministri siano tutti sinceri democratici, o che alcuni episodi di violenza e repressione contro i giovani non siano altamente condannabili; ma devo anche dire che abbiamo avuto stagioni peggiori nella nostra storia repubblicana, che la repressione delle forze dell'ordine non è una novità assoluta ed è stata anche più grave in altri momenti storici, e che finora la democrazia non è stata messa a repentaglio dall'azione di Giorgia Meloni, che ha governato in modo più moderato rispetto a quanto abbiano fatto vent'anni fa Berlusconi o cinque anni fa i membri del primo governo Conte, quando Di Maio e Salvini si lanciavano spesso in azioni anche più radicali. Se una persona si risvegliasse oggi in Italia dopo un coma trentennale e vedesse Giorgia Meloni al governo, senza conoscerne la storia, probabilmente la considererebbe un'esponente della destra DC, non diversa da tanti capi di governo che l'Italia ha avuto nella sua storia.
Ripeto, questo non per elogiare o difendere Giorgia Meloni, ma per far capire che le nostre istituzioni democratiche, per quanto certo un po' in affanno, sono più solide di quanto ci piaccia pensare: se Giorgia Meloni o un altro Presidente del Consiglio volessero oggi limitare le libertà civili degli individui, farebbero una grandissima fatica, e infatti non ci provano nemmeno; e anche quei commentatori, perfino quei filosofi, che avevano visto nella pandemia da Covid una macchinazione internazionale per uccidere la democrazia e togliere i diritti ai cittadini, credo si siano dovuti ricredere, visto che, dopo una situazione effettivamente emergenziale e drammatica, tutto è tornato alla normalità e la presunta dittatura sanitaria sembra non aver lasciato alcuno strascico.
Certo, però, che qualche affanno la democrazia ce l'ha. Quali sono questi problemi? Ne ho individuati tre che secondo me sono un po' più importanti degli altri: il declino della partecipazione politica, la crescente sfiducia nelle istituzioni e l'aumento delle disuguaglianze. Provo velocemente a darvene conto.
Primo: la scarsa partecipazione alla politica. Attenzione, in questo campo non mi riferisco solo a una crescita dell'astensionismo in occasione delle elezioni, che comunque è abbastanza evidente; mi sembra, piuttosto, che la partecipazione alla vita politica si sia fatta estremamente superficiale anche al di là delle elezioni, che si sia sviluppato un sostanziale disinteresse. È un discorso un po' complesso e spero di riuscire a spiegarmi, quindi vi chiedo di provare a seguirmi nel ragionamento. Un tempo, anche qui in Italia, la vita politica era vissuta in maniera molto intensa: in ogni famiglia si discuteva, magari superficialmente ma comunque si discuteva, di questioni politiche; i lavoratori erano iscritti a qualche sindacato e quindi erano spesso in lotta col datore di lavoro; il figlio magari a scuola simpatizzava per un movimento politico e iniziava a comprare il giornale di riferimento di quel movimento; la stessa musica pop aveva pesanti venature politiche, tanto che sapevi benissimo a quale area apparteneva un certo cantante e a quale altra area ne apparteneva un altro; anche fuori casa, la politica si faceva molto sentire con feste popolari organizzate dagli stessi partiti, associazioni giovanili coordinate da gruppi più o meno vicini a qualche movimento e via discorrendo. Non mi riferisco solo a partiti veri e propri, ma più in generale a una intera società civile, a quelli che vengono a volte chiamati i “corpi intermedi”, che mettevano insieme le persone sulla base di precise finalità (appunto anche politiche). Tutto questo oggi non esiste più, se non in minima parte. È difficile trovare un ragazzo iscritto a qualche movimento o a qualche associazione, anche di carattere culturale o ricreativo; è quasi impossibile che nelle case dei giovani di oggi si possano trovare quotidiani; ai partiti e, per certi versi, anche ai sindacati non si iscrive più nessuno; si può vivere una vita tranquillissima senza mai nemmeno sentir parlare di politica. Ormai, infatti, la politica la conosciamo o dalle trasmissioni tv o dai social network: e in entrambi i casi si tratta di una politica sostanzialmente priva di partecipazione. Siamo spettatori della politica, che di fatto si è ridotta a uno show. Quello che ci viene richiesto è di mettere semplicemente un like, come appunto si fa sui social network, di approvare o disapprovare la dichiarazione del giorno, il meme del giorno, ben sapendo però che noi quella dichiarazione non l'abbiamo costruita, che non abbiamo partecipato in alcun modo a formarla.
Un tempo non era del tutto così. Il giovane che entrava in un partito era convinto di poter essere un pezzo importante di quel partito; era convinto che le lettere che spediva alla redazione del giornale venissero lette, che la sua dichiarazione alla riunione del circolo di quartiere venisse in qualche modo ascoltata, che anche banalmente la sua discussione al bar con gli amici servisse a formare un'opinione pubblica che poteva avere un peso, anche se minimo, nei confronti dei politici. Quei politici, per quanto fossero già allora dei veri e propri professionisti, ascoltavano la base. Non era un'epoca in cui venivano effettuati sondaggi d'opinione quotidiani, ma un tempo in cui fino alle elezioni non si sapeva quanto un partito avrebbe preso oppure no; e proprio per questo le strutture del partito diventavano molto ricettive nei confronti di quello che emergeva dalle varie località, dalle varie associazioni, dai vari gruppi. Così il giovane, più o meno appassionato di politica, sentiva che la sua voce poteva almeno in minima parte contare, che aveva un senso partecipare. Non è un caso che nei primi anni '70 Giorgio Gaber cantasse che la libertà non era solo avere un’opinione, ma era partecipazione; perché quella partecipazione era davvero sentita come un elemento fondante della vita politica. Oggi noi stiamo negando proprio quella tesi: perché per noi la libertà pare essere avere un’opinione e basta, senza partecipare.
Questo, sia detto per inciso, ha anche ovviamente un rovescio della medaglia: l'Italia degli anni '70 era forse anche troppo partecipativa, visto che quelle passioni politiche venivano portate a volte oltre il limite della correttezza e sfociavano nella violenza, violenza sia banale, di strada, con offese e spintoni in ogni assemblea di istituto di provincia, ma anche violenza a volte estremamente grave, con i fatti di sangue che conosciamo tutti. Eppure, paradossalmente, proprio quei fatti di sangue rendevano la democrazia ancora più forte: perché è quando una cosa è minacciata che la si apprezza di più, che la si difende con maggior veemenza. Insomma, negli anni '70 la democrazia era sicuramente più a rischio di oggi, eppure proprio per questo la si difendeva molto più accanitamente di oggi.
Il secondo motivo di preoccupazione per lo stato del nostro sistema di governo sta nella sfiducia ormai piuttosto diffusa nei confronti delle istituzioni. La classe politica viene facilmente identificata come una classe di ladri e di furbi, e bisogna dire che questa sfiducia va ormai oltre le singole persone. È difficile trovare qualcuno che esalti ancora il ruolo del Parlamento, qualcuno che nutra estrema fiducia nella magistratura o qualcuno che, magari dopo la fine della cosiddetta luna di miele e qualche mese di governo di troppo, si fidi ancora del leader di turno. L'unico che si salva in questo marasma è forse il Capo dello Stato, perché ci è capitato di trovare in Sergio Mattarella un personaggio che risalta davanti ai limiti di tanti altri rappresentanti della politica; ma in generale la fiducia degli italiani nel buon funzionamento delle istituzioni mi sembra ai minimi storici. Non che all'estero se la passino tanto meglio: basta rivolgere gli occhi agli Stati Uniti per accorgersi che forse le cose, là, stanno anche peggio che qua, con una politica che sembra in ostaggio degli interessi delle grandi corporation o comunque di fini privatistici, e che non sa più parlare al cittadino.
A dirla tutta, questo mi pare anche inevitabile: i problemi del mondo di oggi sono problemi sempre più grossi, che i singoli Stati non possono affrontare da soli. Pensate solo alla pandemia, che per essere ben affrontata ha avuto bisogno di un coordinamento in realtà sovranazionale; pensate alla guerra tra Russia e Ucraina, alla quale si può rispondere solo come Unione Europea e non certo come Italia; pensate alle future sfide dell'intelligenza artificiale o delle grandi aziende tecnologiche, a cui l'Italia, da sola, può rispondere con una voce molto flebile. Davanti a sfide così importanti servono organismi sovranazionali, che però finiscono per rendere ancora più distanti le istituzioni. Se già il cittadino ha poca fiducia rispetto a quello che accade a Roma, figuratevi quanto potrà averne rispetto a quello che accade a Bruxelles o a Strasburgo.
Terzo problema, e non certo per importanza: la crescita delle disuguaglianze. Negli ultimi venti o trent’anni il divario tra i redditi più alti e quelli più bassi è andato crescendo in tutto il mondo occidentale, ed è diventato particolarmente gravoso in Italia, dove le statistiche ci mostrano come i salari non siano affatto aumentati in questi anni, a differenza di quanto avvenuto in altri paesi simili al nostro. Le cause sono molteplici e nel caso italiano c'entra molto anche la scarsa produttività del lavoro, ma in generale gli effetti sono davanti agli occhi di tutti: la classe che è più in crisi è probabilmente la piccola borghesia, quella classe che fino a trent'anni fa sperava, anche con validi motivi, di vedere crescere il proprio reddito, di poter accedere a posizioni migliori, ma che si è vista frustrata in questa ambizione, con i figli che partono per l'estero e non tornano più e gli adulti che, come tipico della piccola borghesia arrabbiata, si spostano in tutta Europa verso partiti populisti. Storicamente, quando questa classe media guarda al futuro come a una minaccia, allora arrivano i guai: l'abbiamo visto accadere molte volte e purtroppo sono molti anni che proprio questa classe sociale si sente trascurata dalla politica o comunque vede i propri problemi non risolti.
E allora, cosa fare davanti a tutto questo? Se in nell'incontro del Simposio filosofico siamo stati bravi a individuare i problemi, ben più difficile è individuare le soluzioni, anche perché ci hanno provato sicuramente menti ben più brillanti della mia, in passato. Io, riprendendo in realtà le considerazioni fatte da altri (e tenendo conto anche dell’esperienza di Renzo Piano, una cosa piccola ma significativa), punterei su tre cose, che vorrei lasciare anche a voi come questioni su cui riflettere e su cui magari si può lavorare anche individualmente.
Primo: dobbiamo istruire di più, dobbiamo studiare di più, dobbiamo cercare di capire di più. In altri termini, dobbiamo uscire da questo meccanismo perverso del giudizio ed entrare in quello della comprensione. Dicevo prima che la politica di oggi mi sembra ridotta perlopiù a mettere like, a cercare sui social o in tv qualcuno che dica le cose che diremmo noi al bar, e poi applaudirlo. Questa non è politica, ma appunto è spettacolo, è uno show. La vera politica è contribuire a formare un'opinione pubblica. Ma per contribuire a questo bisogna prima di tutto conoscere e pensare, cosa che facciamo poco, perché richiede tempo, passione e fatica. Come dicevo anche nella riunione con gli abbonati, penso che ci siano molte persone che avrebbero voglia di capire, comprendere e studiare, e nel mio piccolo anche il canale YouTube lo dimostra: sono centinaia di migliaia le persone che ne fruiscono e che cercano, tramite quei video, di comprendere cose complicate, cose non semplici, che magari servono anche per superare un esame o una verifica ma che fanno crescere una coscienza civica e politica. Quindi, il primo suggerimento è: non limitatevi alla superficie delle cose, ma costringetevi a leggere, ad ascoltare, a studiare, a recuperare qualcosa di un po' più complesso del talk-show serale su Rete 4 o del video su TikTok.
Secondo: dobbiamo ridurre queste disuguaglianze economiche, e purtroppo all'orizzonte non si vede nessuna politica che abbia le capacità per farlo. I dati sono sotto gli occhi di tutti da parecchio tempo e diversi analisti li ho presentati e studiati, ma nulla di concreto è accaduto. Se lo Stato serve a qualcosa, serve proprio a cercare di ridurre queste disuguaglianze di partenza, senza annullare le naturali differenze (ma anzi, proteggendole) e senza livellare la società. Dobbiamo cercare di porre un freno a questa polarizzazione dei redditi, per consentire una vera uguaglianza delle possibilità che dovrebbe essere alla base della nostra cultura occidentale.
Terzo: devo dare credito al buon Davide che me l'ha ricordato durante quella riunione, ma anche a Edoardo Narne del progetto G124 e a Renzo Piano, ma dobbiamo ricordarci di essere gentili. Mi sono convinto che uno dei pregi principali del sistema liberaldemocratico sia il rispetto reciproco, che invece viene prepotentemente a mancare in tutti gli altri sistemi. Nello Stato autoritario, nello Stato totalitario, nello Stato comunista, nello Stato assolutista, nell’ancien régime, eccetera, c'era sempre qualcuno che veniva costitutivamente discriminato, una qualche minoranza che veniva attaccata e contro cui si scagliava l'odio pubblico. Nello Stato che abbiamo costruito in Europa, pur tra mille problemi, abbiamo fatto di tutto per condannare la violenza, condannare i soprusi, mettere da parte l'odio e accettare la tolleranza. La Costituzione italiana, come tutte le altre costituzioni occidentali, mette questi valori in cima alla lista. E allora, se vogliamo ridare senso alla democrazia in cui viviamo, dobbiamo anche rinvigorirne i valori, renderli più effettivi ed efficaci, più sostanziali. Sono convinto, ad esempio, che uno dei problemi della disaffezione rispetto alla politica sia anche in questo eterno urlarsi contro, questo eterno odiarsi e sputarsi in faccia che caratterizza la politica attuale. I dibattiti televisivi sono ormai il luogo in cui ci si urla reciprocamente le peggiori cose; ma anche sui social il clima che si respira non è dei migliori. Guardate di nuovo all'America, dove i problemi emergono a volte in maniera più evidente che non in Europa: la situazione tra le opposte fazioni là non è forse mai stata così calda come in questi ultimi anni. Penso che invece avere voglia di ascoltarsi, di discutere seriamente e di confrontarsi sia sempre la base della nostra cultura occidentale. Noi abbiamo i nostri Stati, con le nostre costituzioni, perché prima abbiamo avuto dei filosofi che hanno mostrato come sarebbe stato utile avere sistemi del genere, filosofi che a loro volta avevano vissuto sulla loro pelle i problemi dell'intolleranza. Le nostre costituzioni e i nostri Stati nascono proprio dall'esperienza delle guerre civili, delle lotte, delle rivoluzioni; come un superamento di quelle lotte fratricide. E possono dunque ritornare ad essere vitali solo nel momento in cui si dà senso e si dà vita a quei confronti, a quei dibattiti, a quel franco, aperto ma anche rispettoso dibattito pubblico.
Mi si faceva notare che in fondo, in queste riunioni per gli abbonati che facciamo online, cerchiamo di rispettare tutte queste regole: io do la parola a un abbonato alla volta, e ognuno sta ad ascoltare l'altro, aspettando il proprio turno per parlare, a volte ribattendo, a volte confermando quello che ha detto il predecessore; in questo modo, pur tra le diverse esperienze, tra i diversi pensieri e tra le diverse opinioni politiche, alla fine tutti si sentono credo un po' arricchiti, perché hanno parlato ma hanno anche ascoltato; e perché hanno ricevuto materiale nuovo su cui riflettere, materiale che magari non li ha portati a cambiare idea ma che comunque rappresenta un passo avanti verso una miglior comprensione della realtà e delle opinioni altrui.
Quindi, compito per casa: quest'estate leggete qualche buon articolo o buon libro su temi di vostro interesse, ma che siano temi sociali, che possano avere ricadute anche sugli altri; e poi provate a parlare di questi temi con qualcuno, possibilmente con qualcuno che sapete avere un'opinione diversa dalla vostra. Cercate di confrontarvi in maniera rispettosa con quest'altra persona, di capire perché la vede in quel modo e di spiegare anche perché invece voi la vedete in modo diverso. Insomma, dialogate, riflettete, discutete, cercando di arricchire voi stessi e chiunque abbiate di fronte. Se facessimo tutti così, che bel passo avanti sarebbe per la nostra stessa democrazia?
Quello che ho registrato e pubblicato
Ed ora, ecco una panoramica su tutto quello che è uscito nel canale nell’ultima settimana:
Kafka e la filosofia: gli antecedenti: secondo video dedicato al pensiero di Franz Kafka e ai suoi legami con la filosofia
Il Manifesto del Partito Comunista - audiolibro spiegato parte 2: continuiamo a leggere il capolavoro di Marx ed Engels
Il principio di causa per David Hume (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
L'omicidio Matteotti e la dittatura fascista (per il podcast “Dentro alla storia”)
Il fascismo come dittatura a viso aperto (per il podcast “Dentro alla storia”)
Le emozioni di Inside Out e la filosofia parte 2
Il falsificazionismo di Popper come strumento oggi
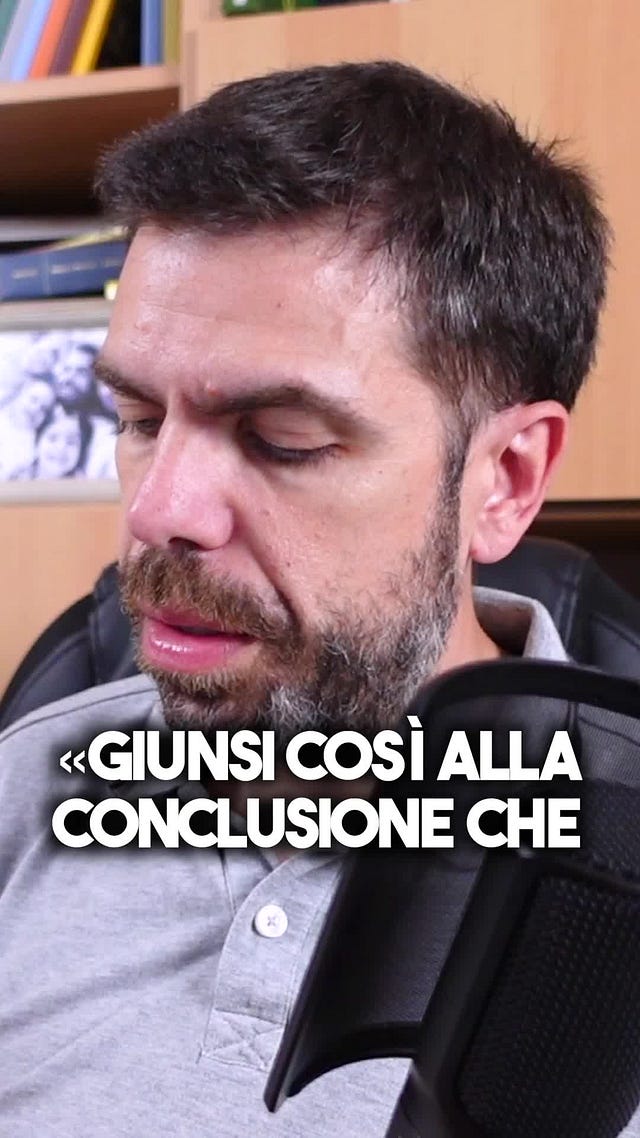 @scrip79Il falsificazionismo costituisce, per Karl Popper, un criterio di demarcazione per distinguere ciò che è scienza da ciò che non lo è. Ma può essere utile anche nella vita quotidiana, per orientarci nelle scelte? #KarlPopper #filosofia #falsificazionismo #AncheSocrateQualcheDubbioCeLAveva #scetticismo
@scrip79Il falsificazionismo costituisce, per Karl Popper, un criterio di demarcazione per distinguere ciò che è scienza da ciò che non lo è. Ma può essere utile anche nella vita quotidiana, per orientarci nelle scelte? #KarlPopper #filosofia #falsificazionismo #AncheSocrateQualcheDubbioCeLAveva #scetticismoTiktok failed to load.
Enable 3rd party cookies or use another browser
Quello che devi fare per seguirmi sui social
Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:
Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads
Quello che puoi fare per sostenere il progetto
Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.
La condizione postmoderna di Jean-François Lyotard: assieme all’italiano Gianni Vattimo, il francese Jean-François Lyotard è considerato il padre della filosofia postmoderna. Questo volume – La condizione postmoderna, pubblicato in lingua originale nel 1979 – è il testo fondativo non solo di questa corrente, ma anche della parola chiave “post-moderno”. Insomma, è un libro da leggere, ancora estremamente attuale, in cui si spiegano la crisi e la fine delle grandi narrazioni su cui si è retta la modernità. Lo si può acquistare qui.
sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):
C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.
Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!
Quello che c’è in arrivo
E concludiamo, come sempre, con qualche anticipazione su quello che ci aspetta nella settimana in corso. Ecco il programma:
domani si parte col podcast di filosofia, con una puntata in cui esploriamo le ultime conseguenze sulla gnoseologia di Hume;
mercoledì ci sarà poi la diretta riservata per gli abbonati, come ogni mese;
per giovedì, visto che si celebra lo “Spider-Man Day”, ho preparato un breve video sulla filosofia dell’Uomo Ragno;
venerdì torneranno i podcast, ma questa volta sarà il turno di quello di storia, con un focus sull’espansione del fascismo nell’Europa degli anni '20;
sabato vorrei pubblicare la seconda e ultima puntata sulla filosofia di Simone Weil;
domenica probabilmente uscirà un altro video breve, visto che devo ancora raccontarvi come è stato ucciso John Fitzgerald Kennedy;
lunedì prossimo, infine, parleremo della visione della religione in David Hume.
E questo è quanto. Lunedì prossimo, tra l’altro, vi invierò la newsletter direttamente da Londra, visto che passerò la settimana (o buona parte di essa) in Inghilterra in viaggio con la famiglia. Dovrei riuscire comunque a pubblicare i video con regolarità, dato che li sto già preparando in anticipo, quindi vi terrò compagnia anche dalla Gran Bretagna, in modo che possiate godervi le vacanze (se volete) anche con la storia e la filosofia. A presto!