Il senso del ridicolo, la sua mancanza e la sua importanza, ma parliamo anche di Only Murders in the Building, Il nome della rosa, Percy Jackson, i cognomi italiani, la mafia, Voltaire e Brooklyn 99
Data emblematica e ormai divisiva, quella del 7 ottobre. Oggi, come certamente saprete, ricorre infatti il primo anniversario dall’attacco di Hamas a Israele, a cui è seguito il contrattacco israeliano con l’invasione prima della Striscia di Gaza e poi, proprio di recente, con l’allargamento del conflitto ormai quasi conclamato al Libano.
Dico divisiva, perché anche in questi giorni questa ricorrenza è stata usata per ribadire la propria vicinanza all’una o all’altra parte coinvolta nel conflitto. E se, nei primi mesi, i dibattiti almeno a volte vertevano sui fatti e sulle strategie concrete, più passa il tempo più mi pare che questa, anche dalle nostre parti, sia diventata una gara quasi del tutto ideologica, di posizionamento. Ovvero: si sta con Israele o con i palestinesi non in base a quello che accade o a quello che potrebbe, concretamente, realizzarsi, ma almeno in certi casi in base alla propria ideologia: se mi piace l’Occidente vedo solo le ragioni di Israele, se mi fa schifo l’Occidente vedo solo le ragioni dei palestinesi.
In realtà la faccenda è complicatissima e ogni volta che personalmente provo ad analizzarla mi trovo in imbarazzo, perché tra così tanti tifosi io non saprei proprio per chi tifare. I palestinesi hanno alcune ragioni sacrosante dalla loro (il diritto all’autodeterminazione, le vittime civili, decenni di ingiustizie), ma allo stesso tempo ottime ragioni si vedono anche nel campo israeliano (il diritto alla sicurezza, il fatto che i suoi nemici siano spesso dei fanatici islamisti, lo spettro dell’antisemitismo). E mi vien da pensare che una soluzione si possa trovare, invece, solo sbarazzandosi del tifo, della paura e dell’odio, ma con soluzioni concrete e pragmatiche, che tengano conto delle ragioni di tutti e scendano per forza di cose a compromessi: di tanto in tanto la diplomazia internazionale sembra proporne alcune, di queste soluzioni, ma sempre con voce flebile e con scarsissime probabilità di successo. Così, a un anno di distanza dai fatti che hanno dato avvio al tutto, io personalmente mi ritrovo abbastanza pessimista.
È forse anche per via di questo pessimismo che negli ultimi mesi non sono più tornato, nei miei video, su questa questione; perché, cosa volete che dica? Al momento, non c’è molto da disquisire, e chi propone soluzioni facili spesso vive nel mondo dei sogni. E poi, lo sapete: ogni volta che provo a dire qualcosa di equilibrato su un argomento caldo, di attualità, si scatena subito la piccola componente arrabbiata del web, che invece non vede l’ora di sbraitare. Ragionare con calma è sempre difficile, quando si è tutti focosi. Vedremo, magari un nuovo video arriverà, ma credo non subito.
Intanto mettiamo da parte questo anniversario e guardiamo al futuro, sperando in un futuro di pace. E guardiamo anche ai libri, ai film e alle varie riflessioni, che ci insegnano sempre qualcosa. Cominciamo.
Quello che ho letto
E allora iniziamo, come al solito, dai libri, con vari volumi che questa settimana ci salutano (perché li ho finiti).
I cognomi degli italiani di Roberto Bizzocchi: vi ho già detto, credo, quanto mi sia piaciuto leggere I cognomi degli italiani di Roberto Bizzocchi, che insegna all'Università di Pisa. Si tratta di un libro di storia con tutti i crismi, che affronta un tema spesso intrigante per il grande pubblico, quello dell'origine dei cognomi, ma lo fa senza concedere troppo alla curiosità superficiale, andando invece a individuare i processi storici di lungo periodo dietro alla questione dei cognomi e spiegandoli in maniera solida e approfondita. Nonostante questa autorevolezza, il libro però non è affatto noioso, forse anche perché Bizzocchi riesce a mantenere fino alla fine uno stile autoironico, riuscendo perfino a strappare qualche sorriso quando racconta le strane vicissitudini di certi cognomi italiani. In un momento in cui sembra che per fare storia a un certo livello si debba cedere allo spettacolo, mettendosi a fare gli sciocchi o puntando tutto sul melodramma, il ricercatore toscano ci dimostra che si può essere simpatici e divertenti mantenendo, al contempo, uno standard molto alto. È un libro insomma che consiglio caldamente, anche perché è uno dei saggi di carattere storico più belli che ho letto negli ultimi tempi. Se vi interessa, potete comprarlo qui.
Il nome della rosa di Umberto Eco: non che mi aspettassi grandi sorprese, visto che Il nome della rosa l'ho letto e riletto varie volte, oltre ad aver visto il film e averne parlato e discusso a scuola in numerose occasioni. Però arrivare alla fine di questo grande, immenso romanzo di Umberto Eco è sempre una grande soddisfazione, sia perché si tratta di un libro molto impegnativo – sia per il numero di pagine che per le vicende narrate –, sia perché si arriva a chiudere quello che, a mio avviso, è sicuramente uno dei grandi capolavori italiani degli ultimi cinquant'anni. E non lo dico solo perché sono un appassionato di storia e quindi inevitabilmente tendo ad apprezzare un romanzo così preciso e ben documentato, ma anche perché qui Eco è riuscito davvero a condensare tutti i suoi pregi e a mettere da parte, o comunque a rendere inoffensivi, i suoi difetti.
La storia è appassionante, ti tiene incollato alla pagina e può essere letta a più livelli: sia da chi cerca costanti riferimenti alla filosofia medievale e agli eventi storici del Trecento, sia da chi semplicemente vuole un po' di sano intrattenimento nello stile della narrativa gialla. A tutto questo devo poi aggiungere che stavolta ho letto il libro in maniera diversa dal consueto: come vi avevo già anticipato, infatti, più che leggerlo, l'ho ascoltato nella versione audiolibro, cosa che devo dire mi ha abbastanza entusiasmato. Certo, non sono riuscito a prendere appunti o a sottolineare i vari passaggi che avrei voluto segnarmi, ma la lettura recitata di Tommaso Ragno è incredibilmente efficace e ripaga delle rinunce momentanee alla carta. Sulla trama credo di non dover rivelare molto, sia perché non voglio fare spoiler, sia perché, ormai, quasi tutti la conoscono. Nel caso contrario, posso dirvi che il protagonista è un frate francescano di nome Guglielmo da Baskerville, che durante una sua missione diplomatica in un convento del Nord Italia si trova invischiato in una serie di omicidi misteriosi sui quali comincia a indagare. In parallelo, si interessa però anche alle oscure vicende legate all'abbazia, e soprattutto alla sua biblioteca. Qui trovate la versione cartacea, mentre qui se volete potete ascoltare la versione audiolibro che ho ascoltato anch'io.
Candido di Voltaire: visto che proprio questa sera si è tenuta la riunione del Club del libro dedicata al Candido di Voltaire, nei giorni scorsi ho dovuto rileggere e terminare il capolavoro dell'illuminista francese. In realtà, l'avevo già letto più volte, e lo sto perfino filmando per il mio canale YouTube, ma avevo bisogno di rinfrescarlo un po' nella mia memoria, almeno per ricordarmi come finisce. La trama è molto semplice: il protagonista è un giovane ragazzo tedesco di nome Candido, che si rivela ingenuo non solo nel nome ma anche nel carattere. Educato da un maestro di filosofia di nome Pangloss, è convinto di vivere nel migliore dei mondi possibili, fedele all'insegnamento originale di Leibniz. Purtroppo per lui, però, il mondo sembra fare di tutto per smentire questa sua teoria, facendogli vivere una serie di vicissitudini molto tragiche e a tratti grottesche. Alla fine, Candido comprende che le cose non stanno come pensava, ma che anche in un mondo imperfetto si può fare la propria parte e cercare di "coltivare il proprio giardino". Non dirò altro sul libro, anche perché molte cose ho detto nella serata del Club del libro. Vi consiglio comunque di acquistarlo e leggerlo, anche perché è una lettura leggera e piacevole. Potete comprarlo qui.
Quello che ho visto
Passiamo ora ai film e, soprattutto, alle serie tv, soprattutto quelle un po’ gialle e un po’ comiche.
Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini (2010), di Chris Columbus, con Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario: c'è stato un periodo, nella mia famiglia, in cui Percy Jackson dominava la scena. Quando mio figlio maggiore frequentava le scuole medie, era entrato in fissa per questo personaggio e nel giro di poco tempo si è letto tutti i romanzi della saga creata da Rick Riordan e, di conseguenza, ha voluto vedere anche i film tratti da quei libri. Anch'io, inevitabilmente, sono stato trascinato in questa ondata, guardando i primi film e leggendo il primo libro. In entrambi i casi ho riscontrato pregi e difetti simili: da un lato, Riordan è stato bravo ad attualizzare i miti greci per un pubblico adolescente, cercando di renderli accessibili nel XXI secolo; dall'altro, però, sembra di trovarsi costantemente di fronte a una “americanata” – se mi passate il termine – ossia a una spettacolarizzazione che sfrutta i nomi e le idee della mitologia antica, senza però riuscire a coglierne il significato più profondo. Qualche giorno fa mi sono ritrovato a rivedere il primo film del 2010, diretto da Chris Columbus, con i miei figli più piccoli, e la mia impressione si è confermata. Tant'è vero che, a un certo punto, ho rischiato di addormentarmi. Certo, c'è molta azione, e sembra di essere davanti a un film di supereroi, con il giovane Perseo nei panni di una specie di Spider-Man delle antiche origini greche; ma, allo stesso tempo, il senso profondo di quei miti non mi sembra emergere affatto. Il bello dei miti antichi non è solo la trama delle vicende, ma anche il contesto culturale in cui quei miti sono nati. Bisogna cercare di capire perché quelle leggende sono state elaborate, perché hanno avuto successo e quali radici profonde della natura umana tentavano di rappresentare. Ebbene, nelle avventure di Percy Jackson tutto questo si perde, diluito in battaglie, turbe adolescenziali e corse senza respiro. Per carità, si è visto di peggio sul grande schermo, ma resta l'impressione che l'opportunità potesse essere sfruttata meglio. Il film è disponibile su Disney+ (dove tra l’altro si trova anche una recentissima riproposizione della saga in versione serie tv) e su Netflix.
Only Murders in the Building, episodi 4.02-4.03 (2024), di Steve Martin e John Hoffman, con Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez: vi ho già parlato diverse volte di Only Murders in the Building, la serie trasmessa con grande successo in Italia da Disney+ e molto amata anche negli Stati Uniti, capace di rilanciare le già fiorenti carriere di Steve Martin, Martin Short e della più giovane Selena Gomez. Ormai giunta alla quarta stagione, la serie, come vi dicevo qualche settimana fa, mi era sembrata sulle prime aver perso un po’ del proprio smalto, soprattutto perché il meccanismo narrativo alla base della trama pareva ripetersi sempre uguale. Il primo episodio della nuova stagione, infatti, non mi aveva entusiasmato e ve l'avevo fatto notare. Tuttavia, devo subito ricredermi con questi due episodi successivi, il secondo e il terzo della quarta stagione, che mi sono sembrati molto frizzanti e capaci di introdurre qualche idea nuova. Devo ammettere che già il primo episodio si era concluso in modo promettente, con un omaggio plateale a C'era una volta il West di Sergio Leone; ma negli episodi successivi si continua a giocare con lo spettatore in modo ancora più esplicito, scherzando sia sulle trame della serie che sugli attori stessi. Ad esempio, è molto divertente il meccanismo che coinvolge l'interazione tra i personaggi a cui siamo abituati e gli attori che dovrebbero interpretarli in un film basato sulla loro storia. In questo contesto, compaiono ad esempio sulla scena Eva Longoria, Zach Galifianakis ed Eugene Levy, impegnati a interpretare loro stessi. Inoltre, ogni episodio è un evidente omaggio a un classico del cinema, vecchio o nuovo che sia, replicandone almeno in parte lo stile: così ci si trova davanti a un continuo gioco di rimandi che lo spettatore è chiamato a scoprire minuto dopo minuto. Insomma, se da un lato la serie ripropone più o meno sempre la stessa trama gialla, dall'altro arricchisce ogni episodio di dettagli accattivanti, pensati soprattutto per i cinefili, che personalmente trovo irresistibili. Dopo un inizio un po' incerto, ora sono insomma più coinvolto e motivato a proseguire con lo show. Se vi interessa, lo trovate su Disney+.
Brooklyn Nine-Nine, tutta la prima stagione (2013-2014), di Dan Goor e Michael Schur, con Andy Samberg, Melissa Fumero, Andre Braugher: chi segue questa newsletter forse ricorderà che parecchi mesi fa vi ho parlato dell'ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine, una serie TV comica che si è conclusa da tempo negli Stati Uniti. Se il mio archivio non mi tradisce, l'ultima volta in cui ho menzionato questo titolo è stato a gennaio 2023, quindi quasi due anni fa, recensendo gli episodi finali che hanno chiuso quella fortunata serie. Da allora sono successe diverse cose, e la più importante, forse, è stata la scomparsa prematura di Andre Braugher, deceduto nel dicembre 2023 a soli 61 anni a causa di un cancro ai polmoni. Per noi appassionati del telefilm, la notizia ha portato un inevitabile momento di lutto, poiché Braugher era una delle colonne portanti dello show. Qualche giorno fa, però, io e la mia famiglia abbiamo sentito il desiderio di rivedere Brooklyn Nine-Nine ripartendo dal primo episodio, andato in onda ormai più di dieci anni fa, nel 2013. E, sapete com'è: quando una serie è divertente, un episodio tira l'altro. Così, in breve, ci siamo ritrovati a riguardare tutta la prima stagione per intero, riscoprendo vecchie trame che non ricordavamo da tempo. Forse la prima stagione non è nemmeno la migliore della serie, poiché il programma è cresciuto e si è affinato con il tempo. Tuttavia, già qui troviamo molti degli elementi che caratterizzano la sua comicità, con i personaggi già ben definiti nelle loro manie e nei loro pregi. Una menzione speciale, rivedendola, va secondo me a Boyle, il personaggio interpretato da Joe Lo Truglio, che riesce a essere tenero e imbarazzante allo stesso tempo. Se non l'avete mai vista, vi consiglio di darle una possibilità: Brooklyn Nine-Nine è una serie poliziesca e comica ambientata in un immaginario distretto di polizia di Brooklyn, in cui il capitano è un uomo di colore omosessuale, il detective principale ha l'età mentale di un ragazzino, il sergente è un palestrato con numerose fobie e la detective principale soffre di una lieve forma di disturbo ossessivo-compulsivo. Insomma, niente male. La trovate su Netflix.
Quello che ho pensato
Questa settimana vorrei riflettere con voi su un fenomeno che riguarda il mio settore, quello della creazione di contenuti culturali sul web. E soffermarmi in particolare su un fenomeno che ho notato per la verità da parecchi mesi, ma che, a mio avviso, si è intensificato di recente. Se dovessi dargli un nome, lo definirei così: la “perdita del senso dell'imbarazzo”.
Negli ultimi tempi, varie cose mi hanno spinto a notare questa tendenza in modo più forte. Ne cito un paio. La prima riguarda un brano scritto da Luca Bizzarri, noto comico e attore televisivo, tratto dal suo libro Non hanno un amico, pubblicato pochi mesi fa. Non seguo Bizzarri con assiduità, quindi non conosco a fondo la storia di questo volume, ma sembra essere una raccolta di brevi testi che l’attore ha scritto per il suo podcast, commentando sarcasticamente alcuni fatti di cronaca. Il capitolo che mi hanno fatto leggere – ma forse a questo punto il libro lo comprerò e lo leggerò per intero – tratta di una notizia di qualche mese fa, riguardante una mamma tiktoker che si lamentava sul web per i troppi compiti assegnati al figlio. Credo che la notizia, se volete recuperarla per intero, fosse questa.
Bizzarri commenta la vicenda come al solito con un certo sarcasmo, ammettendo che forse i professori in questione erano troppo esigenti, ma sottolineando anche come, venti o trent’anni fa, un ragazzo la cui madre lo avesse difeso pubblicamente si sarebbe vergognato a morte, venendo deriso per mesi, se non per anni, dai propri compagni.
Il secondo esempio non è specifico, perché non voglio attaccare qualcuno in particolare, ma piuttosto fotografare un fenomeno; quindi rimarrò sul vago, ma credo sia facile per ognuno di voi identificare un esempio più specifico e attinente. Ormai, su ogni social network – che sia Instagram, TikTok o YouTube – prima o poi compare il creator che si confessa apertamente col suo pubblico, raccontando le proprie debolezze, le proprie fragilità, le proprie crisi di mezza età, le proprie disgrazie e così via. E questo, si badi bene, accade anche e soprattutto quando il creator non si occupa di psicologia o benessere, ma magari di sport o politica, di temi che cioè non hanno teoricamente nulla a che fare con lo sfogo in questione.
Queste confessioni, che toccano temi personali e intimi, mi lasciano sempre un po’ perplesso: da un lato sembrano sincere, e do per quasi certo che lo siano, non sentendomi in grado di giudicare l'intimità di persone che non conosco; dall'altro, mi chiedo se talvolta non ci sia però anche un po’ di furbizia dietro a queste confessioni a cuore aperto, poiché, dati alla mano, questi video diventano rapidamente virali, generano numerosi commenti positivi e incoraggianti e aumentano, insomma, l'engagement.
Probabilmente la verità sta nel mezzo: alcuni lo fanno perché hanno bisogno di sfogarsi, senza pensare alle conseguenze; altri, invece, non riescono più a distinguere ciò che è utile dal punto di vista imprenditoriale da ciò che è utile a livello personale, e quindi quando hanno l’istinto di sfogarsi non lo frenano, lasciando che sfoci sul web in tutta la sua potenza, sapendo sotto sotto che quello sfogo avrà un ritorno, quantomeno in termini di sostegno emotivo da parte dei fan.
Al di là di tutto questo, ciò che mi interessa analizzare non è però il fine con cui si fanno queste cose, quanto piuttosto la palese mancanza di imbarazzo che permea queste confessioni. In altre parole, parafrasando Bizzarri: se venti o trent’anni fa avessi fatto una confessione pubblica del genere, sarei stato deriso a vita. I miei compagni di classe, solo per fare un esempio, sarebbero stati crudeli nel deridermi dopo essermi pianto addosso per trenta minuti davanti al mondo intero.
Qualcuno dirà che questo, in realtà, è un segno di miglioramento, perché ora anche gli uomini possono mostrare le proprie debolezze senza vergognarsene, vivendo in un ambiente meno tossico e più accogliente. E in parte questo è sicuramente vero, ma solo in parte. È proprio qui infatti il punto focale di quello che intendo dire: siamo passati dall’eccesso di volerci mostrare sempre forti e invulnerabili all’eccesso opposto, a una fase in cui mostrare ed esibire le proprie fragilità è diventata quasi una norma, senza tenere nulla per sé.
È ovvio che dietro a questo c’è il peso del web, che tende ad amplificare tutto, ma mi sembra che ci si debba comunque soffermare un attimo su questa perdita di vergogna, soprattutto per i suoi esiti dannosi.
Faccio un altro esempio, di natura più commerciale. Se guardate spesso YouTube, avrete notato che ci sono sponsor ricorrenti nei video di molti creator: ad esempio, compaiono spesso aziende che sponsorizzano servizi di VPN o psicologi online. Alcune di queste aziende nei mesi scorsi hanno contattato pure me, il che dimostra il loro interesse a sponsorizzare a largo raggio tutta una serie di creatori di video; io, personalmente, non accetto sponsorizzazioni, quindi ho declinato la gentile offerta, ma è vero che queste sigle sono ormai dappertutto.
Di per sé non c’è nulla di male in queste sponsorizzazioni; e probabilmente, anzi, i servizi offerti sono ottimi. Quello che mi perplime, però, è come queste sponsorizzazioni a volte vengano integrate nei video di persone che normalmente si occupano di tutt’altro. Anche perché in certi casi questi spot somigliano più a televendite che a vere pubblicità: il creator, che magari si occupa di intrattenimento o tecnologia, improvvisamente inizia a parlare di salute mentale e invita il suo pubblico a usufruire di una fantastica offerta per un servizio di psicoterapia. Insomma, l’esito in certi casi è un po’ ridicolo, e l’improvviso interesse per il benessere mentale pare non del tutto sincero.
Una volta, queste cose sarebbero state prese in giro fino allo sfinimento, come accadeva con i programmi comici che ridicolizzavano Giorgio Mastrota e le sue televendite di materassi. Oggi, però, la questione è un po’ più ambigua: non si vendono più materassi, ma in certi casi si fa leva sulle fragilità psicologiche delle persone a fini commerciali. Non c'è nulla di moralmente sbagliato nel vendere un materasso ortopedico (a meno non si usino tattiche fraudolente), ma la cosa è meno lineare e liscia, a mio avviso, quando si passa a parlare di debolezze psicologiche. Certo, questi spot sono spesso delicati e gli autori fanno molta attenzione a non esagerare, ma mi chiedo comunque perché nessuno li prenda in giro, perché non esistano più sketch comici che li ridicolizzano: perché qualcosa per cui prenderli in giro, in effetti, ci sarebbe.
Questi casi, per quanto diversi, sono accomunati da un unico filo rosso: una parte del pubblico, soprattutto i giovani sui social, sembra aver perso il senso del ridicolo, il senso dell’eccesso, e di ciò che dovrebbe essere, forse, deriso.
Questo fenomeno è legato, mi pare, a un cambiamento dei costumi della nostra epoca. Molti sociologi hanno sottolineato come il nostro sia forse il “tempo del piagnisteo”: ognuno ha qualcosa di cui lamentarsi e si sente in diritto di farlo. Ma questa lamentazione raramente riguarda problemi sociali; più spesso, è incentrata su vicende personali, come i litigi con gli amici o il proprio malessere psicofisico. Paradossalmente, anche quando si affronta un tema politico, come la guerra in Medio Oriente, ci si lamenta più di come quella guerra ci fa sentire piuttosto che della guerra in sé.
Questo eccesso di soggettivismo, questo percepire ogni evento come una questione personale, si riflette anche sui libri, sulla tv, sui social. E perfino su certi libri di storia. La settimana scorsa ho parlato proprio qui nella newsletter del saggio Caro presidente, ti scrivo di Michela Ponzani, basato sulle lettere inviate lungo gli anni ai vari Presidenti della Repubblica. Anche in quel testo, però, notavo di come si parli più di come l'autrice o come i testimoni si sentano davanti ai fatti storici, piuttosto che dei fatti stessi. È come se avessimo rinunciato a un’analisi oggettiva degli eventi per concentrarci solo su come li percepiamo emotivamente.
Tutto ciò favorisce il sentimento, ma anche le lamentele e le confessioni a cuore aperto, senza più preoccuparsi di come verranno recepite dagli altri. Anche perché gli altri sembra non abbiano più alcun diritto di giudicarci. Se in passato esageravamo con la paura del giudizio altrui, oggi sembriamo quasi sospinti a non trattenere nulla per noi stessi.
Tuttavia, mi chiedo se questo cambio di paradigma, spinto alle estreme conseguenze, sia davvero sano. Oggi pare che le uniche persone che si possano prendere in giro siano i politici. La satira su Salvini, Meloni, Schlein e Conte abbonda, ed è un bene, perché ci aiuta a evidenziare le contraddizioni del potere. Ma forse sarebbe utile prendere un po’ più in giro anche l’uomo comune, anche noi stessi, perché non è che noi siamo in ultima istanza poi tanto migliori dei nostri politici.
La presa in giro intelligente è una forma di educazione, perfino filosofica (ed è stata usata, non per nulla, da maestri del pensiero come Socrate, Voltaire, Nietzsche e altri ancora): ci aiuta a demitizzare, a riflettere criticamente. Perché, dunque, nessuno fa satira su quei creator che, da un lato, esaltano la performance e il successo e, dall’altro, invitano a rivolgersi a uno psicologo, magari guadagnandoci una percentuale? Non è una contraddizione che merita di essere messa almeno un po’ alla berlina? E perché nessuno, anche nei commenti ai loro video, li prende in giro?
Se dovessi avanzare un’ipotesi di risposta, direi che forse alcuni non percepiscono più come imbarazzanti quei discorsi. Ci imbarazziamo tutti molto meno di un tempo. Da ragazzino, lo ricordo bene, vivevo nella paura di fare qualcosa di profondamente sbagliato e venire preso in giro: di vestirmi male, fare delle gaffe tremende e altro ancora. Poi ovviamente quelle cose le facevo lo stesso e magari nessuno se ne accorgeva, però certo mi preoccupavano. E preoccupavano tutti i miei coetanei: sentivamo l’occhio del nostro vicino su di noi. Quelle pressioni sociali, chiamiamole così, ci angosciavano ma ci spingevano anche a cercare di essere migliori: in fondo era anche tramite quelle pressioni che imparavamo a gestire i diversi contesti sociali, a stare al mondo e a sopravvivere.
Oggi i ragazzi si imbarazzano molto meno: essere “strani” è più cool, più facilmente accettato. E questo è indubbiamente un bene, in moltissimi casi; e però a volte la totale rinuncia al senso dell’imbarazzo può essere deleteria. Solo per fare un esempio: oggi un ragazzo può mostrare tranquillamente la propria omosessualità, e questo è sano e liberatorio (mentre era assai dannoso il modo in cui una volta doveva mascherare il proprio essere), ma oggi un ragazzo può anche spiattellare davanti a tutti anche cose intime (con chi sta e con chi non sta, e anche cosa fa), mettendo in difficoltà le persone amate. L’oscurità non è un bene, ma neppure la completa trasparenza lo è.
So che la satira può ferire, essere offensiva e talvolta eccessiva, e non voglio difendere questi eccessi. Ma rinunciare completamente alla presa in giro significa accettare tutto, dire che va sempre tutto bene, che ognuno ha ragione anche quando non ce l'ha, che ciò che conta è solo come ti senti, e non come stanno davvero le cose. È importante come ci si sente, ma il sentimento non è tutto: ci sono anche i fatti. E forse sarebbe utile che qualcuno ce lo ricordasse ogni tanto.
Quello che ho registrato e pubblicato
Ed ora spazio ai video e ai podcast che sono usciti questa settimana.
Cosa direbbero i filosofi sulla cittadinanza: abbiamo provato a interrogare (virtualmente) gli antichi filosofi su un tema di grande attualità
Storia della mafia (parte 2): seconda e ultima puntata dedicata alla storia della più famosa organizzazione criminale italiana
Storia dei consumi 16: Debiti e credito nei consumi: la crescita dei consumi è legata anche all’aumento dell’accesso al credito, e qui vediamo come
Leibniz e l'armonia prestabilita (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
L'ascesa del nazismo in Germania (per il podcast “Dentro alla storia”)
Hitler giunge al potere (per il podcast “Dentro alla storia”)
Quello che devi fare per seguirmi sui social
Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:
Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads
Quello che puoi fare per sostenere il progetto
Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.
Lo spirito delle leggi di Montesquieu: stamattina, spiegando in una mia quarta l’importanza del pensiero illuminista per la storia d’Europa, mi sono dovuto per forza soffermare su Lo spirito delle leggi, il testo di Montesquieu che ha di fatto posto in essere quella divisione dei poteri che oggi è alla base di ogni stato occidentale. Leggere quel libro, quindi, è ancora oggi particolarmente importante ed è stato inevitabile segnalarlo anche qui, tra i grandi classici della storia della filosofia; anche perché si tratta di un volume che è invecchiato tutto sommato piuttosto bene. Procuratevelo e leggetelo, dunque: lo si può acquistare qui.
sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):
C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.
Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!
Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:
Quello che c’è in arrivo
E chiudiamo, come al solito, con qualche anticipazione su quello che sta per arrivare sul web:
domani, in primo luogo, partiremo con un video breve dedicato a Guernica, il celebre capolavoro di Pablo Picasso che tanti legami ha con la storia del Novecento;
mercoledì e giovedì arriveranno poi i nuovi episodi dei due podcast, con una puntata incentrata, in filosofia, sull’innatismo di Leibniz e una, in storia, sull’antisemitismo nazista;
venerdì e sabato, invece, faremo probabilmente una pausa: tra qualche riga vi spiego perché;
domenica sarà poi la Giornata mondiale del fallimento, e la celebreremo con un breve video apposito;
lunedì prossimo, infine, vorrei proporvi un nuovo video dedicato alla lettura integrale del Candido.
Ma perché la pausa tra venerdì e sabato? Semplice, perché mentre rileggevo questa newsletter, pronto a inviarla, mi è arrivata la notizia che domattina dovrò partire per la Germania. Ero infatti accompagnatore di riserva per uno scambio culturale di una mia classe con la città di Freising, in Baviera, e però per una serie di incroci sfavorevoli dovrò all’ultimo momento partire. Non avevo quindi abbastanza video già pronti da riempirvi la settimana, e certo non riuscirò a realizzarvi in Germania, quindi giocoforza il canale si prenderà un paio di giorni di pausa. Magari vi allieterò con qualche foto bavarese sui social network.
Prima di salutarci e andare a fare la valigia, però, vi ricordo anche qualche veloce appuntamento. Primo: martedì alle 17:30 andrà in onda su TVA (canale 832 di Sky, ma sarà poi disponibile anche su YouTube) la seconda parte del mio intervento sull’intelligenza artificiale, quindi non perdetelo. Secondo: per chi abita a Rovigo domenica prossima, il 13 ottobre, alcune studentesse della mia attuale quinta, la 5ª ASA del Liceo Scientifico “Paleocapa”, introdurranno una mattina dedicata a Giacomo Matteotti e al tema della Giustizia. L’appuntamento è per le ore 11 del mattino presso l’Auditorium Tamburini di via Pighin, a ingresso libero. Io dovevo esserci ma purtroppo sarò in Germania; comunque le ragazze sono bravissime e meritano attenzione. Dopo le loro letture, ci sarà tra l’altro spazio per le musiche di Mozart, Castelnuovo-Tedesco e Respighi. Non mancate.
Per il resto, ci rivediamo qui lunedì prossimo. Auf Wiedersehen.








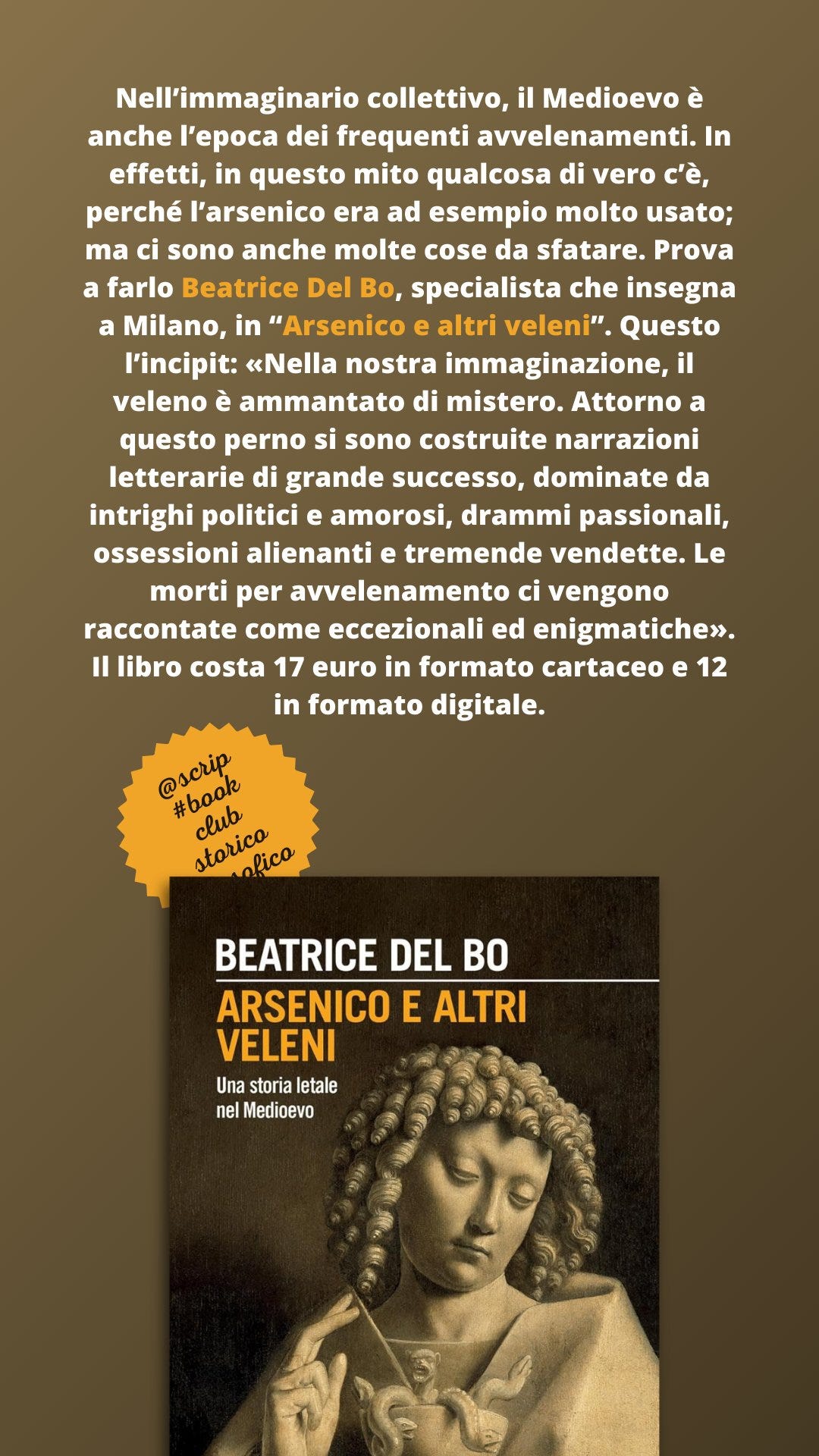
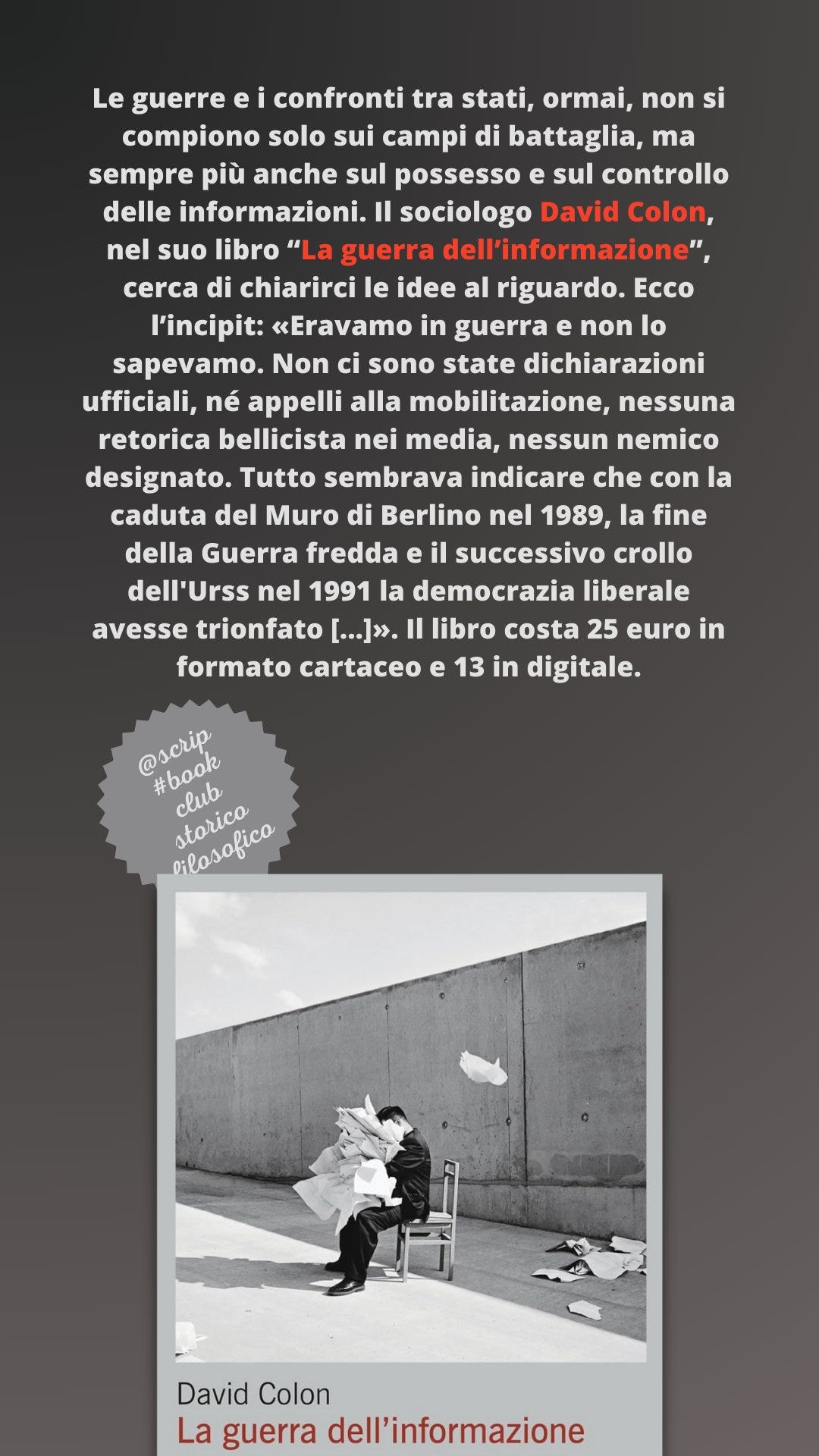
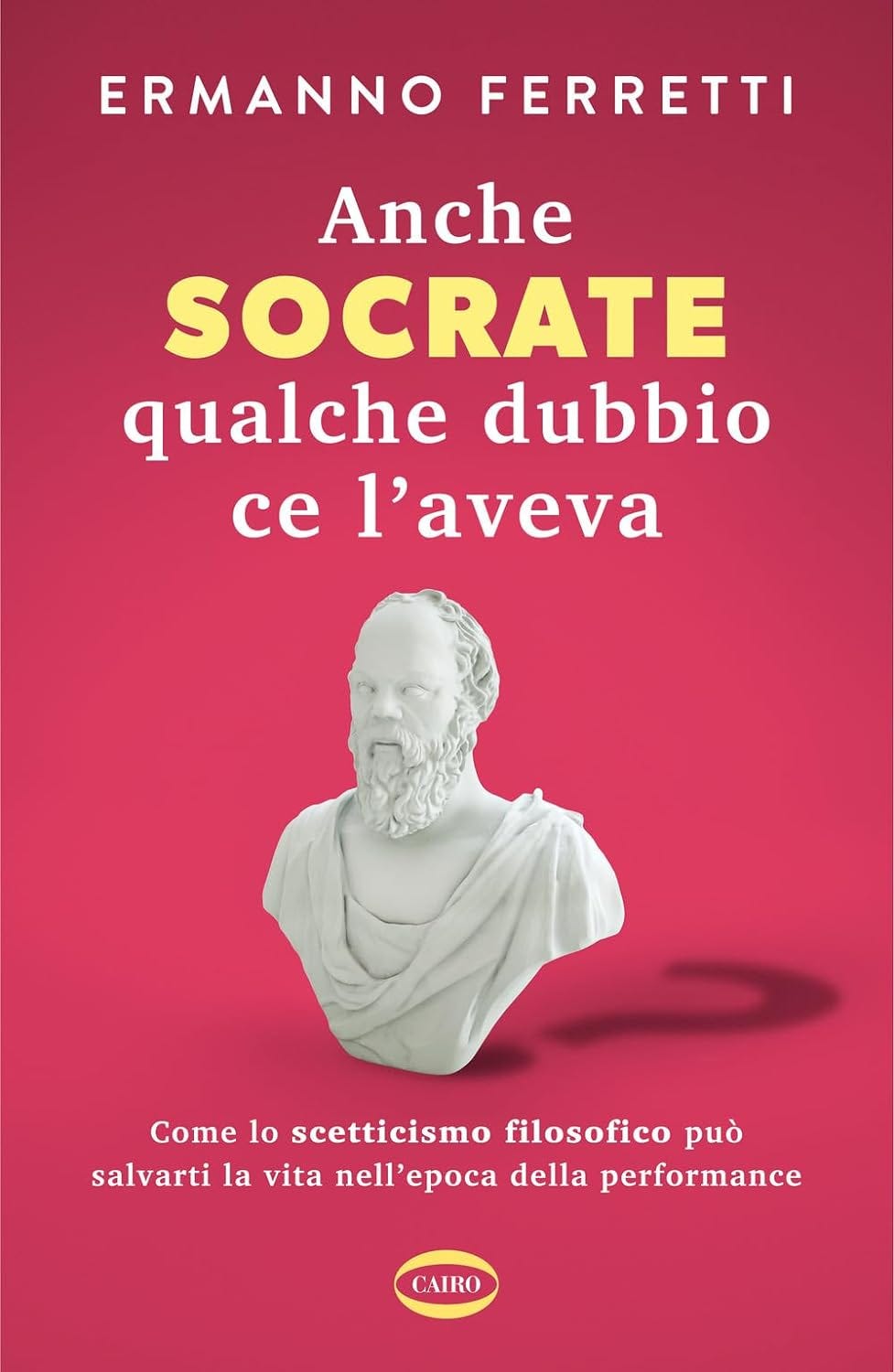
Professore , siccome lei scrive nella newsletter non soltanto di quello che ha pensato , ma anche i libri e i film che ha guardato , le voglio suggerire di guardare un film "Fascisti su Marte".
Vivo all estero e non ho grande interesse per la politica . Sento parlare di pericolo fascistaa proposito del governo Meloni . Voglio proporre una cura filosofica a quelli che si sentono angosciati dal rischio di un governo fascista . Ammesso enon concesso che in italia incomba il rischio di un goverrno fascista , "Fascisti su Marte " di Corrado Guzzanti mi sembra lo strumento adatto ad approccio condotto con distacco filosofico . Il film di Corrado Guzzanti descrive un ipotetica conquista di Marte avvenuto durante il Fascismo , con i toni dell Istituto Luce . Suggerisco di provare a ricordare
nell eventualita´che alcune dichiarazioni della Meloni ricordino il Fascismo con il tono e il modo di porsi del film di Guzzanti . Se vuole darmi un parere sulla mia cura filosofica puo´ scrivermi a karersee200@yahoo.it .