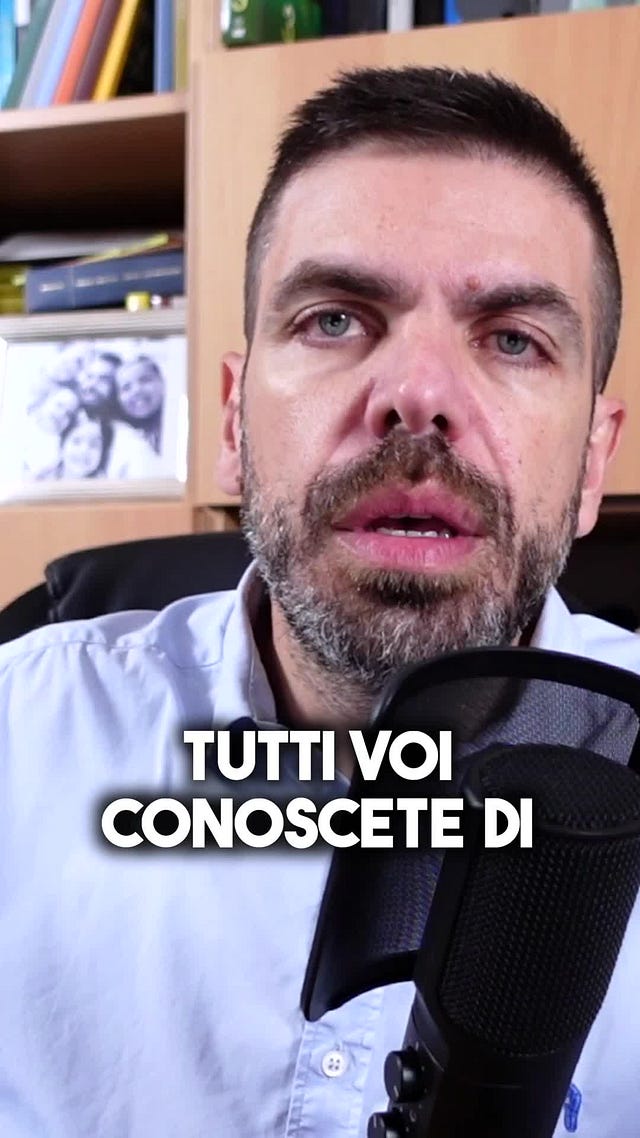Le Olimpiadi dello scetticismo con Julio Velasco e Benedetta Pilato, ma parliamo anche di Alain Delon, Umbrella Academy, Inside Out 2, Robert De Niro, la guerra civile americana, i cognomi e Bauman
Rieccoci qua, cari amici, col Ferragosto che è ormai archiviato e l’estate che sta per finire. Per me questa è l’ultima settimana di ferie, anche se in realtà ho lavorato sempre, per tutta l’estate: ma formalmente da lunedì prossimo si torna a scuola, con esami di recupero, scrutini, riunioni e tutto il resto.
Sarà un anno particolare, almeno dal punto di vista personale: oltre a mio figlio, che ormai sarà in quarta, arriverà nel mio liceo anche la secondogenita. Frequenterà una delle nuove classi prime, e me la vedrò così a bazzicare le aule del liceo in cui insegno. Ma non sarà un ingresso traumatico: se si comporterà come il fratello maggiore, probabilmente per tutto il primo anno farà finta di non conoscermi, quando ci incroceremo nei corridoi.
Sarà sicuramente un anno intenso anche per il grande progetto che stiamo portando avanti assieme sul web. Sul canale continueranno a uscire video e podcast, come di consueto, al ritmo di uno al giorno; inoltre, proseguirà (e anzi partirà) la campagna di promozione di Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva: stiamo organizzando alcuni incontri in giro per l’Italia, e se lavorate in librerie o associazioni culturali, fatevi sentire.
Ma poi sto lavorando intensamente ad altri progetti sia per il web che per il “mercato editoriale”, chiamiamolo così. È presto per darvi ulteriori dettagli, ma ci sarà molto da leggere, da vedere e da studiare nei prossimi mesi: tenetevi pronti.
Ma adesso torniamo alla newsletter, che come al solito è piena di cose di cui parlare.
Quello che ho letto
La sezione letteraria di questa settimana è molto storico-sociale: c’è un romanzo ottocentesco legato alla storia d’Italia, c’è un saggio storico sempre sul nostro paese e c’è infine un libro di sociologia che ho appena finito. Procediamo.
Per tutti i gusti di Zygmunt Bauman: tra i vari libri di questa settimana, devo dirvi che ho finito Per tutti i gusti, il saggio di Bauman di cui vi ho parlato nelle ultime settimane. Il mio giudizio, alla fine, è un po’ agrodolce: il libro presenta sprazzi di idee molto lucide e intriganti, ma le annacqua anche con discorsi un po’ banali o fuori tema, che fanno perdere il filo del discorso. Alla fine, non ho neppure capito troppo bene quale sia il vero tema del volume: il multiculturalismo? L’industria culturale? Entrambe le cose? Questo senza nulla togliere al valore di Bauman, sociologo che ha dato tanto a questa disciplina, ma che qui mi pare non sia incappato nel suo miglior lavoro. Ad ogni modo, il libro può essere comunque interessante se ci si vuole avvicinare in modo semplice e veloce (visto che il volumetto è molto breve) al pensiero dello studioso polacco. Lo si può comprare qui.
I cognomi degli italiani di Roberto Bizzocchi: nei giorni scorsi mi è capitato tra le mani questo breve saggio storico che sembra voler fare il punto sulla storia dei cognomi italiani. Come si scopre in realtà poi leggendo l’introduzione, l’autore, professore dell’Università di Pisa, chiarisce che la sua intenzione non è tanto quella di spiegare, caso per caso, da dove traggono origine i singoli cognomi, ma piuttosto offrire una storia generale su quando si è cominciato a usare i cognomi nella nostra penisola. Il libro è interessante, anche se, a mio parere, molto specialistico: il titolo potrebbe far pensare a un’opera ideata per il grande pubblico, che è sempre curioso di scoprire qualche aneddoto sul proprio cognome, ma in realtà è un testo più adatto agli universitari, e forse anche ai professori universitari. Comunque, è ben scritto, per ora. Ve ne parlerò ancora. Se intanto vi interessa, potete acquistarlo qui.
Le confessioni d’un italiano di Ippolito Nievo: vi ho già raccontato probabilmente decine di volte de Le confessioni d’un italiano di Nievo. L’ho cominciato, infatti, più di un anno fa, e periodicamente lo porto avanti e poi lo lascio lì a prendere un po’ di polvere. Comunque negli ultimi giorni mi è ritornato tra le mani e ho deciso di dedicarmici con rinnovato vigore, tanto che ormai sono in dirittura d’arrivo, visto che mi mancano solo una settantina di pagine (su quasi mille di romanzo). Di cose, a livello di trama, ne sono successe a bizzeffe: Carlo, il protagonista, è ormai invecchiato e ha subito anche qualche lutto importante; è stato arrestato come rivoluzionario, è stato malato fino a diventare quasi cieco, è stato perfino esule a Londra. Ora si appresta a tornare in Italia, e addirittura a Venezia, negli anni '20 dell’Ottocento, all’inizio di quel periodo risorgimentale che lo stesso Nievo visse da protagonista. Il romanzo è molto ottocentesco, pieno di romanticismo, patriottismo e slancio spirituale; ma è anche autoironico quando serve, ci mostra una discreta evoluzione dei personaggi e ci dà anche un bello spaccato di cosa pensavano gli italiani – o almeno alcuni italiani – di un paio di secoli fa. Lo potete comprare qui.
Quello che ho visto
Nell’elenco degli audiovisivi di questa settimana ci sono due film e una serie, in uno strano mix di nuovo e (parzialmente) vecchio. Vediamo.
Inside Out 2 (2024), di Kelsey Mann: finalmente sono riuscito anch’io a vedere Inside Out 2. Lo so, sono arrivato per ultimo, visto che il film della Pixar ha battuto diversi record d’incasso, ma alla fine ce l’ho fatta. E direi che ne è valsa la pena: il film, infatti, non ha per nulla deluso le mie aspettative. Già mi era piaciuto molto il primo capitolo della saga, che avevo trovato a suo tempo intelligente e delicato, ma il suo seguito non mi pare essere da meno. Come nel film di nove anni fa, anche questa volta gli sceneggiatori sono riusciti, a mio avviso, a rappresentare molto bene ciò che accade dentro ognuno di noi in alcuni momenti cruciali della vita, come ad esempio quando comincia la pubertà. Se siete tra i pochi che non l’hanno visto, ecco una breve trama (senza troppi spoiler): Riley, la protagonista del primo film, è cresciuta e ora ha 13 anni, pronta a fare il grande salto dalle scuole inferiori al liceo. Questo cambiamento, però, si accompagna a due eventi: primo, l’improvviso arrivo appunto della pubertà, con nuove emozioni che cercano di prendere il controllo della sua psiche (si tratta di ansia, invidia, imbarazzo, noia: ne parlavamo anche noi qui); secondo, un weekend formativo organizzato da una importante coach di hockey, che potrebbe aiutarla a entrare nel team liceale. Tutte queste sollecitazioni si sommano insieme, portando Riley a comportamenti nuovi e non sempre felici, ma anche a un vero e proprio conflitto interiore, rappresentato dalla lotta tra le emozioni del primo film (gioia, tristezza, rabbia, disgusto e paura) e quelle nuove. Il film riprende quindi il discorso interrotto nove anni fa, senza ripetersi troppo e aggiungendo qualche momento comico particolarmente riuscito (il marsupio che ricorda sia lo zainetto di Dora l’esploratrice che lo Strumentopolo della Casa di Topolino mi ha fatto provare molta nostalgia per quando avevo i bambini piccoli) e anche qualche momento toccante. Bello bello bello: dopo alcune prove un po’ incolori della Pixar, un filmone del genere ci voleva. Se siete fortunati, potete trovarlo ancora al cinema.
The Umbrella Academy episodio 1.01 (2019), di Steve Blackman, con Tom Hopper, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman: ormai, coi figli che crescono, mi sono abituato all’idea che possano guardare film o, soprattutto, serie tv per conto loro. Ci sono però alcune serie che, negli anni, abbiamo cominciato a vedere assieme e che continuiamo, stagione dopo stagione, a guardare rigorosamente tutti assieme, come in un piccolo rituale familiare. Sto pensando a serie come Friends (il mio figlio più grande credo l’abbia rivista tutta almeno tre volte), Stranger Things, Dark, Lost e poche altre. Tra queste c’è anche The Umbrella Academy, serie molto strana che ha esordito su Netflix nel 2019 e di cui sono usciti proprio in questi giorni gli episodi della quarta stagione, dopo due anni di attesa. Le prime tre stagioni le abbiamo viste tutte, e io a suo tempo ho pure letto il fumetto da cui lo show era stato tratto; ma, proprio per via dell’estrema complessità della trama, non ricordo proprio tutto, e lo stesso può dirsi dei miei figli, che non erano sicuri di quale destino fosse toccato ai protagonisti alla fine degli ultimi episodi visti. Insomma, prima di vedere i nuovi episodi ci siamo detti che sarebbe stato bene fare un rewatch, come si dice oggi, cioè rivedere tutte le vecchie puntate per rinfrescare i ricordi; o almeno provarci. E così abbiamo cominciato intanto dalla prima puntata, dall’episodio pilota, in cui si presentano i protagonisti e si vede già all’opera quel fantastico personaggio che è Numero 5. Tutte le stagioni (anche quella nuova) sono presenti su Netflix.
Il Gattopardo (1963), di Luchino Visconti, con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale: lo sapete credo tutti, perché era sulle prime pagine di tutti i giornali (cartacei e online), detto e ridetto dai telegiornali e perfino riproposto sui social, almeno su quelli frequentati da gente di una certa età come il sottoscritto: domenica è venuto a mancare Alain Delon, sex symbol e grande attore che realizzò i suoi film più importanti negli anni '60. Come spesso accade in questi casi, appena saputa la notizia mi è venuta voglia di rivedere l’interprete francese in uno dei suoi film più importanti; e scartabellando un po’ sul web mi sono presto reso conto che su RaiPlay era disponibile Il Gattopardo, il capolavoro del 1963 diretto da Luchino Visconti a partire dall’altrettanto famoso romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tra l’altro, mi dicono che poi a sera RaiUno l’abbia anche trasmesso nella sua programmazione normale, per omaggiare l’attore francese. Il film è sontuoso e lunghissimo, come forse già sapete: dura tre ore, cosa che all’epoca non era certo comune, e si presenta come un grande affresco della Sicilia risorgimentale. Le vicende prendono avvio praticamente dal momento dello sbarco in Sicilia dei garibaldini, durante l'impresa dei Mille; passano poi attraverso il plebiscito che porta la Sicilia ad unirsi al resto del Regno d'Italia; per concludersi infine nei primi anni post-unitari, col passaggio di molti notabili siciliani a servizio del Parlamento italiano e di Vittorio Emanuele II. Il film, come il libro, dipana la sua narrazione su due livelli principali: da un lato ci sono le vicende familiari, legate in particolare alla affascinante figura del principe di Salina, interpretato da Burt Lancaster, vecchio patriarca che cerca di far sì che tutto nella sua famiglia e nel suo paese resti come prima, riuscendoci anche piuttosto bene, considerando che riesce anche a preparare un destino florido per il nipote, l’arrembante Tancredi (interpretato proprio da Delon); dall'altro, c'è l'acutissima critica sociale che già Tomasi aveva portato avanti nel suo romanzo, una critica che mostra come il Risorgimento italiano sia stato in pratica una rivoluzione mancata, come già aveva sottolineato Antonio Gramsci, un movimento anche a tratti di popolo che però vide sostanzialmente tradite le sue aspirazioni più radicali, e che non fece altro che confermare al potere e quello stesso ceto dirigente che già governava anche prima del percorso unitario. Tutti questi diversi piani di lettura, poi, si mescolano tra loro in un modo che affascina l'occhio, come spesso accade nelle opere di Visconti, e non può lasciare indifferenti. A rivederlo oggi, a tantissimi anni dalla sua realizzazione e, nel mio piccolo, ad almeno una ventina d’anni di distanza dall'ultima volta che l'avevo visto, si presenta ancora come un film estremamente potente, che cattura l’attenzione. Lo trovate, come detto, su RaiPlay.
Quello che ho pensato
Avete seguito i Giochi Olimpici di Parigi, che si sono conclusi lo scorso 11 agosto? Avete esultato per le vittorie italiane, urlato contro il cielo per i quarti posti, condiviso i meme sul cecchino turco e infine partecipato alle solite polemiche da social network, partendo da quella sulla cerimonia d’apertura quasi blasfema e concludendo con la questione della pugile algerina Imane Khelif?
Sì, le Olimpiadi sono sempre un rito collettivo, e lo sono state ancora di più in quest’edizione: tre anni fa, a Tokyo, eravamo ancora un po’ reduci dell’esperienza del Covid, e avevamo forse poca voglia di scherzare; sette anni fa, a Rio de Janeiro, la moda dei meme non era ancora così tanto forte e diffusa. E allora questa volta tutto quello che è emerso a Parigi è rimbalzato fino allo sfinimento sui nostri lidi.
Ma l’aspetto secondo me più interessante di questi Giochi, su cui mi vorrei soffermare oggi, è legato al tema della performance. Da questo punto di vista, i fatti più significativi sono stati, credo, due: primo, i festeggiamenti di Benedetta Pilato, diciannovenne tarantina che è arrivata quarta nei 100 metri rana; secondo, la vittoria dell’oro, nell’ultimo giorno della competizione, della squadra femminile di pallavolo trainata da un immortale Julio Velasco.
Facciamo un rapido riassunto di queste due situazioni, per chi se le è perse. Partiamo dalla Pilato: la giovane nuotatrice pugliese, già medaglia d’oro ai Mondiali e appena diciannove anni sulla carta d’identità, si è vista sfuggire il bronzo olimpico per un nonnulla. Durante la gara dei 100 metri rana, infatti, ha concluso con un solo centesimo in più rispetto alla terza classificata; una differenza talmente microscopica da lasciare, spesso, con l’amaro in bocca. La ragazza, però, si è presentata al microfono delle televisioni sorridente e contenta per la prestazione e per l’occasione di rappresentare l’Italia alle Olimpiadi.
Fin qui tutto abbastanza normale, al massimo un po’ sorprendente. Ma davanti alle dichiarazioni di Pilato, la polemica è montata a causa di alcune frasi di Elisa Di Francisca. Quest’ultima – ex schermitrice a sua volta campionessa olimpica, impegnata a commentare i Giochi per la tv – è in un certo senso sbottata, incredula davanti alla felicità della ragazza: «Ma ci è o ci fa?», ha chiesto, in diretta, davanti a mezza Italia. La Di Francisca non capiva come si potesse essere contente per un quarto posto, e non ci si lanciasse invece in un interminabile pianto di delusione.
La commentatrice è stata rapidamente subissata di critiche, sui social, da parte soprattutto dei più giovani, ricevendo l’accusa di alimentare una “competitività tossica”. Le due – Di Francisca e Pilato – pare si siano poi chiarite, ma l’ex schermitrice è tornata sulla questione proprio in questi giorni, con dichiarazioni che hanno in realtà ribadito la sua posizione: «La sofferenza prepara alla vita, non l’accontentarsi […]. I ragazzi che si accontentano, i genitori accondiscendenti, la proposta di abolire i voti a scuola… Mi sembra un discorso culturale, di società che sta attraversando un cambio generazionale». Si è poi detta contro “il buonismo imperante”. Su tutto questo ritorniamo tra qualche riga.
L’altro fatto che vale la pena di ricordare è stata la vittoria della Nazionale femminile di pallavolo, che ha dominato il suo torneo arrivando a vincere per 3-0 anche la finale contro gli Stati Uniti, campioni olimpici in carica. Al di là delle bravissime atlete, sotto i riflettori è finito inevitabilmente anche Julio Velasco, l’allenatore argentino già protagonista di tante imprese nel settore maschile.
Classe 1952, Velasco allena in Italia dal 1983; con la Nazionale maschile ha vinto due Mondiali, cinque World League e due Europei. Nel suo straordinario curriculum mancava solo l’oro olimpico. Nel 1992 la sua squadra era tra le favorite, arrivando alle Olimpiadi da campione del Mondo in carica, ma venne eliminata nei quarti di finale a sorpresa dall’Olanda; quattro anni più tardi, nel 1996, arrivò fino in finale e perse di nuovo per 3-2 sempre contro l’Olanda, sempre di misura. Dettagli in una carriera piena di successi, si dirà; e in effetti a volte la differenza la fanno anche piccoli casi fortuiti, una palla che finisce sulla riga invece che fuori o cose del genere. A quei livelli, la differenza tra vincere e perdere a volte è un nonnulla, come nel caso della Pilato. Però l’oro in effetti a Velasco mancava, e adesso quella lacuna è stata colmata con una vittoria francamente esaltante.
Era scontato, dunque, che i giornalisti si recassero dall’allenatore argentino, subito dopo la vittoria, per fargli la classica domanda: «Quanto mancava questa medaglia?» Meno scontata è stata la risposta del tecnico, che ha detto che in realtà della medaglia gli importava il giusto, non troppo. E che non è quella medaglia a cambiare il valore del suo lavoro.
Ora, cosa c’è da imparare da tutte queste vicende? Varie cose, a mio avviso, magari spogliando le questioni anche di banalità e luoghi comuni, che in questi casi non mancano. Il buonismo non c’entra nulla, con buona pace di Di Francisca, che sulla questione sembra aver riflettuto poco; non si tratta di dire che un quarto posto valga quanto un primo, né di dire che non ci si debba impegnare nella vita. Nessuno sta sostenendo questo: né Pilato né Velasco, che non sono certo stupidi. Non “ci sono” né “ci fanno”. Piuttosto, mi sembrano maggiormente in grado di accettare la realtà delle cose per come si configurano.
Benedetta Pilato gareggia ad altissimi livelli da quando aveva 14 anni. Ha fatto sicuramente sacrifici enormi per arrivare là, e ha ottenuto finora risultati straordinari. Alle Olimpiadi ha sfiorato la medaglia, e non si può certo dire che non ci abbia provato. Cosa deve fare, di più? Bestemmiare, sbraitando contro la sorte? Protestare contro gli arbitri o contro i cronometristi? Sono cose a cui purtroppo gli atleti italiani ci hanno spesso abituato, tutte cose che in realtà disonorano il senso dello sport. Non è forse più maturo accettare la sconfitta, accettare di essere quarti al mondo (cosa che costituisce comunque un risultato più che eccellente), e sorridere, soddisfatti per quello che si è comunque fatto? È più maturo essere felice di essere il quarto al mondo nella propria categoria, o arrabbiarsi per non essere uno dei primi tre?
Insomma, tra Pilato e Di Francisca mi pare che la saggezza penda decisamente dalle parti della prima. Tra l’altro, la carriera sportiva prima o poi finisce, le gare lasciano spazio ad altro, magari si diventa commentatori televisivi davanti a milioni di persone che ti ascoltano: accumulare un po’ di saggezza, forse, è altrettanto importante che accumulare ori.
E in questa direzione, secondo me, vanno anche le dichiarazioni di Julio Velasco, che da questo punto di vista è un vero e proprio maestro di vita. E non lo scopriamo certo oggi: chi lo segue da tempo sa bene qual è il carattere dell’allenatore argentino, quello di un uomo serio, gran lavoratore, fermo, ma anche e soprattutto un vero leader. Non un leader autoritario, ma un maestro che sa convincere con la forza della parola, e che sa dare il giusto peso alle cose. Un maestro anche modesto e calmo, che sa accogliere la vittoria come la sconfitta.
Ecco, come più di qualcuno mi ha fatto notare, sia nella vicenda di Pilato che in quella di Velasco (e forse potremmo aggiungerci quella del “pistolero” turco, Yusuf Dikec, medaglia d’argento nella pistola ad aria da 10 metri), quello che emerge è un po’ di sano scetticismo filosofico, per come l’ho presentato anche all’interno di Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Alla fine del capitolo 5 di quel libro, infatti, ben prima di sapere come sarebbero andate queste Olimpiadi di Parigi, scrivevo queste parole:
Ricordate Momenti di gloria, il film che ho citato nella Prefazione? Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012, la London Symphony Orchestra si esibì suonando la celebre colonna sonora di quella pellicola, che per gli inglesi è sinonimo di una grande impresa sportiva. Ma l'esibizione viene ricordata soprattutto per la gag imbastita da Rowan Atkinson, l'interprete di Mr. Bean, che prima si intrufolò all'interno della stessa orchestra e poi sognò di essere uno dei corridori nella celebre scena della spiaggia. E lì annaspava, si faceva superare, imbrogliava, faceva inciampare gli altri atleti: ne combinava di tutti i colori. Riuscendo però a farci ridere e a dissacrare uno dei momenti più topici dello sport mondiale.
Perché, ancora una volta, la grandezza non si ottiene senza una risata, la vittoria non si ottiene senza una o più cadute, alla verità non si arriva se non tramite il dubbio.
Nella vita dobbiamo impegnarci, perché è bello e sano cercare di dare il meglio di noi. Ma dobbiamo anche imparare ad accettare i nostri limiti, a sapere che a volte la vittoria sfugge, che si può sbagliare, che si può non essere all’altezza o che si può anche semplicemente essere sfortunati. La vita è talmente imprevedibile che non si può dar nulla per scontato: puoi essere il più forte al mondo e, per un colpo sfortunato, arrivare quarto; puoi essere il migliore di tutti i tempi ma incappare comunque in una giornata “no”.
Se si pensa che quello che conta sia solo il risultato, si finisce per ragionare come certi navigati commentatori, che alla prova dei fatti si rivelano immaturi come un quindicenne esaltato. Se invece si pensa che il risultato sia importante, ma che non dipenda solo da noi, si è più pronti ad accettare il fallimento.
Questa linea di condotta, a essere precisi, è sia scettica che stoica. Scettica, perché accetta programmaticamente il limite, perché non dà per scontato nulla, perché non si pone al di sopra dell’imprevedibilità del mondo. Stoica, perché accetta che non tutto sia in nostro potere, e che sia anzi nostro compito accettare che le cose non dipendano del tutto da noi.
Pilato e Velasco non mi sembra non puntino in alto: competono da tutta la vita; né mi sembra che non si impegnino in quello che fanno. Semplicemente sanno che quello che fanno permette loro di arrivare solo fino a un certo punto, e che poi ci sono gli avversari (che potrebbero anche essere più forti di noi), la sorte, l’imprevedibilità degli eventi. E sanno, forse, che la nostra felicità non deve basarsi su quello che sfugge al nostro controllo, altrimenti finiamo per urlare sempre contro il cielo (o lamentarci degli arbitri).
Ecco, queste Olimpiadi credo ci abbiano insegnato qualcosa di utile, a patto che come sempre siamo disposti ad impararlo: che il segreto della felicità sta nell’accettazione; nel cammino verso una meta che può anche non essere raggiunta, ben sapendo che quel che conta è come stiamo noi e come stanno le persone attorno a noi durante questo cammino, e non eventuali traguardi o medaglie date da sconosciuti. Sembra quasi una banalità, ma evidentemente c’è bisogno di ribadirla più e più volte.
Quello che ho registrato e pubblicato
Ed eccoci ora al classico momento in cui facciamo la summa di tutto quello che è uscito, questa settimana, sul web:
Kafka tra società e burocrazia: ultimo video dedicato ai lavori di Franz Kafka, in cui lo facciamo dialogare con Weber, Benjamin e Foucault
Storia dei consumi 15: Il consumismo in Estremo Oriente: abbiamo parlato tanto di consumi, ma non abbiamo ancora visto come si diffusero in Oriente
Hume dalla morale alla politica (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
Il crollo di Wall Street del 1929 (per il podcast “Dentro alla storia”)
Scelte e scetticismo per Robert De Niro
Quello che devi fare per seguirmi sui social
Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:
Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads
Quello che puoi fare per sostenere il progetto
Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.
La guerra civile americana di Raimondo Luraghi: Raimondo Luraghi è stato un importante storico piemontese, venuto a mancare, alla veneranda età di 91 anni, ormai più di dieci anni fa. I suoi studi sulla guerra civile americana, comunque, sono dei classici e meritano di essere letti ancora oggi, perché sono invecchiati molto bene. Nel catalogo di Rizzoli si trova La guerra civile americana, un bel volume che ricostruisce cause ed eventi di quello che viene giustamente definito “il primo conflitto industriale della storia”. Lo si trova tra l’altro a un prezzo molto accessibile, attorno ai 12 euro: compratelo, se volete, qui.
sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):
C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.
Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!
Quello che c’è in arrivo
Cosa uscirà da qui in avanti, questa settimana? Ecco l’elenco (provvisorio) di quello che ho in mente:
domani partiamo con un video su Tommaso Campanella e la sua filosofia;
mercoledì e giovedì arriveranno i podcast, con la conclusione di Hume in filosofia e le soluzioni europee alla crisi del 1929;
venerdì spero di proporvi l’ultima puntata dedicata alla lettura integrale e commentata del Manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels;
sabato tornerà subito, a tempo di record, il podcast filosofico (perché le date successive sono bloccate da altre cose), con cui inizieremo a parlare di Leibniz;
domenica sarà l’anniversario della morte sia di Hume che di Nietzsche, e credo uscirà uno short per celebrare almeno uno dei due;
lunedì prossimo, infine, è già stato fissato l’incontro online con gli abbonati per il Simposio filosofico mensile: il tema prescelto è “La storia può insegnare qualcosa all’umanità o siamo destinati a ripetere ciclicamente gli stessi errori?”
E anche questa settimana siamo arrivati alla fine. Prima di salutarci, lasciate che vi ricordi, come sempre, che in tutte le librerie trovate il mio ultimo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva, sul quale continuano ad arrivarmi riscontri: tra l’altro, settembre (più ancora di gennaio) è un bel mese per cominciare a fare buoni propositi, per mettersi a leggere un nuovo saggio o anche solo per dare una piccola svolta alla propria vita, e spero che questo libro possa essere d’aiuto in questo senso. Inoltre, visto che siamo in tema di buoni propositi, vi ricordo anche che sul canale è possibile sottoscrivere l’abbonamento, che tra le altre cose vi permette – a seconda del livello, come potete scoprire qui – di partecipare alle riunioni mensili che facciamo online tramite Google Meet e che sono a mio avviso molto belle e stimolanti: le usiamo per parlare di libri e di filosofia, ma in modo molto sciolto, senza eccessivi formalismi.
E poi, ovviamente, vi ricordo anche di riposarvi e divertirvi, che è la cosa più importante. Ci rivediamo qui tra sette giorni esatti. Buona settimana!