Perché dico che ci sarebbe bisogno di un'educazione ai social network, ma parliamo anche di Carlo Magno, Umberto Eco, La mosca, Zygmunt Bauman, Kennedy, Barbero, Weil, Ed Wood, Nievo e Midnight Gospel
Vi sembrerà un po' strano, ma oggi vi scrivo da Londra. O meglio, vi invio questa mail dalla capitale britannica, anche se l’ho già preparata nei giorni scorsi. Sono appena arrivato nella grande città inglese e passerò qui i prossimi sei giorni in vacanza con la famiglia. Non potevo però dimenticarmi di voi, che con costanza (e un pizzico di sadomasochismo) leggete ogni settimana queste mie parole.
E quindi eccoci qua, con il solito mix di letture, serie TV e, soprattutto, riflessioni ispirate anche dall'attualità. Come leggerete, il tema centrale della newsletter nasce infatti questa settimana da una domanda che mi è stata posta sui social, domanda su cui ho dato forse per scontata una risposta e sulla quale vale la pena, invece, di mettere un po' in fila i pensieri.
Quindi direi di cominciare subito. Ho solo due cose da dirvi prima di lasciarvi al consueto menù: da un lato volevo avvertirvi che, nonostante la vacanza, i video e i podcast continueranno a uscire nei prossimi giorni, senza interruzioni (sempre che la connessione, qui a Londra, non mi giochi brutti scherzi); dall'altro, come sempre, vi ricordo che in libreria potete trovare, se non l'avete già fatto, il mio ultimo lavoro, Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, un libro che parla di filosofia e attualità. I riscontri finora sono stati molto buoni, ma aspetto anche il vostro parere.
Detto questo, partiamo!
Quello che ho letto
E cominciamo come sempre dai libri. Nessuna novità all’orizzonte questa settimana, ma qualcosa di interessante da dire (almeno per me) c’è lo stesso.
Per tutti i gusti di Zygmunt Bauman: nonostante sia molto breve e consti di poche decine di pagine, sto trovando un po’ di difficoltà a finire di leggere il saggio Per tutti i gusti di Zygmunt Bauman. Non è colpa dello stile di scrittura, perché in realtà lo studioso polacco ha una prosa piuttosto scorrevole e riesce a portare avanti i riferimenti sociologici e culturali senza appesantire troppo il testo. Quello che mi lascia invece un po' perplesso è il modo in cui Baumann sostiene le sue tesi, tesi con cui tra l'altro non sono neppure troppo in disaccordo. Non è facile da spiegare, ma ci provo: l’intento dello scrittore che è venuto a mancare qualche anno fa è, in questo libro, quello di analizzare la produzione culturale destinata alla società contemporanea, soprattutto quella di stampo popolare, che ormai interessa tutte le classi, indipendentemente dall'appartenere o meno al cosiddetto ceto intellettuale. Di per sé questo è un tema molto interessante, perché in effetti mai come in questi ultimi anni gente istruita e gente senza una precisa formazione hanno fruito degli stessi prodotti culturali, ormai accessibili a tutti. Tuttavia, dopo aver delineato abbastanza bene il campo di indagine, Bauman sembra perdersi in discorsi che servono più ad alimentare polemiche interne al mondo culturale che non a chiarire i termini del discorso. Ad esempio, nella parte in cui sono arrivato, c'è un lungo capitolo dedicato alle polemiche tra fautori del multiculturalismo e detrattori di questa tendenza. E, leggendolo, mi chiedo continuamente: «Embè?» Cioè, alla fin fine è davvero così rilevante dare una stoccata a quello che pensava vent'anni fa il ceto intellettuale di sinistra americano? Non è una polemica che oggi suona un po’ stantia, superata, o riservata al massimo agli addetti ai lavori? Insomma, il volumetto alterna pagine interessanti ad altre che si potrebbero tranquillamente saltare. Comunque, ormai inizio a vedere la fine e spero di darvene un giudizio complessivo forse tra una o due settimane. Intanto, se vi interessa, il libriccino può essere acquistato qui.
L’isola del giorno prima di Umberto Eco: ho già dedicato diverse righe, nelle settimane scorse, a questo romanzo di Umberto Eco, suscitando anche qualche reazione sui social, cosa che mi ha ulteriormente confermato che Eco continua a essere molto amato. Vorrei, come ho cercato di fare anche in privato, però chiarire a tal proposito un punto: è vero che la settimana scorsa ho sottolineato come Eco abbia ottenuto un successo, a mio modo di vedere, inatteso a livello editoriale, ma questo non implicava che secondo me lo scrittore piemontese non meritasse quel successo. A stupirmi è piuttosto il fatto che Eco, anche nei suoi romanzi, è sempre stato un autore molto complesso, estremamente erudito e poco avvezzo a sfruttare le normali convenzioni della narrativa. Detta in altri termini, se facessi il mestiere del redattore e oggi mi arrivasse sulla scrivania il manoscritto di un romanzo come L'isola del giorno prima, magari spedito da un autore sconosciuto, lo giudicherei non dico impubblicabile, ma di certo molto di nicchia. Forse direi, tra me e me: «Bel libro, ma non lo leggerà praticamente nessuno». Mi fa quindi piacere che questa mia (ipotetica) previsione venga smentita dai fatti, ma il caso di Umberto Eco e soprattutto dei suoi romanzi rimane per me incomprensibile. Per quanto riguarda L’isola del giorno prima, poi, nello specifico, sono quasi arrivato in dirittura d'arrivo, eppure di fatto non è ancora accaduto quasi niente: i personaggi sulla scena, fatto salvo qualche flashback, sono stati in tutto solo due e non hanno compiuto nessuna azione, nessuna impresa. Sono stati semplicemente fermi ad aspettare e a confrontare le loro rispettive conoscenze sull'universo, la geografia e la vita. Nonostante tutto questo, il libro mi sta piacendo e penso di poter dire che, indipendentemente da come sarà congegnato il finale, si tratta di un volume che merita una lettura attenta, soprattutto se si ha una qualche passione per il Seicento, secolo che in effetti non avevo mai apprezzato così tanto come dopo la lettura di questo romanzo. Se vi interessa, il libro potete acquistarlo qui.
Le confessioni d’un italiano di Ippolito Nievo: non so se vi mancava, ma questa settimana ho fatto ripartire, dopo qualche mese di pausa, la lettura di un classico del Risorgimento italiano che mancava da queste pagine da un bel po’ di tempo: Le confessioni d’un italiano di Ippolito Nievo. Ho iniziato a leggerlo più di dodici mesi fa, ma essendo un libro piuttosto voluminoso e scritto più di centocinquant'anni fa, con un linguaggio che può sembrare un po’ datato, non sono ancora riuscito a terminarlo. Mea culpa, in verità, perché il libro è affascinante, frizzante nella trama e acuto nelle osservazioni, anche se inevitabilmente figlio del suo tempo. Nievo fu infatti un giovane patriota veneto che partecipò alla spedizione dei Mille di Garibaldi e morì, tra l'altro in circostanze misteriose, proprio durante quell'esperienza. Imbevuto di ideali risorgimentali, prima di lasciare questo mondo riuscì comunque a scrivere questa mastodontica opera, che pochi conoscono e studiano ma che forse meriterebbe maggior fortuna. Ricordo di aver letto, tempo fa, lo storico Mario Isnenghi affermare che il nostro romanzo patrio, quello che si dovrebbe leggere alle superiori, non dovrebbe essere tanto I promessi sposi di Alessandro Manzoni, quanto piuttosto proprio Le confessioni di Nievo. E si tratta, in effetti, proprio di un romanzo storico. Il protagonista è un certo Carlino, un ragazzo cresciuto in un castello dalle parti di Portogruaro, tra il Veneto e il Friuli, durante gli ultimi decenni di vita della Repubblica di Venezia. Lì impara a conoscere le tendenze politiche del luogo e si innamora della “Pisana”, giovane figlia della famiglia che lo sta allevando. Una volta cresciuto, Carlino scopre di avere origini importanti e ottiene un posto nel Maggior Consiglio della Repubblica, ma lo occupa per poco tempo, visto che la Serenissima viene rapidamente conquistata da Napoleone e ceduta agli austriaci con il Trattato di Campoformio. Dopodiché, la vita di Carlino diventa effervescente: si sposta tra diverse città del Nord Italia, entusiasmandosi in parte per le imprese napoleoniche, ma rimanendone anche dubbioso. Si ritrova poi sentimentalmente legato proprio alla Pisana, che però nel frattempo si è già sposata. Insomma, la sua vita segue gli alti e bassi della causa italiana, tra aspirazioni indipendentiste e unitarie e assoggettamento ai francesi. La storia è ancora lontana dalla conclusione, perché, nonostante io sia già a tre quarti del romanzo, Carlino è ancora piuttosto giovane e le sue memorie dovrebbero arrivare fino alla veneranda età di ottant'anni. Vedremo se e quando Nievo deciderà di accelerare la narrazione. Comunque, al di là della trama, ciò che colpisce di più è lo stile dello scrittore veneto, uno stile carico di ironia e a tratti anche di sarcasmo, divertente e divertito, che si concede anche, di tanto in tanto, qualche slancio retorico e patriottico che ti permette anche di comprendere bene quale fosse il sentire di quei ragazzi dell'Ottocento. Se vi interessa, il libro può essere acquistato qui.
Quello che ho visto
Passiamo ora ai film (e a una serie animata). Vi accorgerete che non c’è niente di nuovissimo nella lista, ma ci sono parecchi classici.
Ed Wood (1994), di Tim Burton, con Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker: tra tutti i film di Tim Burton, forse Ed Wood è uno dei meno noti, anche se presenta un cast eccezionale: ci sono un giovane e affascinante Johnny Depp, un fantastico Martin Landau che ottenne anche un Oscar e un Golden Globe per questo ruolo, oltre a Bill Murray, Sarah Jessica Parker e Patricia Arquette. Eppure, come dicevo, mi sembra che i giovani fan del visionario regista americano sappiano poco o nulla di questo film, preferendo titoli come Beetlejuice - Spiritello porcello, Edward mani di forbice, Batman o i film in stop motion. Forse è perché la vicenda da cui questa pellicola è tratta è un po' oscura di suo, visto che si concentra su un aspetto secondario, se non addirittura terziario, della storia di Hollywood. Ed Wood è infatti un film biografico che racconta i primi anni di attività di quello che è stato a volte definito il peggior regista della storia del cinema: Wood lavorò negli anni '50 specializzandosi in film a bassissimo costo, perlopiù di fantascienza; film che, obiettivamente, erano realizzati male, in fretta e furia, risparmiando su costi, attori e scenografie. Quei film cercavano di sfruttare la popolarità del genere e sembravano però così assurdi e incomprensibili da risultare quasi belli. Almeno, questa è l'interpretazione che Tim Burton dà a tutto il lavoro di Ed Wood, rivelandosi come un sincero ammiratore di quel suo collega così fuori dagli schemi. Basti pensare che Wood, pur essendo eterosessuale, amava vestirsi da donna e cercava di mettere perfino in scena questa sua passione che, nell'America del dopoguerra, non poteva certo passare inosservata; o che fosse talmente innamorato delle storie di decadenza da riportare sulla scena un Bela Lugosi (grande interprete degli anni '30) ormai tossicodipendente e letteralmente a un passo dalla fossa. Il film è quindi un viaggio all'interno di una carriera stravagante, ma non priva di inventiva e di slancio vitale; ed è proprio in questo slancio vitale che risiede il vero valore di quanto creato da Burton, in una storia che può lasciare anche indifferenti, ma che può anche, a suo modo, emozionare. Se vi interessa, potete trovate il film in streaming su Disney+.
La mosca (1986), di David Cronenberg, con Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz: sono passati davvero tanti anni da quando ho visto per la prima volta La mosca di David Cronenberg. Così tanti che non mi ricordavo quasi più la trama, a parte qualche scena particolarmente intensa e, ammettiamolo, anche particolarmente orribile, che ti rimane impressa nella memoria. Nei giorni scorsi, comunque, visto che è disponibile su Disney+ (cosa piuttosto peculiare, considerando che non lo definirei proprio un film “per famiglie”), ho deciso di rivederlo e, credetemi, sono rimasto orripilato come la prima volta. Il film è in realtà un remake di una vecchia pellicola degli anni '50, che a sua volta era tratta da un racconto horror dell’epoca. Racconta di uno scienziato che inventa una macchina per il teletrasporto, ma che finisce per avere un incidente quando decide di testarla su se stesso. Nella capsula di partenza, entra infatti anche una piccola mosca, e quando il corpo dell’uomo viene ricomposto nella capsula di arrivo, esso si fonde a livello genetico con quello della mosca. Sembrerebbe, detta così, una storia di supereroi (in fondo Spider-Man nasce in modo simile), ma lo scienziato protagonista del film vede il suo corpo degenerare rapidamente, assumendo sempre più le sembianze di un insetto, con scene davvero raccapriccianti. La pellicola vinse l’Oscar per il trucco, anche se molti a suo tempo si lamentarono dal fatto che Goldblum – davvero bravo nel delineare i cambiamenti del protagonista – non avesse ricevuto neppure una nomination per la sua performance. Se vi interessa, come già detto, lo trovate su Disney+.
The Midnight Gospel episodi 1.05-1.06 (2020), di Pendleton Ward e Duncan Trussel: vi ho già parlato in un paio di occasioni di The Midnight Gospel, serie animata disponibile su Netflix di cui questa settimana ho visto altre due puntate (su un totale di otto complessive). La serie ricorda per molti versi Adventure Time, altro cartone animato di Pendleton Ward, ma con un tocco filosofico e quasi buddista che non emerge nel suo show più famoso. Il protagonista è Clancy, un giovane “spacecaster”, ovvero una sorta di podcaster interplanetario: la sua occupazione consiste infatti nel visitare strani mondi grazie a un simulatore computerizzato e intervistare personaggi che, in quei mondi, hanno trovato una sorta di pace ed equilibrio interiori. Il tutto è ispirato a un podcast reale, i cui contenuti vengono qui trasfigurati ma allo stesso tempo anche ripresi. L'effetto è piuttosto straniante: in un paesaggio che passa dal fantasy allo psichedelico, sentiamo riflessioni sulla pace dei sensi, sul karma, sulla reincarnazione e su varie altre questioni di stampo new age; a volte suonano anche abbastanza interessanti, mentre altre volte partono un po' per la tangente. Non ho ancora capito se questo strano mix mi piaccia. Anzi, direi che non mi emoziona particolarmente, ma allo stesso tempo devo anche ammettere che alcuni passaggi risultano curiosi e interessanti, e in generale il cartone si lascia guardare. Come detto, potete recuperarlo su Netflix.
Quello che ho pensato
Questa settimana parliamo, in un certo senso, di un argomento a richiesta. Mi è stato chiesto infatti di esprimere meglio la mia opinione – che ho accennato qua e là nelle settimane scorse – riguardo ai social network e all’effetto che possono avere sui ragazzi.
Prima di tutto voglio dire che ho, istintivamente, un atteggiamento in generale di curiosità e cauto ottimismo verso i social, simile a quello che ho sempre avuto nei confronti delle novità. Fin da quand’ero bambino, ho affrontato milioni di volte discussioni sulle novità tecnologiche: prima la tv commerciale, poi il computer, i videogame, internet, gli smartphone, i social network… e l’elenco potrebbe diventare lunghissimo. Ogni volta, davanti a tutte queste novità, mi sembra siano emerse due opinioni principali: quella degli iper-critici e quella degli entusiasti. Usando la famosa terminologia di Umberto Eco, gli apocalittici e gli integrati.
Da un lato, ci sono quelli che pensano che ogni novità segni, potenzialmente, la fine dell’umanità, il dramma assoluto, l’inizio della decadenza. Quand’ero solo un bambino, si diceva – e lo si diceva davvero, visto che sul tema si esprimevano studiosi e sociologi – che i cartoni animati giapponesi avrebbero creato una generazione violenta, instupidita, ignorante. Così non è stato, o almeno non più della media. Lo stesso è stato detto per il computer, i videogiochi e così via: ogni cambiamento veniva visto da alcuni – soprattutto dai commentatori più anziani – come l’ultimo prima della rovina. L’Apocalisse era sempre dietro l’angolo.
Dall’altro lato c’erano quelli che si lanciavano entusiasticamente in quelle novità, senza scorgerne i limiti o i pericoli. Certi cartoni animati erano effettivamente violenti, e il pubblico di allora non ci era abituato. Passare decine di ore al computer, soprattutto con gli schermi di un tempo, non era certo salutare, e anche i videogiochi potevano creare dipendenza.
Tra questi due estremi, ovviamente, la soluzione migliore stava nel mezzo: non scappare davanti alle novità, ma affrontarle magari anche con l’aiuto di una guida o di alcuni limiti. Nel caso dei cartoni animati giapponesi, per esempio, mia madre da bambino mi imponeva un certo limite di tempo che potevo passare davanti alla tv; dopodiché dovevo uscire, o leggere, o fare altro. Certo, a volte guardavo di nascosto L’Uomo Tigre, che lei mi aveva severamente proibito perché “troppo violento”, ma non c’è regola senza trasgressione, non c’è limite senza qualche sconfinamento. E comunque penso di essere cresciuto come una delle persone meno violente al mondo, nonostante la visione abusiva di quell’anime.
Con i social network, credo che il meccanismo dovrebbe essere simile. Forse, in questo caso, parlare di “cauto ottimismo” è un po’ eccessivo; preferirei piuttosto dire che “dobbiamo in qualche modo farci i conti”, ma la sostanza alla fin fine è simile.
Mi spiego meglio, riprendendo anche alcuni discorsi che ho fatto di recente sulla scuola e sulla democrazia. I social network esistono ormai da vari anni e fanno parte della vita quotidiana di miliardi di persone. Prima c’erano Facebook e Twitter, oggi spopolano Instagram e TikTok, senza contare YouTube, Threads, BeReal e mille altre varianti: sono una realtà che non possiamo ignorare.
In teoria, rappresentano anche qualcosa di positivo: ci permettono di metterci in contatto con altre persone, di condividere idee e immagini, di socializzare anche a distanza. In un’epoca di isolamento crescente, i social possono aiutarci a rafforzare legami con persone che conosciamo ma che non riusciamo più a vedere di persona, ma anche a crearne con altre “anime affini” in giro per l’Italia o il mondo, e perfino ad avere un contatto più intimo con “divi” che ammiriamo (campioni sportivi, attori di Hollywood, cantanti, politici).
È stato proprio sull’onda di queste promesse che io stesso, quindici anni fa, ho iniziato a usare questi strumenti. Nel 2009 ho cominciato a utilizzare intensamente Twitter, curioso di scoprire cosa accadeva nel mondo e di raccontare qualcosa di me. Ero molto appassionato, come sanno quelli che mi seguono da allora; e quell’esperienza portò, tra le altre cose, alla conoscenza diretta di alcune persone, ad incontri e cene, oltre che alla scrittura di Per chi suona la campanella, il mio primo libro.
Poi però qualcosa si è rotto, nel mio caso ma credo non solo nel mio caso. Quando i social sono diventati popolari, hanno attirato anche persone che non volevano socializzare in modo positivo, ma solo sfogare i loro istinti più bassi. Oggi Twitter è una mezza cloaca (e mi perdoneranno quelli che lo usano ancora attivamente): disinformazione, messaggi stupidi e provocazioni inutili sono all’ordine del giorno. Proprio ieri, solo per fare un esempio, ho letto un tweet di Elon Musk che meritava di essere segnalato e cancellato per palese disinformazione e per la propagazione di conclamate falsità; solo che Elon Musk è il padrone della baracca, e non si può certo sbattere fuori dalla piattaforma quello che la possiede. Ormai Twitter non è un social network con qualche troll; sono i troll che hanno preso in mano il social network. Facebook è un po’ meglio – ma non troppo – solo perché si tende a seguire solo persone che si conoscono direttamente, ma anche lì basta imbattersi in un articolo condiviso da una testata giornalistica per incappare in decine di commenti offensivi, ignoranti, stupidi.
L’odio, sul web, corre più veloce di tutto il resto, e tende a sopraffare tutto. Ma non è solo l’odio il problema; è che sui social ciò che “vende”, cioè ciò che viene condiviso e promosso, è spesso ciò che gioca sui nostri sentimenti più inconfessabili e, onestamente, brutti.
Se l’algoritmo di Twitter deve scegliere quale tweet “pompare”, cioè mostrare a migliaia e migliaia di utenti, è facile prevedere per cosa opterà: non certo per il messaggio lungo e riflessivo, per quello che fa chiarezza, quanto piuttosto per il tweet polemico, per quello che provoca reazioni indignate, per quello che offende. Il tweet offensivo genera cento volte più engagement di quello serio; così come anche su YouTube il video breve, stupido e urlato ha immediatamente più visibilità di quello meditato (e corretto).
Insomma, nonostante le potenzialità dei social network, il bisogno di quelle piattaforme di mantenere alto il coinvolgimento dell’utente ha finito per renderli strumenti in mano a chi diffonde idiozie, cretinate o cose pericolose. Molti studi, ad esempio, hanno evidenziato come i social abbiano aumentato il settarismo e la radicalizzazione delle persone.
Si potrebbe dire, però, che i social network oggi più popolari si sottraggono almeno in parte a questa logica. Twitter e Facebook, infatti, usano le parole, mentre Instagram e TikTok usano le immagini, e tramite le immagini è più difficile diffondere messaggi d’odio. Questa è un’obiezione sensata, e devo dire che anch’io ormai uso Instagram con più piacere di quanto non faccia con Twitter: i messaggi sono tendenzialmente più positivi.
Tuttavia, anche questo ha un costo. Pensate a cosa vi lascia Instagram, dopo un uso prolungato. Nel mio caso, in questa stagione estiva sto vedendo tantissime foto delle vacanze. La mia reazione istintiva è duplice: da un lato sono felice di vedere che persone che conosco (o anche sconosciuti che seguono il canale) visitano posti bellissimi in giro per l’Italia o per il mondo; alla lunga, però, mi rendo anche conto che questo potrebbe generarmi un po’ d’invidia. Per fortuna anch’io faccio un po’ di ferie e, come vi ho raccontato, proprio oggi sono arrivato a Londra, ma se non potessi permettermi nemmeno una vacanza vivrei con una certa ansia l’esperienza sui social.
Per non parlare dell’aspetto fisico, dei corpi, della bellezza. Sarà che Instagram è un social giovane, sarà che – proprio per via del canale YouTube – ho molti follower di età liceale o universitaria, ma se scorro la timeline (o, peggio ancora, le storie) vedo sempre e solo gente bellissima e in forma. Gente sempre sorridente, vestita benissimo, senza un filo di grasso, in migliaia di foto dalla spiaggia, dalla barca, dall’aereo. Io ho la pancetta, mi vesto tendenzialmente a caso e non sono capace di farmi fare foto aesthetic, come dicono oggi. Non mi faccio neppure i selfie, a meno che non mi costringano, perché mi vergogno. E me ne frega anche il giusto: mi interessava poco di come apparivo a diciott’anni, figuratevi ora. Però mi rendo conto che non tutti sono come me, e che a diciott’anni questo costante confronto con fisici perfetti potrebbe creare qualche problema.
Immaginate di essere un adolescente brufoloso e insicuro, o una ragazzina con qualche rotolo di grasso: parliamo tanto di accettazione e di non fare bodyshaming, e poi questi ragazzini aprono il cellulare e si trovano davanti decine di amici sostanzialmente perfetti. Se non sono abbastanza maturi da capire che quella è solo una piccola parte di realtà (o addirittura pura apparenza), potrebbero viverla male. E in effetti, in alcuni casi, la vivono male per davvero, ci dicono gli studi. Solo per citare un passo del PDF che ho appena linkato: «The use of social networks is strongly correlated with the development of anxiety and other psychological problems such as depression, insomnia, stress, decreased subjective happiness, and a sense of mental deprivation». In Italiano: «L’uso di social network è fortemente correlato con lo sviluppo di ansia e altri problemi psicologici come depressione, insonnia, stress, calo della felicità soggettiva e un senso di deprivazione mentale». Ovviamente non tutti la vivono così, ci mancherebbe; però qualcuno che risente di tutto questo c’è, e dobbiamo occuparcene.
Il discorso da fare sarebbe ancora molto ampio, ma non voglio tediarvi troppo. La soluzione, ovviamente, non è il divieto (come non lo era vietare i cartoni animati trent’anni fa), ma piuttosto l’educazione e, in certe fasce d’età, il limite. Gli adolescenti andrebbero educati a conoscere le potenzialità e i problemi dei social, a capirne gli effetti e a valutare le conseguenze dell’abuso di quelle piattaforme. Quando sono piccoli, i genitori dovrebbero cercare di tenerli lontani dai social, e permettere un avvicinamento graduale solo man mano che crescono, sempre guidandoli verso scelte consapevoli. A patto che i genitori stessi, ovviamente, non siano a loro volta dipendenti dai social e sappiano staccarsene con giudizio critico.
Quello che ho registrato e pubblicato
Facciamo ora il punto anche sui video e sui podcast che ho pubblicato questa settimana:
Potere e misticismo in Simone Weil: concludiamo il percorso su Simone Weil con la sua analisi della politica e della religione
Lo scetticismo di Hume nei confronti della coscienza (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
La religione per David Hume (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
La diffusione del fascismo in Europa (per il podcast “Dentro alla storia”)
Spider-Man, il supereroe che sbaglia come un filosofo
L'assassinio di John Fitzgerald Kennedy
Tiktok failed to load.
Enable 3rd party cookies or use another browser
Quello che devi fare per seguirmi sui social
Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:
Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads
Quello che puoi fare per sostenere il canale
Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.
Carlo Magno. Un padre dell’Europa di Alessandro Barbero: non c'è certo bisogno che vi presenti il nome di Alessandro Barbero: è di gran lunga lo storico più famoso d'Italia, soprattutto per via della sua intensa attività di divulgatore in televisione, sul web e dal vivo. Questa attività è partita ormai più di vent'anni fa e l'ha reso un vero e proprio maestro nel settore. Ma Barbero non è solo un grande divulgatore, è anche uno storico di prim’ordine, e alcuni dei suoi saggi sono pietre miliari nel loro campo. Tra tutti i suoi libri specialistici, pensati per un pubblico di universitari e di studiosi, vi consiglierei in particolare quello su Carlo Magno, uscito ormai parecchi anni fa ma ancora forse il migliore su quell'argomento. Con una ricostruzione minuziosa e dettagliata, Barbero riesce a dare un quadro di uno dei più grandi uomini della storia europea, mostrandone anche il lascito proprio per il vecchio continente. Il libro non può certo mancare nella collezione di un appassionato e lo si può comprare qui.
sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):
C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.
Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!
Quello che c’è in arrivo
Chiudiamo come al solito con un piccolo aggiornamento su quello che spero di pubblicare sul canale in questa settimana. Come vi ho già accennato, la pubblicazione avverrà da Londra, quindi potrebbe anche esserci qualche piccola disfunzione: ho già caricato il materiale, ma se la connessione mi farà un po' dannare, dovrò rivedere rapidamente il piano editoriale. Comunque, ecco cosa vorrei proporvi:
domani partirò con un video breve, di un minuto, per celebrare l'anniversario della morte di Theodor Adorno, il grande filosofo tedesco;
mercoledì sarà il turno del podcast storico, con una nuova puntata che introdurrà il tema della crisi del 1929;
giovedì, invece, pubblicherò un video sull'attualità, in cui cercherò di spiegarvi in modo equo e spero chiaro che cos'è questa autonomia differenziata di cui si parla tanto in questi giorni;
venerdì torneremo a Franz Kafka, con il terzo video dedicato alla sua filosofia;
sabato e domenica ci saranno poi di nuovo i podcast: parleremo della morale di Hume in quello filosofico e dell'economia statunitense degli anni '20 in quello storico;
infine, lunedì prossimo vorrei proporvi la terza puntata della lettura integrale del Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels.
E questo è tutto per questa settimana. Fate i bravi mentre sono via e, se anche voi siete in viaggio o comunque potete prendervi qualche giorno di ferie, riposatevi e godetevi l'estate. A presto!






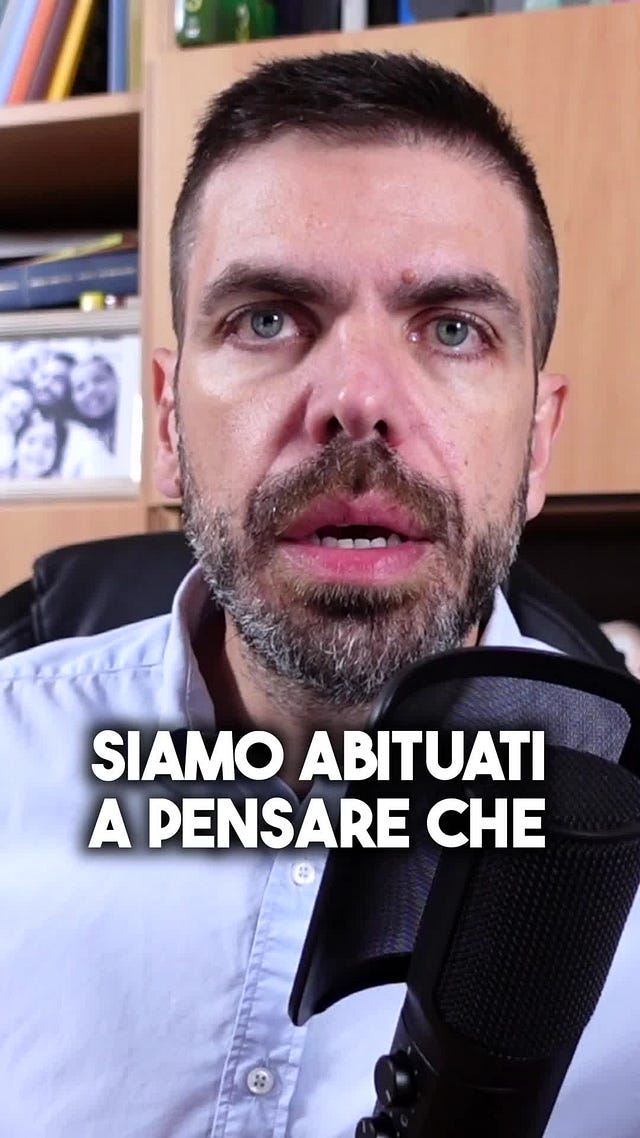


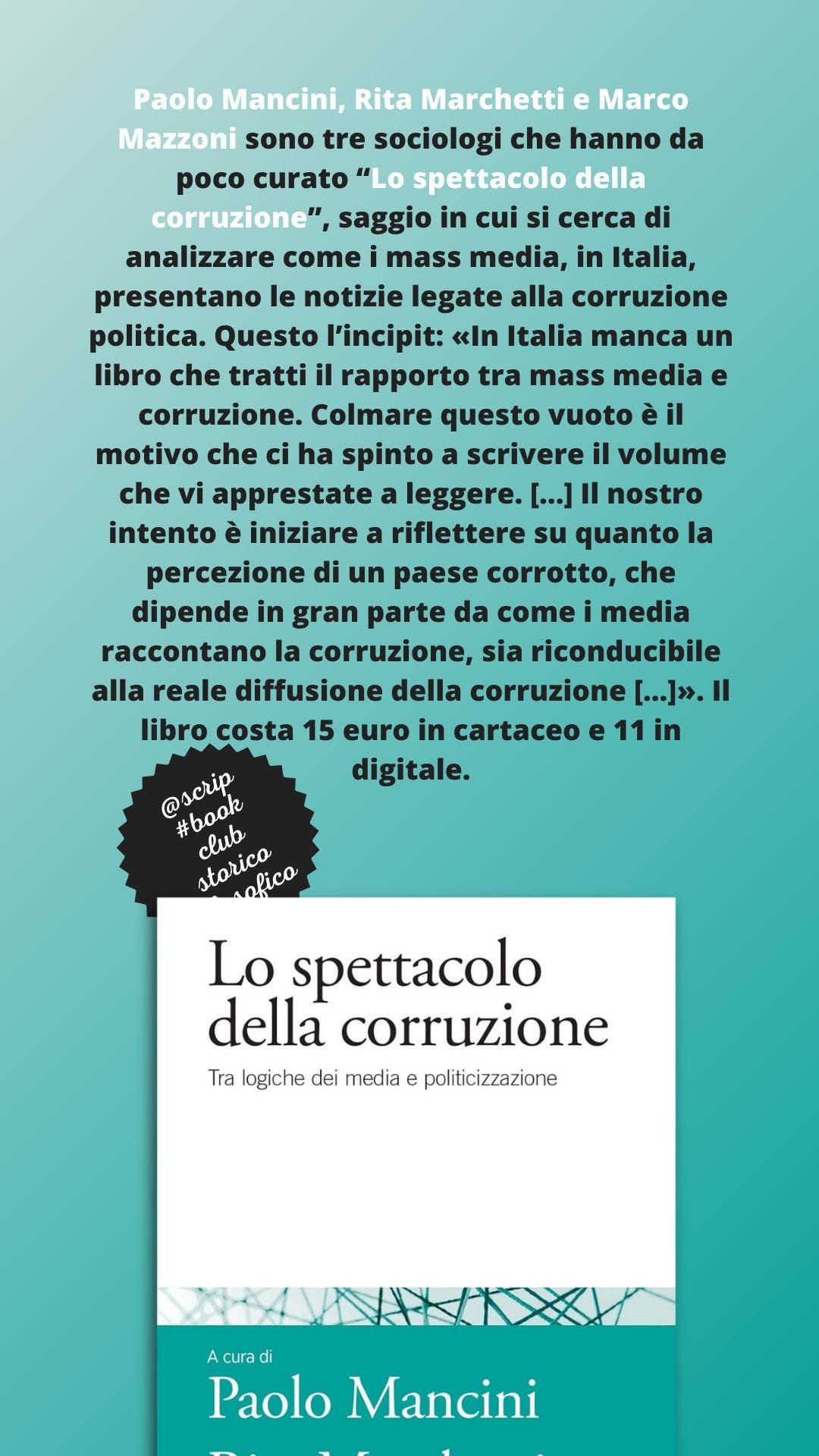
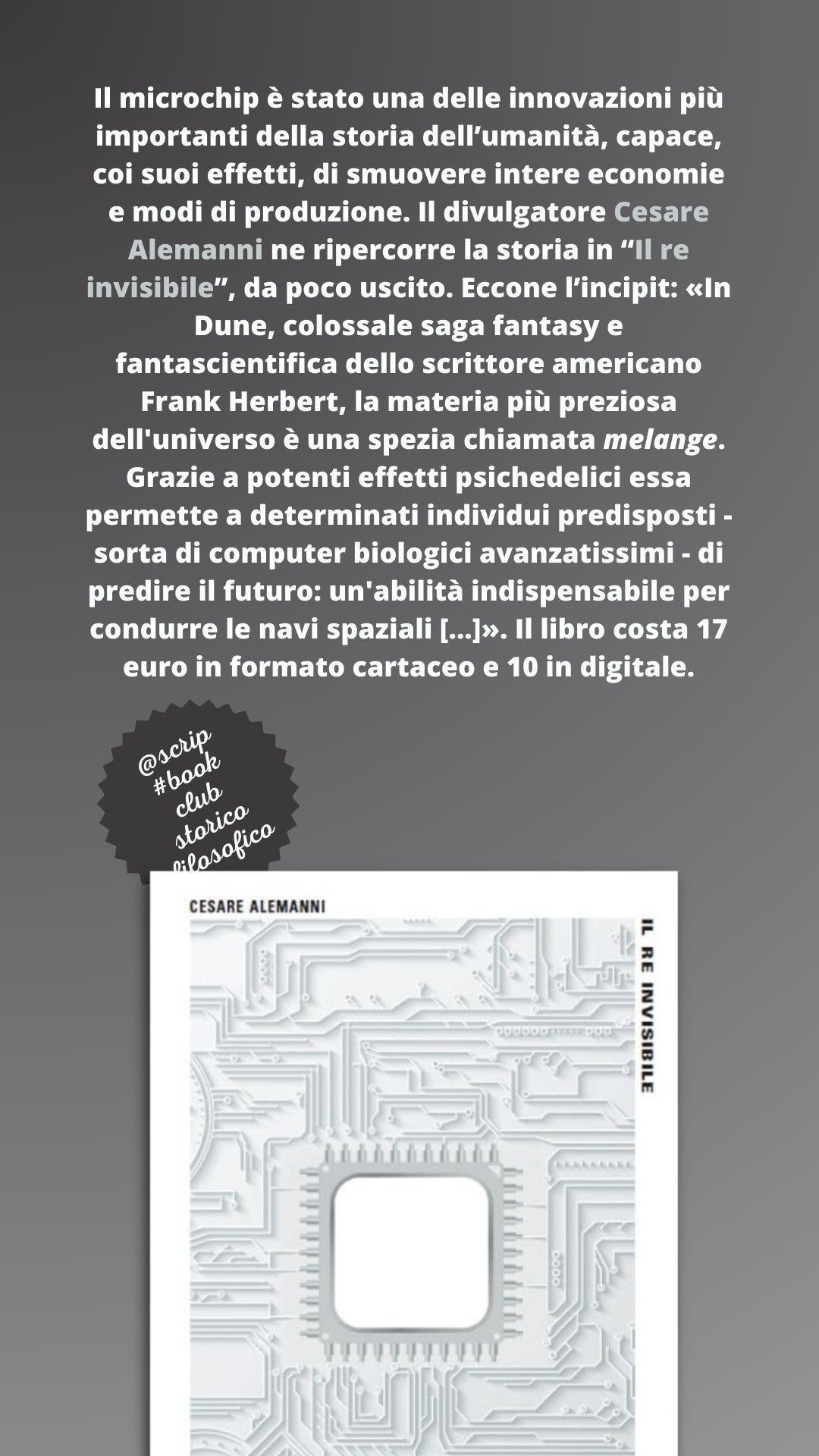
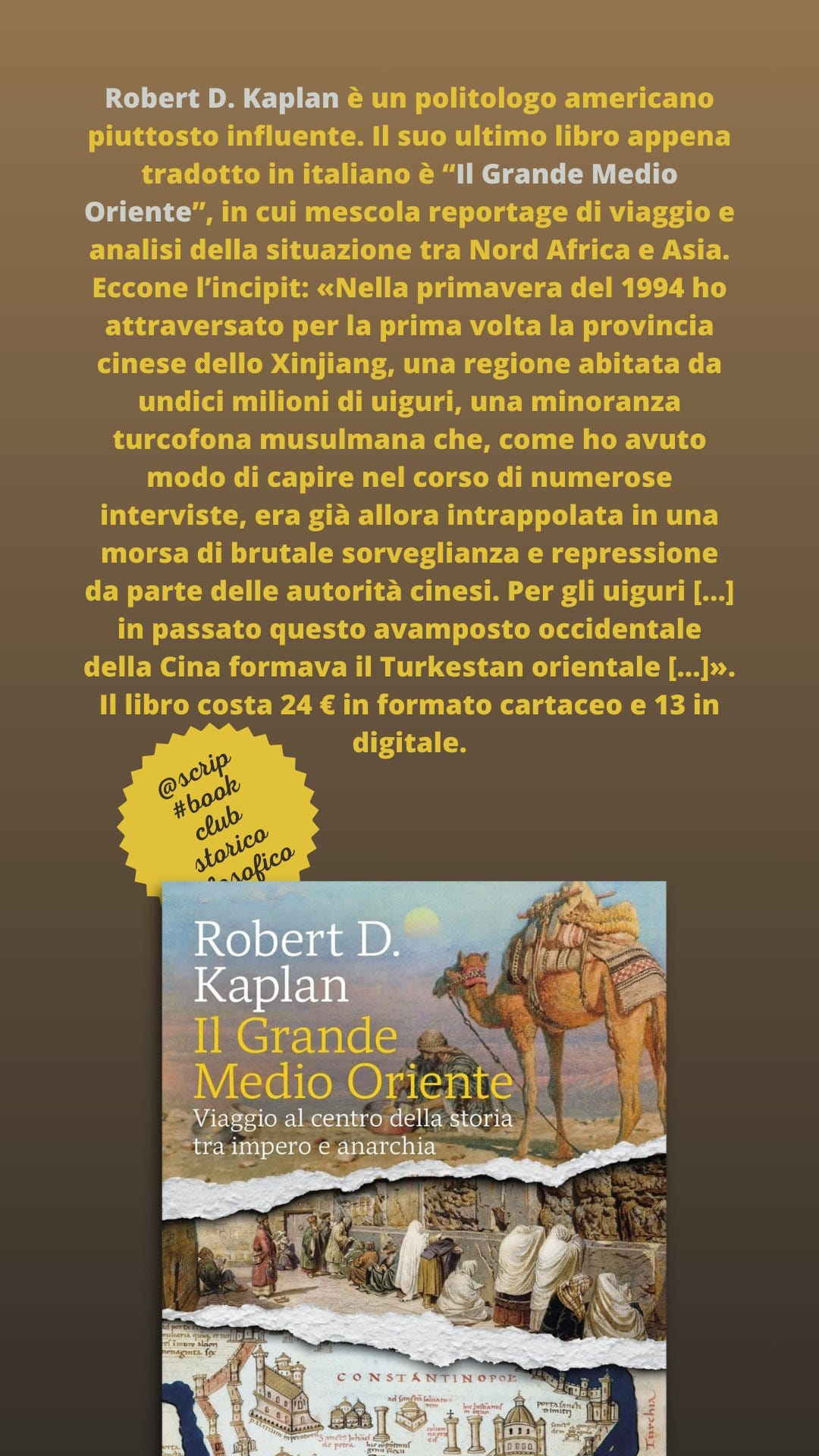
Ciao Ermanno, buona permanenza a Londra. Io sono dai suoceri a Berlino. A presto
Ciao, Pino