Sulla cultura del vittimismo nel governo (ma anche a scuola), senza dimenticare Gaza e Israele, Baby Reindeer, Il problema dei 3 corpi, Aristotele, i totalitarismi, Erodoto, Nievo e i Monty Python
A voler seguire l'attualità, questa settimana ci sarebbero tante cose interessanti di cui forse varrebbe la pena di parlare. Molte, soprattutto, gravitano attorno alla questione israelo-palestinese: mentre continuano e anzi si diffondono proteste giovanili in varie parti del mondo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dato infatti un'indicazione molto chiara su come spera che questo conflitto vada a finire. Nei giorni scorsi, come forse avrete sentito, ha dato a larghissima maggioranza mandato al Consiglio di Sicurezza di valutare l'entrata della Palestina tra i paesi membri dell’ONU, un'indicazione che è di fatto una presa di posizione netta a favore della nascita di uno Stato palestinese vero e proprio.
Forse avrete visto la dura protesta con cui l'ambasciatore israeliano ha risposto a questa votazione, ma bisogna anche dire che Israele dovrebbe forse iniziare a comprendere come il resto del mondo giudica quello che sta facendo. Purtroppo, come spesso accade davanti alle grandi questioni di politica internazionale, in ultima istanza in gioco c’è un problema di empatia: Israele continua ad avere in mente gli attacchi subiti a ottobre, e non riesce a mettersi minimamente nei panni dei palestinesi; mentre il resto del mondo, com’è naturale, si immedesima molto più facilmente proprio col popolo palestinese, che adesso sta subendo le più pesanti angherie. E così, mentre Israele si sente una vittima, una buona parte del resto del mondo pensa che ora le vere vittime siano invece i civili palestinesi. E il fatto è che, dal loro punto di vista, hanno ragione entrambi; ma non riescono a vedere le cose dall’altro punto di vista (ed è, credo, soprattutto Israele a non farlo, ora come ora, anche perché il numero di vittime palestinesi continua a crescere).
Dalle nostre parti la questione, però, mi sembra abbia sempre meno a che fare con quello che davvero succede a Gaza, ma soprattutto con noi. Ed è una cosa che accade sempre più di frequente, a mio avviso, nel nostro tempo: i fatti ci interessano solo nella misura in cui ci permettono di posizionarci, di farci sentire dalla parte giusta della storia, e non perché ci smuovono a fare davvero qualcosa. Sabato sera mi è capitato ad esempio di vedere l'Eurovision, un concorso musicale che è diventato – e lo è già da un po' – più che altro un’occasione per dire da quale parte si sta: qualche anno fa si stava con l'Ucraina, al di là della bellezza o meno della canzone che rappresentava quel paese, perché ci si immedesimava con le sofferenze di quel popolo; quest'anno Israele ha subito pesanti fischi durante tutta la manifestazione, ma poi ha anche ottenuto un ottimo voto da casa, segno che anche il mondo occidentale si divide più o meno a metà tra chi sostiene quel paese a spada tratta e chi lo attacca, sempre a spada tratta; per non parlare delle questioni che riguardano la sessualità e il genere, che suscitano gli stessi effetti di posizionamento.
La mia impressione – forse da vecchio boomer, lo ammetto – è che ci piaccia tanto dire cosa pensiamo, ci piaccia protestare, ma che non abbiamo in realtà nessuna idea di come trasformare la nostra indignazione in qualcosa di propositivo. In questo momento sembra che i giovani siano molto interessati a quello che accade a Gaza e siano molto critici – e credo anche giustamente – nei confronti di quello che sta facendo Israele. Ma quanti di questi giovani tra poche settimane andranno a votare per le elezioni europee? Quanti sanno ad esempio la posizione dei vari partiti su quello che sta accadendo in Medio Oriente? Quanti, anche solo semplicemente, conoscono quali sono i partiti europei in corsa? Eppure, se vogliamo che l’Europa faccia qualcosa, è soprattutto tramite quel canale che si può agire: detta in altri termini, non sarà certo una partnership tra la propria università e quella israeliana a fare la differenza.
Insomma, mi pare che ci sia davvero uno scollamento tra la rabbia, che viene manifestata sui social o dal vivo, e la proposta politica, che è scarsa, o prossima allo zero. Perché se si protesta, si dovrebbe protestare per ottenere qualcosa; ma se non si ha in mente cosa si vuole ottenere, o quantomeno come si possa arrivare a quel risultato, allora forse la protesta serve più a noi che alla causa che difendiamo.
Ma questi sono forse solo deliri di un vecchio impenitente. Per il momento lasciamo perdere e passiamo piuttosto a parlare dei libri e dei film, come sempre.
Quello che ho letto
Cominciamo, allora, con i libri. In lista questa settimana ci sono due saggi, uno molto moderno e uno molto antico, e un romanzo.
Le confessioni d’un italiano di Ippolito Nievo: era da un po' di tempo che non portavo avanti la lettura de Le confessioni d’un italiano di Ippolito Nievo. Si tratta, come forse qualcuno di voi ricorderà, di un libro imponente, un romanzo infinito, scritto nell'Ottocento da uno dei principali protagonisti del Risorgimento italiano, il veneziano Nievo, che seguì poi Garibaldi nell'impresa dei Mille e morì in circostanze anche abbastanza misteriose durante quella pagina di storia. Le confessioni fu il romanzo che scrisse prima di quegli eventi, e in cui cercò di descrivere il lungo percorso di formazione dell'identità nazionale italiana, soprattutto tramite le vicende (inventate) di uno sfortunato esponente della nobiltà della provincia veneziana. La storia è particolarmente picaresca e segue le vicende di questo protagonista, Carlino, lungo diversi decenni, tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, mentre la Serenissima crolla sotto i colpi prima di Napoleone e poi degli austriaci. Per ora sono arrivato alla fase in cui, dopo la prima discesa di Napoleone, l’Italia viene riconquistata dalle truppe reazionarie, con i protagonisti per ora barricati a Genova in attesa di rinforzi. Ma il fatto più interessante di questo romanzo non sono tanto le vicende storiche, che vengono comunque raccontate con dovizia di particolari, quanto il tono ironico e divertito dello stesso Nievo, che riesce di tanto in tanto anche a sferzare dei colpi intensi non solo contro l'Austria o la Francia, ma anche contro la stessa Venezia, colpevole della sua stessa disfatta. Certo, si tratta di un libro davvero infinito, e, se volete leggerlo, vi avverto che servono sicuramente dei mesi, anche perché si tratta di un italiano ottocentesco che, per quanto scorrevole, richiede comunque un minimo di impegno; in ogni caso, il libro lo potete acquistare qui.
Etica Nicomachea di Aristotele: se siete abbonati al canale, sapete che una volta al mese ci troviamo online per discutere insieme di un libro che abbiamo letto nei trenta giorni precedenti. Pochi giorni fa abbiamo tenuto l'incontro di maggio, dedicato alla Lettera sulla tolleranza di John Locke e Per la pace perpetua di Immanuel Kant; e, in quell'occasione, abbiamo annunciato anche il nuovo libro che dobbiamo affrontare per inizio giugno: l'Etica Nicomachea di Aristotele. Si tratta di un libro certo non semplice e più corposo di quelli che avevamo da fare per questo mese, ma il bello di questo Club del libro è che ogni tanto gli iscritti si lanciano in qualche proposta temeraria, portando comunque anche a termine l'impegno che si prendono. Visto che Aristotele non è un autore che si legge in pochi minuti, mi sono messo d'impegno anch'io, e ho iniziato già questa settimana la lettura del volume, ritrovando, come sempre mi accade, molte delle cose che spiego in classe anno dopo anno, ma stavolta sentite dalla viva voce del grande filosofo greco. Sono ancora agli inizi, nella fase introduttiva in cui il pensatore presenta il problema del sommo bene, ma già qui si vede tutto lo stile di Aristotele, il suo procedere lento e chiaro, le sue classificazioni e il modo convincente che ha di mostrare il suo punto di vista. Questo libro mi terrà compagnia ancora a lungo, quindi torneremo sicuramente a parlarne; se vi interessa – ed essendo un classico immortale della filosofia, probabilmente dovrebbe – lo potete acquistare qui.
Nudge di Richard H. Thaler e Cass R. Sustein: tra i libri che si approssimano alla conclusione, questa settimana devo segnalare Nudge, saggio di cui vi ho già detto varie cose nelle puntate scorse. Si tratta di un saggio che definirei di economia comportamentale: i due autori infatti, analizzando i comportamenti degli esseri umani in vari ambiti sociali, cercano di sostenere la tesi del paternalismo libertario, ovvero di promuovere politiche in cui lo Stato lasci liberi i cittadini di decidere davanti alle varie scelte della vita, spingendoli però dolcemente, inclinandoli, verso quella che si può ritenere essere la soluzione migliore. In realtà il tema è estremamente complesso: i due autori si prodigano a mostrare alcuni esempi di applicazione che sono anche tutto sommato condivisibili, ma man mano che si va avanti nelle pagine ci si rende conto che quegli esempi esauriscono solo una piccola gamma delle varie possibilità. Detta in altri termini, è facile dire che si può dare un “pungolo” affinché le persone facciano una scelta saggia, ma molto meno facile è trovare l'equilibrio tra questo pungolo e da un lato i diritti individuali, e dall'altro i giusti equilibri sociali. Ad esempio, nel libro si sente pesantemente l'influenza del modo di pensare americano, molto attento all'individualismo e alla libertà di scelta, e molto poco invece l’influenza del nostro modo europeo di rapportarsi ai problemi, un modo in cui si sa che le scelte individuali hanno comunque sempre una ricaduta sul collettivo; per questo motivo alcune delle proposte che i due autori danno abbastanza per scontate suonano decisamente estreme agli occhi di un europeo, abituato ad un ruolo molto più attivo dello Stato nella sanità e nelle politiche sociali. Il che, ovviamente, non vuol dire che la proposta dei due studiosi sia sbagliata, ma che forse andrebbe meglio calata nelle varie realtà storiche, e che in ogni caso in questo campo è bene aprirsi anche a molti compromessi, senza lasciarsi troppo trascinare dal fascino di una certa ideologia. Comunque il libro è interessante e sto ormai per finirlo: se volete acquistarlo, potete trovarlo qui.
Quello che ho visto
Questa settimana mi sono dedicato esclusivamente alle serie TV, tra l'altro con show di cui vi ho già parlato in alcune occasioni nelle mail scorse. Portate pazienza ma il panorama cinematografico e televisivo – o almeno il mio tempo per vedere qualcosa di nuovo – è un po' latitante.
Il problema dei tre corpi episodio 1.06 (2024), di David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo, con Saamer Usmani, Marlo Kelly, Jess Hong: proprio in questi giorni ho letto qualche recensione negativa riguardo all'adattamento televisivo de Il problema dei tre corpi, disponibile su Netflix. Recensione negativa che non mi trova del tutto d'accordo: come ho sostenuto anche nelle settimane scorse, penso che rendere per il piccolo schermo – e soprattutto per un pubblico generalista come quello di Netflix – un romanzo complesso e filosoficamente intrigante come il libro di Liu Cixin fosse un'impresa praticamente disperata. E, stante queste premesse, mi sembra che gli sceneggiatori in questo caso abbiano fatto buona parte di quello che potevano. Il guaio è che la bellezza del romanzo originale non sta affatto nella sua trama, che per molti versi è secondaria, quanto nel fascino esercitato da alcune atmosfere, in primis dal videogioco attraverso cui i protagonisti vengono a conoscenza del mondo trisolare. Videogioco che è ovviamente presente anche nell'adattamento televisivo, ma che compare solo in alcune puntate, venendo rapidamente messo in sordina a favore di un'ambientazione più realistica (almeno all'apparenza) e calata nel mondo reale. Questo ovviamente è un limite della serie: ma è anche un limite comprensibile, un po' per gli alti costi degli effetti speciali e un po' per il caos narrativo che avrebbe generato; e quindi non deve stupire, credo, che tutta questa trama parallela all'interno del videogioco sia stata gestita dai creatori con una certa parsimonia, forse timorosi di vedersi scappar via la storia. Insomma, se mi ci fossi messo io avrei fatto sicuramente molto di peggio, e quindi tutto sommato mi sento di essere comprensivo nei confronti degli autori; d'altra parte spero che, pur con tutti questi compromessi, siano riusciti almeno ad affascinare qualche neofita e magari avvicinarlo al romanzo originale. Io, per parte mia, devo ancora vedere qualche episodio per chiudere questa miniserie, ma penso che tra pochi giorni potrò tirare tutte le somme del caso. Intanto, se vi interessa, la serie la trovate su Netflix.
Baby Reindeer episodi 1.03-1.04 (2024), di Richard Gadd, con Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau: vi ho già raccontato la settimana scorsa che i primi due episodi di Baby Reindeer mi avevano abbastanza inquietato, ma questa settimana è andata pure peggio. La serie è scritta e interpretata da un comico scozzese, Richard Gadd, ma in realtà di comico non ha proprio nulla: ispirata a un'esperienza realmente vissuta dal protagonista, racconta di una stalker che si innamora in maniera ossessiva appunto di questo aspirante comico, che però è ancora agli inizi della carriera. La cosa degenera poi molto rapidamente in una vera e propria persecuzione, che va ad innestarsi nella vita già piuttosto disagiata del protagonista, vittima di altre molestie anche molto pesanti. Insomma, la visione di questa serie è, al contrario di quanto ci si poteva aspettare, una lenta discesa negli inferi della psiche umana, un viaggio di difficoltà pesantissime che fanno in qualche misura anche parte della nostra società. Per stomaci forti, sicuramente, ma comunque interessante: la trovate su Netflix.
Monty Python's Flying Circus episodio 2.05 (1970), con John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle: questa settimana, come già altre volte, per concludere ho visto anche l’ennesima puntata del Monty Python's Flying Circus, grande serie TV britannica trasmessa originariamente tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. L’episodio in questione non è per la verità granché: come ogni tanto accadeva in uno show così pieno di fantasia e di irriverenza, non era facile ripetersi di settimana in settimana e quindi a volte capitavano delle puntate un po' sotto la media. Il che, per la verità, vuol dire tutto e niente: considerando che alcuni episodi hanno fatto letteralmente la storia della TV, essere un po' sotto la media in quel contesto vuol dire comunque essere molto superiore a quello che solitamente viene trasmesso oggi nei nostri programmi comici. Se vi interessa, la serie, in tutte le sue varie stagioni, la trovate su Netflix ancora con i dialoghi originali sottotitolati in italiano.
Quello che ho pensato
Negli ultimi anni sono usciti alcuni libri, spesso giornalistici o al massimo di satira sociale, incentrati sul fatto che questa sia una sorta di epoca del piagnisteo. Penso ad esempio a L'era della suscettibilità di Guia Soncini, di cui abbiamo anche parlato su queste colonne ormai vari mesi fa: libri che ironizzano e puntano il dito su un aspetto che sembra emergere nell'atteggiamento di molti, forse anche per via dei social network.
In realtà questi libri colgono un lato di una questione più ampia, che i sociologi più accorti hanno già segnalato da parecchio tempo. Abbiamo parlato in passato, infatti, di forme più o meno forti di narcisismo che sembrano contrassegnare la nostra epoca, dovute alla crisi della società, alla caduta dei punti di riferimento e al ripiegamento su se stessi; ma da questo narcisismo, da questo pensare che il mondo ruoti tutto attorno a sé, deriva ultimamente a mio avviso anche una forma sempre più netta di vittimismo.
Sì, vittimismo più che suscettibilità: il problema non è tanto che ci arrabbiamo per qualcosa, quanto che ci sentiamo costantemente vittime di qualcosa, o che ci presentiamo come tali. I primi portatori di questo atteggiamento sono, se ci pensate un attimo, i nostri politici, e non si può nascondere che l'attuale maggioranza di governo stia facendo da parecchi mesi del vittimismo un'arte. Prendiamo solo il caso che ha tenuto banco sui giornali in questa settimana: la ministra della famiglia Eugenia Roccella è stata contestata nei giorni scorsi durante un evento agli Stati generali della natalità e subito il governo ha iniziato a parlare di censura, chiedendo che tutte le forze politiche e perfino gli intellettuali si esprimessero in difesa della ministra. Per rincarare la dose, il giorno successivo la polizia ha caricato un piccolo gruppo di manifestanti, manganellandoli con anche un certo fervore.
Ora, io penso che le contestazioni possano essere fatte in molti modi e non amo troppo quando si contesta impedendo all'avversario di parlare; lo trovo un gesto subdolamente violento, e in genere perfino controproducente, perché ti fa passare dalla parte del torto anche quando avresti ragione. Ma da qui a parlare di censura ce ne passa: soprattutto se consideriamo che il governo e la ministra non costituiscono un gruppo di normali cittadini, visto che hanno miliardi di modi per poter esprimere il loro pensiero, per addirittura trasformarlo in leggi e quasi per obbligarci ad ascoltarlo. E così si arriva facilmente al paradosso che chi controlla tutti i canali istituzionali e tutta la televisione pubblica, tra l’altro in modo abbastanza spudorato, arrivi a sostenere di essere stato zittito da una decina di ragazzini, cosa che a ben guardare fa un po' ridere.
Ma ormai mi sembra che la politica italiana sia questo: aspettare che qualcuno ti attacchi per poterti poi lamentare per settimane a mezzo stampa. E dire che pochi anni fa non era così: se vi ricordate nel 2009 Berlusconi, durante un comizio a Milano, si vide lanciare in faccia una statuina del Duomo, con un gesto – quello sì, davvero – di grande violenza. L'autore di quel fattaccio era, se ricordo bene, un folle, ma l'allora leader di Forza Italia non ne fece chissà quale dramma e anzi si impegnò a mostrarsi subito di nuovo in forma, pronto a ritornare presto all'agone politico. Su Berlusconi si possono avere opinioni diverse e anche lui non mancò di mostrarsi spesso come vittima, ma certo non si può dire che si faceva spaventare da un paio di contestatori; e se andiamo più indietro nel tempo troviamo che i politici di una volta erano molto più forti e resistenti di quelli di oggi (ricordate Togliatti, a cui perfino spararono ma che si premurò di sopravvivere soprattutto per dire ai suoi di darsi una calmata?).
D'altronde, all'epoca il vittimismo non rendeva: un politico doveva mostrarsi capace, resistente, più forte delle contestazioni, e certo non bastavano pochi facinorosi per zittirlo. Farsi spaventare da un gruppo di ragazzini era un segno di debolezza, non di forza; e poteva forse rappresentare anzi un passo falso nella carriera. D'altronde i politici di una volta in certi casi erano stati partigiani, e quando si scampa alle pallottole si capisce che qualche urlo non fa poi male. Oggi, cresciuti nella bambagia, ci lamentiamo di quisquilie che non meriterebbero neanche un trafiletto a pagina sette, e invece ne creiamo un caso politico infinito.
Si dirà che questa è la precisa strategia di Giorgia Meloni e di molti esponenti delle destre radicali europee: quella di presentarsi come l'unica voce avversa al pensiero unico (e per questo bersagliata), quella di far sentire il proprio elettorato sotto costante attacco, quella di generare paura, perché la paura rende bene a livello elettorale. Certamente c'è, dietro a questo perenne ricorso al vittimismo, anche qualcosa del genere, ma mi sembra che almeno in certi casi il vittimismo sia sincero, spontaneo, non calcolato; e che proprio per questo sia anche profondamente diseducativo. Perché il vittimismo ormai non riguarda più, com’è stato per molto tempo, solo gli esponenti dei partiti post-fascisti; inizia a permeare anche molti altri ambiti.
A scuola è diventata ad esempio quasi la norma: noi insegnanti ci atteggiamo costantemente a vittime, di volta in volta di genitori, di studenti o del ministero; a loro volta i genitori non sono da meno, convinti che la scuola non lavori per far crescere i loro figli ma per punirli o umiliarli; per non parlare poi degli studenti, che, in questo clima, si sentono molto più bersagliati di quanto in realtà non siano. Tutti si sentono vittime di qualcuno o di qualcosa, e pochi mi sembra abbiano la forza davvero di reagire a tutto questo. D'altronde, se ci si sente soli come siamo soli in questa fase storica, è chiaro che in un certo senso ci ritroviamo soli contro il mondo; e che ci sentiamo abbandonati, isolati, colpevolizzati.
Per carità, queste caratteristiche, in qualche persona, ci sono sempre state: anche venti o trent'anni fa la scuola aveva i professori lamentosi o gli studenti convinti che si fosse messa in atto una persecuzione contro di loro; ma questi toni venivano stemperati da altri atteggiamenti uguali e contrari, molto diffusi, come quelli di chi affrontava la vita con più leggerezza, rispondeva ai problemi con una risata o semplicemente mandava a quel paese tutto e tutti e non si faceva abbattere da qualche piccola magagna quotidiana.
Lo dico spesso, ultimamente, anche ai miei studenti, che trovo intelligenti, bravi, ma poco sicuri di loro stessi, incerti e titubanti: che dovrebbero paradossalmente imparare a mandare a quel paese a scuola, imparare a tenere lontani da sé i voti, a vedere tutto l'apparato come qualcosa che non li definisce e che non li deve neppure più di tanto colpire. In realtà anche la scuola è un gioco di delicati equilibri: bisogna imparare ad ascoltare quello che gli insegnanti ci dicono e ci propongono, senza però diventarne appunto vittime; bisogna far tesoro delle cadute, senza però pensare che quelle cadute davvero ci rappresentino; bisogna da un lato ascoltare e dall'altro tapparsi le orecchie, mettendo in campo attenzione e distacco allo stesso tempo.
Ma se ci pensate bene questo è quello che dovremmo fare in ogni istante della nostra vita: badare a quello che ci accade, ma allo stesso tempo prendere tutto quello che succede con almeno un po' di leggerezza; piangere e poi ridere e poi piangere di nuovo, e poi ridere nuovamente: perché la vita in fondo è sempre un dramma che muta in commedia, e a sua volta una commedia che muta in dramma.
E invece ci siamo trasformati un po' tutti in delle drama queen, come si dice oggi, cioè delle persone che amano piangersi addosso, lamentarsi di quanto sono sfortunate e subire passivamente gli eventi, senza riuscire a imparare alcunché da essi e senza quindi neppure riuscire a cambiare davvero la propria esistenza. Per questo dico che il vittimismo non è solo un problema della politica, dove forse emerge in maniera più lampante, ma è anche un problema della nostra società: ci lamentiamo sempre e però in concreto facciamo molto poco, o meno di quanto potremmo, per cambiare le cose. La lamentela, l'altra parte, ci porta ad un circolo vizioso: si auto-alimenta e ci dà un contentino col minimo sforzo, facendoci evitare di affrontare davvero i problemi.
E allora, chiediamo ai politici di resistere un po' più strenuamente a qualche piccola contestazione, ma chiediamo anche a noi stessi di reagire meglio agli impegni della vita, di imparare a ridere delle nostre magagne e dei nostri problemi e magari di disarmare anche qualche lamentela altrui, mostrando a tutti il lato ironico della nostra esistenza.
Quello che ho registrato e pubblicato
Passiamo ora ai video e ai podcast che sono usciti questa settimana, se ve li siete persi:
I totalitarismi del '900 in un'ora: ricapitoliamo la storia del nazismo e dello stalinismo nel secolo scorso
La filosofia ebraica medievale: un percorso attraverso i più importanti filosofi ebrei del Medioevo, tra Avicebron e Maimonide
Introduzione a John Locke (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
Ragione ed esperienza per John Locke (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
La fine della Prima guerra mondiale (per il podcast “Dentro alla storia”)
I trattati di pace della Prima guerra mondiale (per il podcast “Dentro alla storia”)
Quello che devi fare per seguirmi sui social
Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:
Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads
Quello che puoi fare per sostenere il canale
Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i nostri consigli della settimana.
Storie di Erodoto: Erodoto è forse il primo grande storico della nostra cultura: le sue Storie sono infatti la prima opera di questo genere ad essere giunta fino a noi nella sua interezza. Studiate e ristudiate, analizzate criticamente, esaltate o ridimensionate, le Storie sono uno dei capisaldi imprescindibili della nostra conoscenza della cultura greca. Prima o poi, dunque, vanno affrontate, anche se il volume è corposo e impegnativo; per fortuna ne esistono buone edizioni a un prezzo accessibile. Quella che vi consiglio oggi appartiene a questo filone e può essere acquistata qui.
sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):
C’è poi un nuovo modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ne è comparso uno nuovo chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.
Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!
Quello che c’è in arrivo
Chiudiamo, come sempre, anche con qualche anticipazione su quello che dovrebbe uscire sul canale nei prossimi giorni:
domani toccherà a uno short, un video breve, incentrato sul mito del buon selvaggio e su Rousseau;
mercoledì arriverà poi – se tutto va bene – il video di storia antica che era inizialmente previsto per questa settimana, quello sull’antica Israele;
giovedì dovrebbe uscire la penultima puntata in assoluto della lettura integrale del Saggio sulla libertà di John Stuart Mill;
venerdì e sabato torneranno quindi i podcast, con Locke da una parte e le conseguenze della Prima guerra mondiale dall’altra;
domenica, poi, vorrei fare un video della serie Video Club storico-filosofico, ma non vi rivelo ancora su cosa;
lunedì, infine, potrebbe essere la volta del Simposio di maggio (anche se la data è ancora da decidere ufficialmente): il tema sarà impegnativo, e cioè “Esiste un senso della vita? E, se sì, è oggettivo o soggettivo?”.
E questo è tutto anche per questa settimana. L’anno scolastico ormai volge verso la fine, si approssimano gli Esami di Stato e soprattutto si avvicina anche qualche novità di cui, tra un paio di settimane, vi inizierò a parlare. Restate sintonizzatevi e, intanto, godetevi la settimana. A lunedì prossimo!







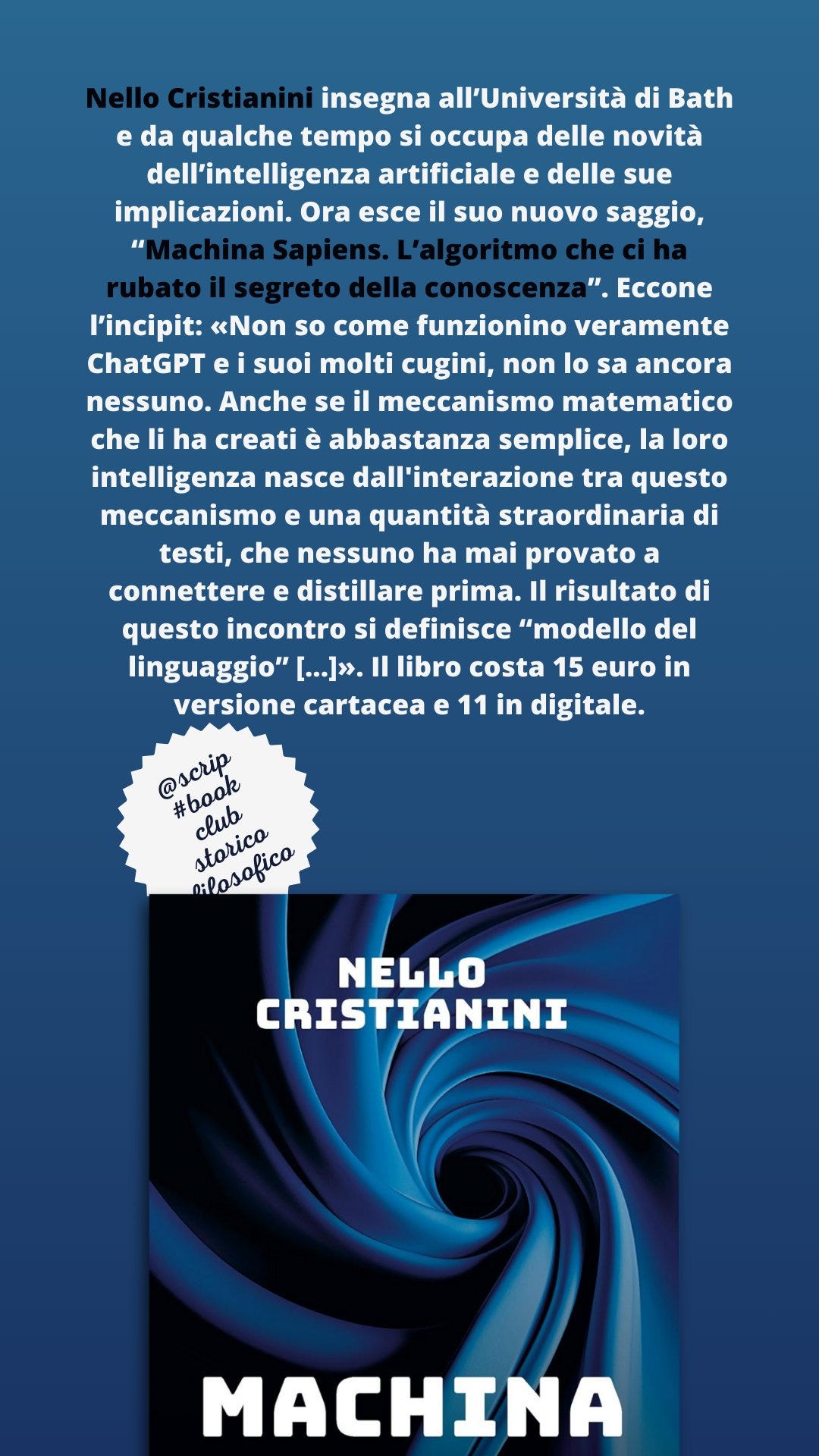
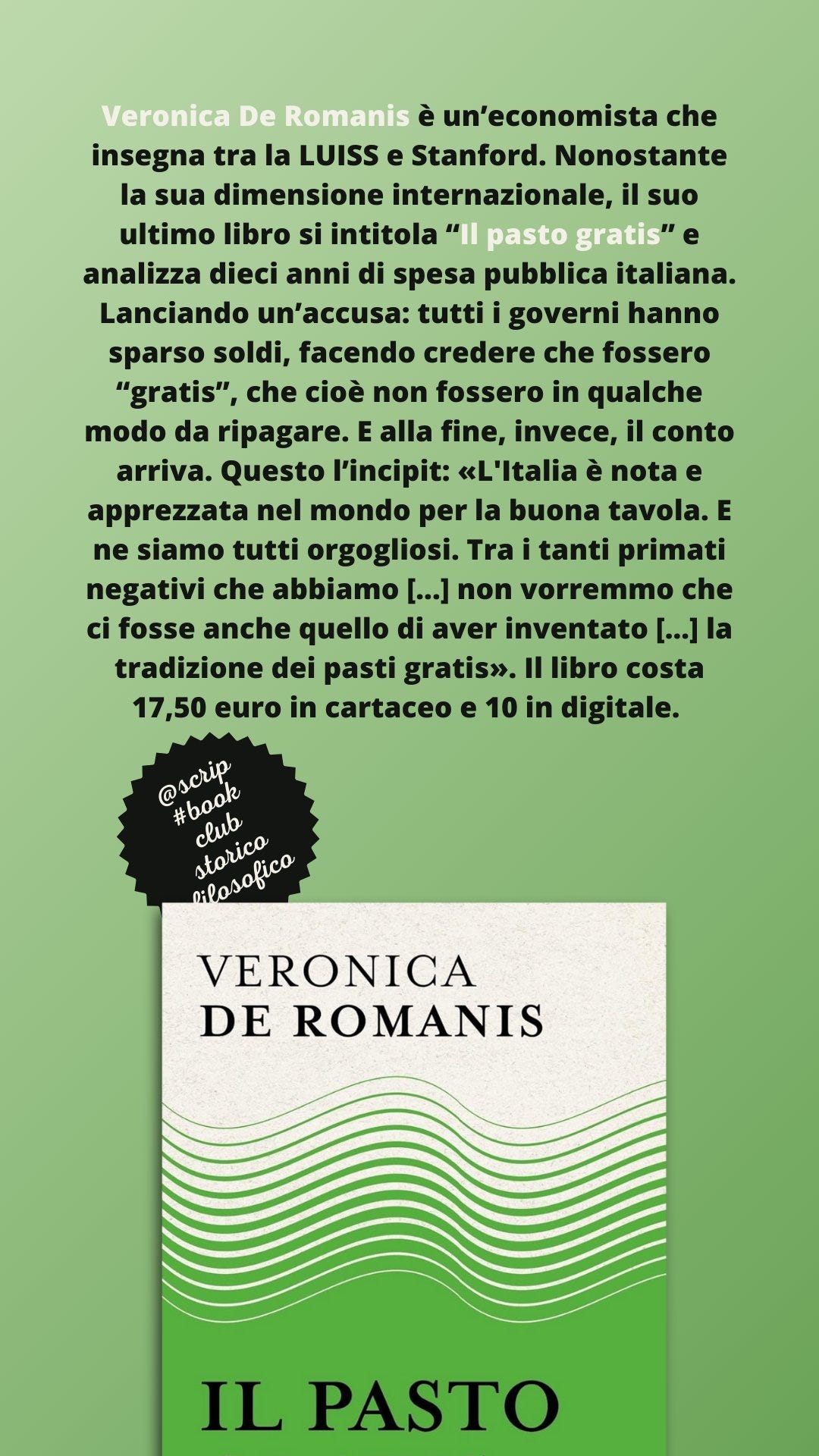

Vediamo che lo Stato di israele e la Palestina sono in guerra da decenni .
La causa di questo conflitto perenne potrebbe essere che gli ebrei sono credenti di Jehova
e i palestinesi credono fortemente , come gli ebrei , di Allah e che considerino reciprocamente degli infedeli , che devono essere sottomessi alla ( secondo il proprio limitato
e dogmatico punto di vista ) vera religione o vanno sterminati? Lo propongo come spunto di riflessione.
Sempre eccellente, prof!