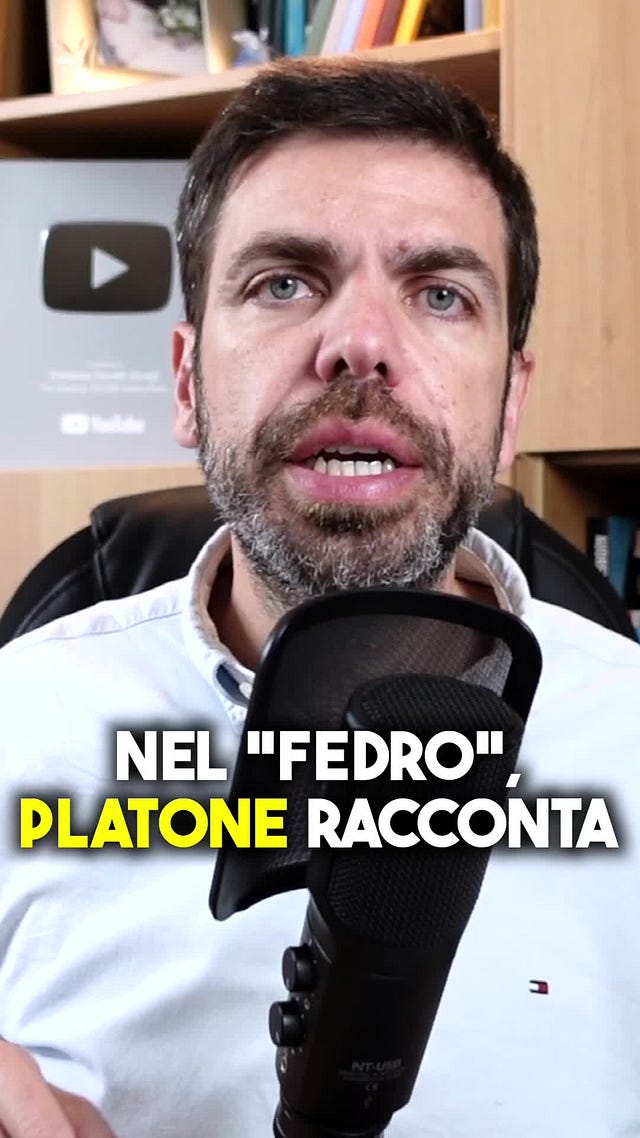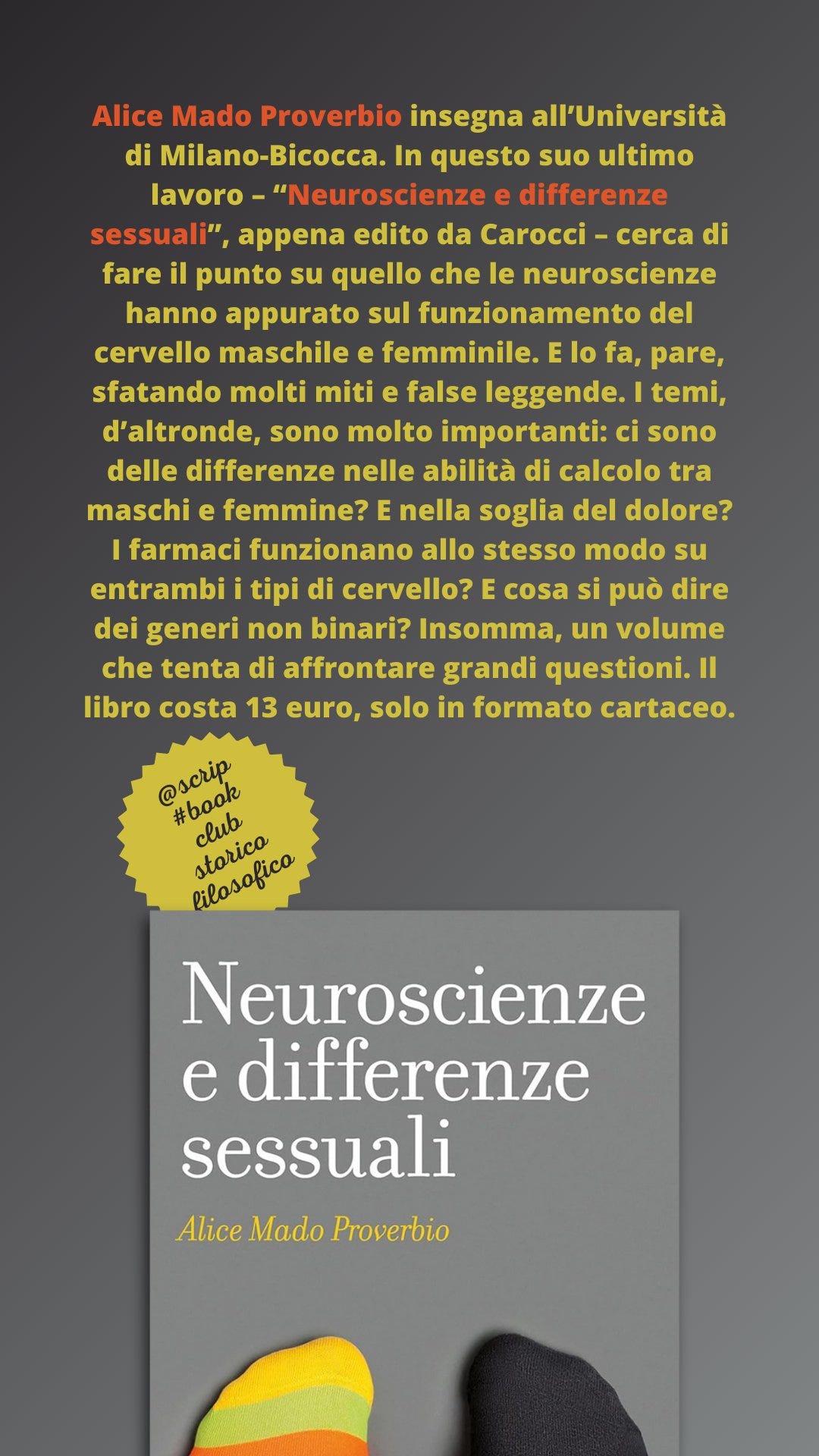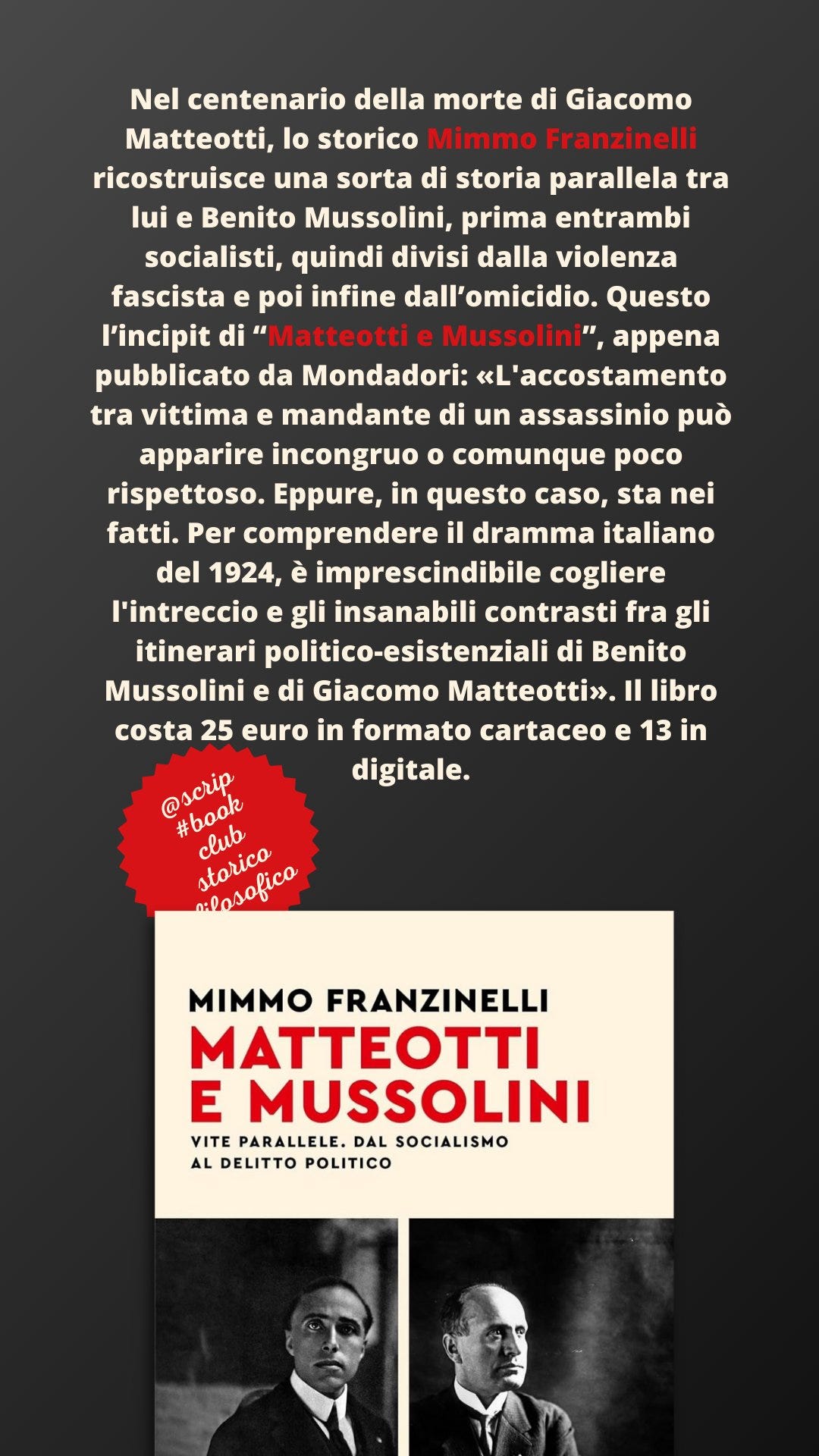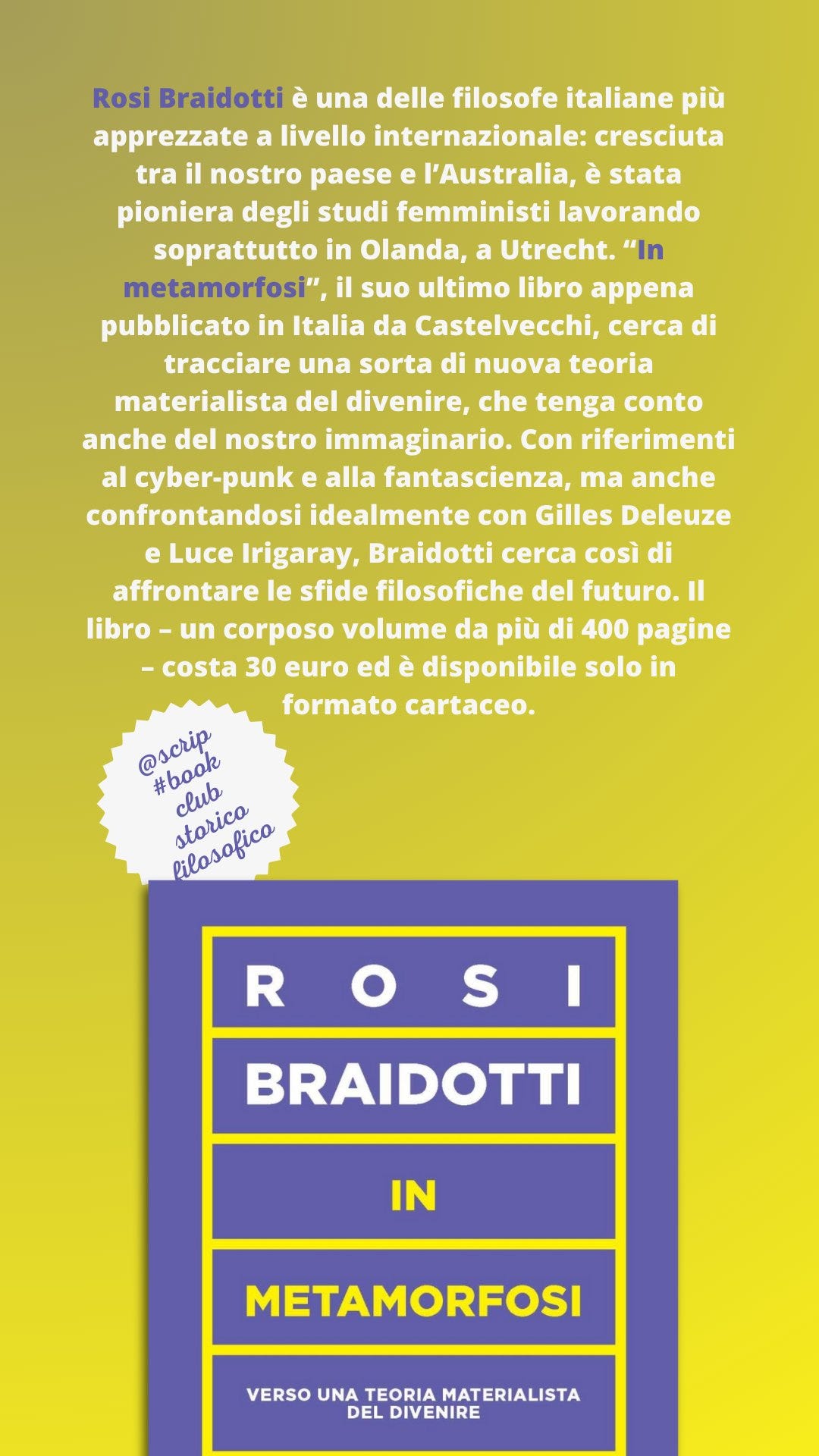Sulle mescolanze di filosofia, tecnica e umanità, ma anche su Baby Reindeer, Il problema dei tre corpi, la pace di Kant, la detenzione di Guareschi, la filosofia di Croce, l'amore di Notting Hill
Ed eccoci qui, pienamente ormai dentro al mese di maggio. Non mi sono ancora abituato a scrivere “2024” alla fine delle date, e già siamo in procinto di arrivare alla metà dell’anno. Ma il guaio non è tanto questo: è che ad agosto compirò 45 anni e continuo a dire in giro, quando me lo chiedono, che di anni ne ho 42; poi magari mi correggo: «No, aspetta, 43! Non mi ci sono ancora abituato». E solo qualche ora dopo, a casa, ripensandoci, mi rendo conto che ne ho 44 e mezzo, e che non mi sono corretto per niente.
La settimana scorsa è stata piuttosto intensa, nonostante la giornata di pausa del 1° maggio e finalmente ritmi un po’ più rilassati in famiglia (i campionati sportivi dei figli stanno, grazie al cielo, finendo). Martedì sera ho partecipato all’evento di cui vi raccontavo la settimana scorsa, e ora quell’intervento è disponibile online: una piccola cosa, ma mi piace essere riuscito a condividerla sul canale. La trovate più avanti, nella sezione Quello che ho registrato e pubblicato.
Per il resto, sono stato catturato soprattutto dalla scuola: si iniziano a stendere i programmi per l’Esame di Stato (sarò esterno, e spero di non finire troppo distante da casa), si programmano già attività per l’anno prossimo, si correggono le ultime, numerose verifiche. E di tanto in tanto si incontra anche qualche ex alunno, com’è successo questa settimana, a rimembrare insieme quello che accadeva pochi anni fa in quegli stessi banchi in cui insegno ancora oggi, e a capire come la vivevano i ragazzi, quell’esperienza, cosa allora non ti dicevano e adesso possono confessarti.
L’esperienza della scuola è sempre particolare, unica, e però fondamentale nella vita di ognuno. Le scuole superiori, nel bene e nel male, ci danno l’ultimo tocco, costituiscono l’ultima spinta alla nostra formazione, non solo cognitiva ma anche umana; a volte danno il tocco giusto, a volte quello sbagliato, molto più spesso stanno nel mezzo: ma sono comunque tocchi fondamentali.
Certo oggi la scuola mi pare sempre più in crisi; in primo luogo come istituzione, in secondo luogo però anche dal punto di vista umano. I ragazzi ci chiedono non più solo un luogo in cui apprendere – com’è sempre stato, più o meno –, ma anche un luogo in cui crescere e in cui trovare un proprio equilibrio; e la scuola quest’ultimo aspetto, quest’ultima domanda non sa ancora soddisfarla.
I perché sarebbero molti e discuterne ci porterebbe via molto tempo: magari più avanti, nelle prossime settimane, avremo modo di soffermarci su alcuni di questi. Oggi però lasciamoci trascinare da altri temi, cominciando come sempre dai libri.
Quello che ho letto
Nell’elenco di questa settimana, tra l’altro, ci sono due libri che ci lasciano, perché li ho finiti di volata. Vediamoli.
Diario clandestino di Giovannino Guareschi: in primo luogo, ho cominciato e rapidamente terminato la lettura di questo breve libro che è stato in casa mia per decenni e che però non avevo mai affrontato. Il Diario clandestino di Guareschi è infatti un volume che credo appartenga a mio padre, molto invecchiato e ingiallito, che però proprio in queste settimane ho ripreso in mano per un interesse molto concreto, nato a scuola. Come forse vi ha raccontato in altre occasioni, infatti, da qualche mese sto lavorando assieme a un gruppo di ragazzi al recupero di alcune fonti documentarie sull'internamento dei militari italiani in Germania durante la Seconda guerra mondiale, nelle ultime fasi del conflitto. E, oltre ai documenti storici veri e propri, stiamo cercando di recuperare un po' anche la memorialistica e di ricostruire il modo in cui la cultura italiana del tempo raccontò quella triste vicenda. Il Diario clandestino è, da questo punto di vista, una delle fonti più famose: l'umorista italiano, creatore di don Camillo e Peppone e di tanti altri personaggi, venne infatti internato in Germania per tutto l’ultimo anno e mezzo di guerra, e dopo la liberazione raccontò almeno in parte quell'esperienza appunto in questo libriccino. Contrariamente a quanto il titolo può lasciar pensare, però, non si tratta di un vero e proprio diario, perché già nella premessa Guareschi spiega che in realtà un diario l'aveva anche tenuto, ma che sarebbe stato scorretto darlo alle stampe senza coinvolgere le altre persone che condividevano la prigionia con lui; e allora in questo libro decise di pubblicare i racconti, un po' fantastici e un po' tristi, oltre che umoristici, che scrisse proprio nel lager e che lesse ai suoi compagni, aiutandoli così a superare quei difficili momenti. Così il libro si configura come una raccolta di raccontini molto brevi e animati da una fervida fantasia, che però ci fanno indirettamente comprendere come ci si sentisse all'interno di questi campi, quanto si sognasse di scappare, di tornare a casa o di avere di che mangiare e di che sopravvivere. Ogni tanto si ride, ma molto più spesso si percepisce il muto dolore degli internati; spesso, tra l’altro, si sogna, e alcuni di questi racconti sono in questo senso molto belli. Se vi interessa, il libro può oggi essere acquistato qui.
Per la pace perpetua di Immanuel Kant: il prossimo 8 maggio si terrà la consueta riunione del Club del libro, l'appuntamento riservato gli abbonati del canale in cui discutiamo di libri che abbiamo letto nel mese precedente. Questa volta al posto di un solo libro ce ne saranno due in discussione: la Lettera sulla tolleranza di John Locke, di cui vi ho parlato qualche puntata fa, e Per la pace perpetua di Immanuel Kant, che ho terminato proprio in questi giorni. Sul libro di Kant non c'è molto da aggiungere rispetto a quello che tendenzialmente già si sa: è un saggio molto breve e però dalle aspirazioni molto alte, visto che si propone di stendere una serie di articoli che secondo Kant sarebbero stati necessari per garantire pace in Europa e nel mondo per i tempi futuri. L’intento è assai nobile, com’è facile intuire, e bisogna anche ammettere che il filosofo tedesco ebbe delle intuizioni interessanti, che poi la storia ha confermato come necessarie affinché si raggiunga davvero la pace; d'altro canto, su alcuni altri punti inevitabilmente il discorso di Kant è superato, anche perché venne fatto quasi 250 anni fa, in un’Europa assai diversa da quella attuale. In ogni caso confrontarsi con questo testo penso sia fondamentale per riconsiderare come oggi i nostri Stati siano organizzati e come si regoli il diritto internazionale, soprattutto in un momento storico come il nostro, in cui la guerra sembra di nuovo farla da padrona. Se vi interessa, lo potete acquistare qui.
Nudge. La spinta gentile di Richard Thaler e Cass Sunstein: questa settimana ho dato infine anche una bella letta ad almeno un centinaio di pagine di Nudge, il libro di cui vi ho già parlato altre volte e che propone delle soluzioni di “paternalismo libertario” davanti a tanti problemi che affliggono la nostra società contemporanea. L'approccio dei due autori mi pare interessante, pure condivisibile in alcuni punti, anche se su certi temi mi sembra forse un po' estremo. Cercando di spiegarvelo in maniera concisa, direi che i due studiosi ritengono che all'individuo debba essere lasciata la massima libertà su praticamente tutti i temi che riguardano le scelte individuali, ma che allo stesso tempo lo Stato dovrebbe suggerire, tramite quello che loro chiamano un “pungolo”, una sorta di soluzione ottimale per l’individuo stesso, senza però imporla con la forza. Ad esempio, secondo loro lo Stato non dovrebbe creare un piano pensionistico statale per i lavoratori, ma dovrebbe lasciare che sia il libero mercato, in forma privatistica, ad offrire degli adeguati piani pensionistici a tutti i dipendenti; allo stesso tempo, però, lo Stato dovrebbe aiutare le persone a fare la scelta migliore, ad esempio offrendo simulazioni della resa dei diversi piani, oppure proponendo un piano standard abbastanza efficace in cui si aderirebbe in automatico, a meno che non si faccia una scelta diversa. I due autori parlano insomma proprio di una “spinta gentile”, che inclina senza obbligare, e che lascia quindi agli individui la responsabilità della scelta quando questi se la vogliono prendere, ma che concede anche una scelta standard efficace (e automatica) qualora preferissero affidarsi al suggerimento dello Stato. Personalmente credo che in certi ambiti che questa linea possa risultare molto efficace, ma non in tutti: questa forma libertaria, infatti, presuppone che i cittadini siano in grado di operare scelte consapevoli e sagge in molte circostanze della vita, e che al limite possa bastare un pungolo per (ri)portarli sulla retta via. Per quanto io sia d'accordo sull'idea che la libertà di scelta debba essere preservata, visto soprattutto che io stesso vorrei scegliere per me senza che nessuna autorità (che spesso giudico più insulsa e stupida di me) mi imponga il suo volere, ritengo d'altra parte che ci siano persone che, per ignoranza e incapacità, spesso scelgano contrariamente ai loro stessi interessi, senza neppure rendersene conto. Cosa fare con costoro? Lasciare che si facciano del male? Mostrare loro la retta via sperando che se ne lascino convincere? Pungolarle e basta? Oppure offrire delle soluzioni statali obbligatorie che certo limiteranno un po' la loro libertà ma eviteranno drammi ben peggiori? Il tema è complicato, e penso che vada districato caso per caso; un approccio troppo ideologico davanti a questioni così problematiche mi pare riduttivo e forse questo è l'unico vero difetto del libro, che su certi temi mi sembra tranchant; ad ogni modo, offre comunque molti spunti interessanti. Se volete comprarlo, lo trovate qui.
Quello che ho visto
E passiamo ora ai film, anzi ai film e alle serie tv (che anzi rappresentano la novità più interessante della settimana, credo).
Il problema dei tre corpi episodio 1.05 (2024), di David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo, con Saamer Usmani, Marlo Kelly, Jess Hong: di settimana in settimana continuo da un po' di tempo a parlarvi de Il problema dei tre corpi, anche perché sto vedendo una puntata a settimana e quindi, nonostante si tratti di una miniserie, me la sto portando dietro con calma. Devo dire che, giunto al quinto episodio, forse posso provare a trarre anche qualche prima conclusione sulla qualità dell'adattamento di uno dei libri che più ho amato negli ultimi mesi, e di cui vi ho parlato anche qui l'anno scorso. Nonostante il romanzo di Liu Cixin sia complicato e difficilissimo da rendere in un’opera cinematografica, devo dire che secondo me gli sceneggiatori della serie ospitata da Netflix hanno fatto tutto sommato un buon lavoro. Per certi versi, inevitabilmente, la serie è peggiore del libro, però devo anche dire che quel libro, per come era scritto e impostato, non avrebbe secondo me mai davvero funzionato sul piccolo schermo. Se insomma lo si voleva adattare per la tv, bisognava trasformarlo in qualcosa di diverso, in qualcosa che preservasse in parte lo spirito originale dell'opera letteraria, ma che vi aggiungesse anche una trattazione diversa dei personaggi, un maggior lato umano e una storia un po' più lineare e facile da seguire. In questo mi sembra che gli sceneggiatori abbiano, come dicevo, raggiunto il loro scopo e reso tutto sommato accessibile un'opera che altrimenti sarebbe stata confinata allo stretto giro degli appassionati di fisica e di fantascienza, senza arrivare al grande pubblico. Insomma, per ora mi sento abbastanza soddisfatto. Certo, potrebbe anche darsi che nelle ultime puntate rovinino tutto, ma almeno fin qui mi sono divertito e devo dire che, pur con qualche semplificazione, mi sembra che si sia anche rispettata l'opera di partenza. La serie – che quindi per ora mi sento anche di consigliare – la trovate su Netflix.
Baby Reindeer (2024), di Richard Gadd, con Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau: spinto dal fatto che ne ho sentito parlare in qualche occasione in questi giorni, ho provato a guardare su Netflix una nuova miniserie appena uscita che per la verità non rientra nei generi che di solito amo: si tratta di Baby Reindeer, show un po’ inquietante tratto da una storia vera. Il protagonista è un aspirante comico che vive a Londra e che, nell'attesa di sfondare, lavora come barman in un pub. Proprio svolgendo questo mestiere incontra un giorno una donna più vecchia di lui che gli fa un po' pena, perché sovrappeso, sola e apparentemente senza denaro. Per questo motivo inizia a rivolgerle la parola e a scherzare con lei, ma questa scelta nel giro di poco tempo alimenta un circolo vizioso per cui la donna comincia a ripresentarsi sempre più spesso al locale e a tormentare il ragazzo, convinta che tra i due possa nascere qualcosa di serio. La cosa sembrerebbe fin qui simile a tante altre storie che accadono quotidianamente, se non fosse che ad un certo punto la situazione degenera e il barman scopre che la donna è stata radiata dall'ordine degli avvocati per accuse di stalking ed è stata anche condannata in passato per questo stesso reato. La tinta della narrazione, se all’inizio era quasi leggera, diventa così rapidamente fosca, senza contare poi che lo stesso protagonista commette una serie di errori marchiani che peggiorano la situazione, invischiandolo in un vortice da cui ad un certo punto non sembra quasi esserci via d’uscita. In genere tutta questa inquietudine e questo calarsi nella mente del maniaco non mi attirano granché, ma credo che in questo caso proseguirò fino alla fine della serie, giusto per vedere anche come va a finire la vicenda. Se vi interessa e siete appassionati di queste storie tristi e tragiche, la trovate su Netflix.
Notting Hill (1999), di Roger Michell, con Hugh Grant, Julia Roberts, Rhys Ifans: penso che Notting Hill l'abbiate prima o poi visto tutti: è uno dei film più famosi degli anni '90, anche se uscì alla fine del decennio, ed è contemporaneamente anche uno dei più facili da guardare: la storia è romantica e ironica, cattura facilmente l'attenzione dello spettatore e gli regala una serie di sogni tutto sommato a buon mercato. Detta così, potrebbe sembrare che la mia recensione si prepari ad essere particolarmente cattiva, invece tutto sommato la pellicola con Hugh Grant e Julia Roberts mi piace: riesce, pur in una certa prevedibilità, a risultare convincente, anche a distanza di tanti anni. Sarà per lo charme di Hugh Grant, sarà per il fatto che le favole ci incantano sempre, ma credo che la pellicola colpisca ancora nel segno, o almeno a me riesce a fare quell'effetto. Se siete tra i pochissimi che non l'hanno mai vista, sappiate che la trama ruota attorno a un timido e un po' impacciato libraio di Notting Hill, bel quartiere di Londra, che per caso si imbatte in una diva del cinema americano che si trova in città per realizzare un film. Tra i due scatta ovviamente l'amore, reso però complicato dall'immensa fama di lei. Non vi rivelo ovviamente il finale, ma posso dirvi che la pellicola può essere vista come una sorta di riedizione aggiornata e corretta di Vacanze romane, di cui vi parlavo giusto la settimana scorsa; solo che qui al posto di una principessa c'è un'attrice un po' più esperta delle cose del mondo, e al posto della Roma degli anni '50 la Londra degli anni '90. Il film potete vederlo facilmente su Netflix, ma se siete di animo romantico potete pensare anche a comprarlo tramite questo link.
Quello che ho pensato
Come avrete visto nell'introduzione di questa newsletter e poi come vedrete anche scartabellando tra i video usciti questa settimana, qualche giorno fa mi sono trovato in un teatro qui in provincia a parlare dell'utilità della filosofia.
Ho aperto quel breve intervento dicendo che la filosofia in realtà non serve a niente, che è una materia apparentemente inutile, salvo puoi passare i successivi dieci minuti a cercare di dimostrare esattamente il contrario. Non so se ci sono riuscito, ma qui vorrei spendere qualche riga per parlarvi di una questione che in quel breve intervento non sono riuscito a toccare ma che mi sembra completi bene il discorso in oggetto.
In quell'intervento sostenevo infatti che la filosofia in realtà è molto utile perché aiuta a fare i conti con le decisioni quotidiane, con quello che facciamo e usiamo ogni giorno, perfino con le convenzioni sociali; aiuta a capirle, perfino a disarmarle e analizzarle, in modo da diventare veramente padroni della propria vita. Confermo tutto quello che ho detto là, e lo ritengo profondamente vero, ma vorrei aggiungere un altro discorso sull'utilità e l'inutilità della filosofia.
Il titolo della serata che si è svolta in quel teatro era “L'utilità dell'inutile”, una sorta di ripresa di un saggio di Nuccio Ordine di cui ho parlato anche qui sulla newsletter qualche tempo fa. In quel breve libro, lo studioso italiano si prodigava a sminuire tutto ciò che è normalmente ritenuto utile, cioè tutto ciò che appare come “economico e profittevole”, esaltando invece ciò che è apparentemente inutile, cioè ciò che non genera profitto, come appunto l'arte e la filosofia. Ecco, io penso che quel discorso fosse profondamente sbagliato fin dalle premesse, e purtroppo infici buona parte del nostro approccio nei confronti della filosofia e di quelle che normalmente vengono chiamate scienze umane. Non è raro, infatti, che discorsi del genere vengano fatti in difesa del latino, del greco, della filosofia stessa: e si dice che queste discipline magari non servono a niente, ma sono molto belle, e il loro valore sta proprio in questa bellezza libera da doppi fini.
Ecco, io contesto il fatto che non servano a niente, come contesto assolutamente il fatto che ciò che è utile sia brutto proprio in quanto utile. A me pare che questo sia, anzi, un modo piuttosto superficiale di vedere la questione, prodotto da chi magari non ha mai compreso del tutto la bellezza della scienza e della tecnologia e non si sia mai reso conto di quanto proprio scienza e tecnologia siano legati alla dimensione umana dell'esistenza. Detta in altri termini, e più brutalmente: un cellulare di oggi parla dell'uomo tanto quanto ne parla l’Odissea di Omero, e forse anche di più, anche se ovviamente lo fa in un modo assai diverso, con un linguaggio differente.
Proviamo a sviluppare quella che qui può sembrare solo una frase provocatoria, ma in cui in realtà c'è qualcosa secondo me di vero. Prendiamo idealmente in mano un cellulare: dentro ci troviamo intanto delle parti fisiche, materiali, come il silicio che abbiamo estratto dalla terra e abbiamo adattato ai nostri scopi, come i circuiti che abbiamo creato da zero, come il vetro che abbiamo iniziato a lavorare fin dall'antichità, e come molti altri materiali che manifestano le esigenze emerse nella storia dell'umanità.
Ma poi c'è anche una parte software, costituita dal sistema operativo e da tutte le app installate nel dispositivo, applicazioni che seguono la dinamica delle azioni umane, che funzionano grazie ad algoritmi basati sulla logica che avuto la sua origine con Aristotele ed è poi proseguita con gli stoici, che perfino permettono di mettere in contatto le persone tra loro. Come si può pensare che un cellulare sia un mero oggetto, una fredda tecnologia? È un oggetto che crea connessioni, a volte anche disturbanti e problematiche, ma comunque connessioni tra esseri umani; è, anzi, forse l'oggetto più umano che utilizziamo nella vita e tutti i giorni. Un martello non ci permette di creare connessioni comparabili a quelle di un cellulare; e perfino un libro, da questo punto di vista, può essere più “freddo” e morto di un cellulare.
L’Odissea di Omero, d'altra parte, è sì un testo che parla di storie umane, ma ha anch’esso una sua componente in un certo senso “tecnologica”: la poesia, se ci pensate anche solo un attimo, è fondata sulla metrica, cioè in un certo senso sulla matematica; i versi si costruiscono con una precisa cadenza di accenti, e anche nelle rime c'è molta tecnica, che va a convivere con l'ispirazione. Come un cellulare è uno strano miscuglio di abilità tecniche e umanità, così in fondo lo è anche un’opera letteraria. Certo non voglio dire che abbiano lo stesso valore o che funzionino esattamente allo stesso modo, ma la struttura di quegli oggetti è molto più simile di quanto non vogliamo ammettere.
Non esiste, cioè, il lato umano separato dal lato tecnologico: le tue dimensioni sono sempre convissute e si sono sempre influenzate a vicenda. Un divertente libro di qualche anno fa, scritto dal narratore inglese Nick Hornby, si intitolava Shakespeare scriveva per soldi, titolo che ho sempre trovato geniale: perché è facile dire che la grande poesia non obbedisce alle leggi del mercato, ma in realtà è spesso anche molto falso, perché i poeti, soprattutto quelli più grandi, hanno quasi sempre obbedito alle logiche del mercato. Shakespeare, Virgilio, Ariosto e moltissimi altri grandi creatori di versi hanno cercato dei committenti e dei mecenati, lavorando anche per soddisfare le loro richieste; e così anche Leonardo, Michelangelo, Raffaello e miliardi di altri grandi artisti hanno dovuto fare i conti con la realtà economica del loro tempo. Economia, tecnologia e umanità sono facce diverse di una stessa medaglia, in realtà inseparabili l'una dall'altra.
Certo, tra tutte queste dimensioni c’è un equilibrio molto delicato, per cui può capitare che a volte le leggi del mercato sovrastino l'ispirazione e perfino la tecnica, oppure che lo squilibrio si senta su altri versanti; e questo può dare origine a opere più o meno riuscite, e a situazioni più o meno problematiche. Ciò non toglie che però la separazione netta di questi abiti è spesso artificiosa, spesso dettata da un idealismo di stampo crociano che non è solo superato dai tempi, ma che è sempre stata solo una costruzione a tavolino, un bel sogno a cui si appigliavano quelli che avevano paura che la scienza stesse per dominare il mondo.
Purtroppo per loro, la scienza ha sempre dominato il mondo; purtroppo per loro non esiste una vera separazione tra materia e spirito, tra fisica e filosofia, tra corpo e mente: anche Platone ed Aristotele cercavano di arrivare alla scienza, e quando compivano quel percorso spesso lo facevano con parole poetiche o a partire da riflessioni sull’uomo.
Quindi la filosofia non può certo dirsi inutile: anzi è forse la disciplina che più di tutte riesce a mescolare al massimo grado quei diversi ambiti. Nella filosofia c'è una grande attenzione ovviamente al lato umano, ma c'è anche molta tecnica, c'è anche molta scienza, c'è perfino anche una certa dose di interesse economico: quando il pensiero dei grandi filosofi si occupa di politica, ad esempio, questa dimensione torna sempre in primo piano. Così come non bisogna dimenticare che tutti i più grandi filosofi hanno avuto a che fare col potere, economico e non solo: Platone voleva fare la rivoluzione, Aristotele educò Alessandro Magno, Tommaso d’Aquino dava istruzioni alle autorità della Chiesa, Guglielmo di Ockham si schierò con l'imperatore, lo stesso Hegel (l’idealista massimo, che tanto idealista nei fatti non era) fu accusato di essersi sostanzialmente venduto al re di Prussia. Senza pensare poi ai filosofi del '900, che arrivarono a schierarsi con più o meno tutti i partiti politici, dall’estrema sinistra all’estrema destra.
Insomma, non esiste il pensiero puro, così come non esiste la scienza pura e non esiste l'economia pura: esistono miscugli complicati di tutte queste componenti che si influenzano a vicenda. Una teoria scientifica ha sempre il suo contenuto filosofico, e una dottrina politica spesso è influenzata sia dalla filosofia che dalla scienza; e, come diceva il francese Bruno Latour, spesso siamo a contatto piuttosto con degli ibridi, con dei sistemi misti in cui una componente emerge sulle altre, ma in cui gli altri fattori rimangono ben presenti sottotraccia a influenzare il risultato.
La filosofia, piuttosto, può avere il compito (importante) di far emergere queste influenze nascoste, dimostrarci come dietro a una tecnologia ci sia un certo approccio filosofico o come dietro alla filosofia ci sia un influsso economico. E diventare quindi utilissima per poter valutare meglio e più a fondo il mondo in cui siamo immersi, e poter anche magari cambiarne alcune cose (dal punto di vista tecnologico, economico, umano).
Quello che ho registrato e pubblicato
Facciamo però ora anche il punto sui video e sui podcast che ho pubblicato questa settimana:
Utilità e inutilità della filosofia: il mio intervento a teatro di cui vi parlavo anche sopra, per intero
Stile e brani dai libri di Dostoevskij: terzo e ultimo video (per ora) dedicato ai libri di Dostoevskij, con anche la lettura di qualche passo significativo
Il massacro delle Olimpiadi di Monaco 1972: la nostra storia delle Olimpiadi giunge a un evento tragico legato al terrorismo
Storia dei consumi 14: la critica al consumismo: continua il nostro percorso nella storia dei consumi, con lo sguardo critico dell’Occidente
I poteri del Leviatano secondo Hobbes (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
Verso l'ultimo anno di guerra (per il podcast “Dentro alla storia”)
Il mito della biga alata
Quello che devi fare per seguirmi sui social
Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:
Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads
Quello che puoi fare per sostenere il canale
Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i nostri consigli della settimana.
La mia filosofia di Benedetto Croce: ci sono stati pochi filosofi influenti, in Italia, quanto Benedetto Croce, e non a caso lo abbiamo citato solo qualche riga fa; conoscerne il pensiero, dunque, è importante non solo per curiosità filosofica, ma anche per capire un pezzo della nostra storia intellettuale, nel bene e nel male. Il libro che vi propongo questa settimana raccoglie diversi saggi, scelti dallo stesso Croce in modo che fossero introduttivi del suo pensiero, e pensati per un pubblico internazionale; è proprio per questo motivo che, oggi, il volume può risultare particolarmente interessante, anzi indispensabile se non si conosce già il pensiero del filosofo. Insomma, è assai consigliato. Lo potete acquistare qui.
sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):
C’è poi un nuovo modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ne è comparso uno nuovo chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.
Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!
Quello che c’è in arrivo
Concludiamo come sempre, prima di salutarci, con una panoramica sui video attesi in questa settimana appena cominciata:
domani e giovedì toccherà ai podcast, con l’inizio di Locke in Dentro alla filosofia e la conclusione della Prima guerra mondiale in Dentro alla storia;
nel mezzo, mercoledì, ci sarà la riunione del Club del Libro per gli abbonati del canale, dedicata proprio a Locke e a Kant;
venerdì poi penso arriverà un video sulla filosofia ebraica medievale;
sabato vorrei pubblicare quindi un video di storia dedicato agli ebrei e alla loro civiltà nell’antichità;
domenica e lunedì prossimi, infine, sarà la volta ancora dei podcast, con di nuovo Locke (inizieremo a vedere la sua gnoseologia) e le conseguenze della Prima guerra mondiale.
E questo è tutto. Ci vediamo qui tra sette giorni esatti: non mancate!