Elon Musk ovvero la nostra perenne (e deludente) ricerca di un messia, ma parliamo anche di Cecilia Sala, Benito Mussolini, Woody Allen, Luigi Pirandello, Only Murders in the Building e Guareschi
E così il 2024 è finito e il 2025 è cominciato. Un anno tondo tondo, un quarto di secolo. In termini storici, potremmo dire che l’inizio del XXI secolo è ormai finito e ci avviamo verso la sua metà: e dire che pare ieri – o almeno lo pare a me, che inizio ad avere una certa età – che ci preoccupavamo per il millennium bug, che aspettavamo il “mille e non più mille” e altre amenità del genere. Per quanto mi riguarda, ormai ho vissuto più anni nel XXI secolo che nel XX, eppure mi sembra di essere ancora un uomo del Novecento.
Ad ogni modo, molto più concretamente, quest’anno sarà complicato credo per i romani, col giubileo; meno per tutti gli altri, che si vedranno i mesi sfilare via come al solito,da sotto agli occhi troppo in fretta.
Per me si prospetta un anno intenso come lo scorso, e forse ancora di più. Oltre ai progetti vari, ricominceranno anche le conferenze e le presentazioni di Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva e de La storia in scena in giro per l’Italia: solo per darvi qualche prima anticipazione, vi posso dire che sabato 25 gennaio sarò alla Libreria Lovat di Treviso (anzi, Villorba) per il primo libro, mentre lunedì 10 febbraio dovrei tenere online un webinar di storia per presentare il secondo (a cui seguiranno però anche incontri dal vivo). Altre informazioni su questi libri le trovate più avanti in questa stessa newsletter.
Se siete nuovi – e potreste esserlo, perché la newsletter accoglie decine di nuovi iscritti ogni settimana – sappiate che qui parliamo di libri, film e questioni di attualità più o meno legate alla storia e alla filosofia (ma anche alla sociologia, alla scienza e alla cultura in generale). È una newsletter sempre lunga e sempre corposa, ma ovviamente potete pescare solo quello che più vi interessa. E poi ci sono i rimandi al canale YouTube e ai podcast, che costituiscono il punto da cui tutto è nato: trovate più informazioni su questi elementi scorrendo la newsletter fino in fondo.
Ma adesso basta con le presentazioni teoriche: passiamo alla pratica. Cominciamo.
Quello che ho letto
Partiamo come al solito dai libri. Niente di troppo nuovo rispetto alle settimane scorse, nell’elenco di questa volta, ma qualche volume giunge ormai al termine.
Scritti e discorsi di Benito Mussolini: avrete forse letto la polemica di fine anno, quando il 31 dicembre il quotidiano Libero diretto da Mario Sechi, già portavoce di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, ha fatto una prima pagina a nove colonne per nominare Benito Mussolini “uomo dell'anno”. Una prima pagina volutamente provocatoria, fenomeno a cui Libero non è certo nuovo: l'anno scorso aveva nominato uomo dell'anno addirittura Giorgia Meloni, in un curioso scambio di sesso che dovrebbe essere malvisto dagli esponenti della destra estrema, sempre molto rigidi sull’identità sessuale; ma Meloni può essere donna e uomo contemporaneamente, pare. La combo Meloni-Mussolini, un anno dopo l’altro, potrebbe chiaramente far alzare qualche sopracciglio, ma Libero da molti anni pare puntare più a fare trolling che informazione, e quindi anche quella paginona col volto di Mussolini non deve poi così stupire. Al di là di questo, però, c’è anche qualcosa di vero in quella scelta: perché in effetti l’ex Duce è ancora oggi uno degli uomini più studiati e discussi della nostra Italia contemporanea, sia a livello accademico, sia a livello popolare. C'entra anche il fatto, ovviamente, che nel 2024 ricadesse il centesimo anniversario del delitto Matteotti, e che proprio in questi primi giorni del 2025, invece, ci sia stata la ricorrenza del famigerato discorso del 3 gennaio 1925 con cui Mussolini si assunse la responsabilità di quell'omicidio e diede il via alla dittatura a viso aperto. Senza contare, inoltre, che quest'anno cadranno gli ottant'anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e quindi dalla fine della dittatura in Italia; e senza contare, per calare l’ultimo asso, che sta per uscire su Sky l’attesissima serie televisiva M, proprio dedicata a Mussolini e tratta dai romanzi di Antonio Scurati. Insomma, è proprio vero che Mussolini è in un certo senso l’uomo dell'anno, ma mi pare anche giusto che sia così: è stata una delle personalità – ovviamente nel male – più rilevanti del secolo scorso, e cercare di studiarlo e capirlo è sempre importante. Se poi egli costituisca, come sostiene Sechi nel suo editoriale, l'ossessione della sinistra, non saprei dirlo: o, meglio, per quanto mi riguarda dovrebbe essere l’ossessione storica di tutti noi, di sinistra, di centro o di destra. Mi meravigliano sempre, anzi, quelli che vorrebbero metterlo nel cassetto, archiviarlo, quando lo spirito che lui (anzi, LVI) ha incarnato – il disprezzo delle regole, l’uso e l’esaltazione della violenza, la sbruffonaggine, il ricorso all’idea dell’uomo forte, un non nascosto razzismo – aleggia ancora più o meno nell’aria, anche se in forme diverse da un tempo. Senza dimenticare che ora, per la prima volta, abbiamo al governo un partito che fa ancora fatica a distaccarsi completamente da quella memoria e da quella nostalgia: mi sembra anzi che di Mussolini si parli fin poco, date le circostanze. Ad ogni modo anch'io, non certo per motivazioni politiche ma soprattutto storiche, quest'anno ho dato molto peso a quella figura, rileggendo in particolare i suoi Scritti e discorsi che proprio questa settimana ho portato a termine, dopo qualche mese di studio e attenzione. E come ho detto altre volte, bisogna secondo me ammettere una cosa: che Mussolini non ha mai nascosto ciò che era. Leggendo i suoi discorsi, emerge tutto di lui, senza timidezze: nelle sue parole si sentono tutta la sua tracotanza, la sua eccessiva autostima, anche l’ignoranza piuttosto crassa (era davvero un uomo di cultura superficiale, e lo si vede chiaramente dai riferimenti con cui tentava di infarcire i suoi discorsi), l’incapacità di vedere la realtà delle cose, il perenne intento di nobilitare ciò che nobile non era; ma anche l’incoerenza, l’opportunismo con cui, di anno in anno, cambiava idea su tutte le questioni principali pretendendo però di dimostrarsi lineare e coerente. Ad esempio, un anno diceva che tutto presto sarebbe diventato facile; tre anni dopo diceva che tutto era difficile, e però sottolineava di averlo detto fin da subito, agli italiani, che le cose sarebbero state dure: un ciarlatano privo di vergogna, in pratica, con in più il difetto di essere circondato da una sfilza di manigoldi violenti. Ed è tutto lì, nero su bianco, evidente a chiunque abbia voglia di leggere le sue parole. Mi chiedo come, riguardando quei discorsi così assurdi e platealmente smentiti dalla storia, ci si possa dire oggi mussoliniani; eppure ancora esistono molti ammiratori di Mussolini. Che non abbiano mai letto davvero gli scritti del Duce? Che non li abbiano capiti? Che non ne abbiano colte le contraddizioni irrisolvibili? Non so, per me certe cose rimangono un mistero. Se volete anche voi immergervi in quest’anno mussoliniano, potete comprare e leggere i suoi discorsi qui.
L’incendio di Cecilia Sala: continuiamo a non avere particolari notizie su Cecilia Sala. O, meglio, sappiamo che la sua detenzione in Iran è particolarmente gravosa e stressante, soprattutto per il fatto che sia in isolamento, sottoposta al regime carcerario che di solito si riserva ai più gravi nemici del regime; ma non arrivano novità sulla sua scarcerazione. In questa settimana online si è letto di tutto, e ovviamente non sono mancate le offese alla giornalista da parte dei soliti stupidi commentatori, che l’hanno accusata di essere comunista (evidentemente non sanno che scrive per Il Foglio, che è parecchio lontano dal comunismo) o di essersela cercata. Come al solito, chiunque abbia una tastiera o un cellulare in mano si sente in diritto di poter dire la sua, senza aver mai aperto un libro, senza aver mai fatto un viaggio, senza conoscere la benché minima frazione dell’argomento su cui si vuole esprimere. E allora, forse proprio per questo, vale la pena proprio di prenderli in mano, i libri, a partire da quello di Cecilia Sala, L'incendio, uscito pochi mesi fa e baciato da un buon successo in libreria. Lo sto leggendo abbastanza velocemente, anche perché non è così lungo e racconta storie umane, che quindi scorrono via in modo particolarmente veloce. Forse, proprio per questa voglia di raccontare il lato umano di ogni cosa, finisce per non essere troppo diverso da tanti reportage che abbiamo letto in questi anni, però sicuramente è un ottimo punto d’avvio per chi vuole saperne di più sulla popolazione dell'Iran, dell'Ucraina e di altri paesi simili, magari anche con un linguaggio un po' più fresco e un po' più giovanile della media. Mi sembra infatti un libro adatto soprattutto ai giovani, a chi non conosce già quelle situazioni e vuole però avvicinarvisi. Il libro può essere comprato qui.
Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello: a proposito di conclusioni: questa settimana ho portato a termine anche Uno, nessuno e centomila di Pirandello, soprattutto in vista della riunione del Club del Libro (info qui) che si terrà per la verità tra circa una settimana. E devo dire anche che il romanzo mi è piaciuto, e molto: mi è sembrato più breve di quanto lo ricordassi, più teso, oltre che più efficace nel sostenere la sua tesi. E quando dico “più”, intendo rispetto a come me lo ricordavo dalla lettura precedente, effettuata per la verità vari anni fa. Questo non so se sia un bene o più propriamente un male: perché vuol dire che invecchiando cambio gusti, forse divento più filosofo (e apprezzo di più le tirate filosofiche), ma magari anche perdo un po’ di energia. A ben guardare, infatti, Uno, nessuno e centomila è un romanzo in cui non succede praticamente niente: i soliloqui hanno la netta predominanza sui fatti, e la trama è esilissima se non inesistente. La si potrebbe riassumere così: un uomo, Vitangelo Moscarda, si accorge di avere il naso storto, e un po’ alla volta si rende conto che ognuno lo vede in un modo diverso, in un modo che tra l’altro non corrisponde per nulla al modo in cui si vede lui stesso. Un po’ alla volta questa consapevolezza – quella di essere uno e centomila, ma forse in realtà nessuno – lo porta praticamente alla pazzia, ben attorniato però da personaggi o ipocriti, o altrettanto pazzi. Fine. Ma ovviamente quel che conta non è la trama, imbastita da Pirandello solo per dare un po’ più di forma a quelle riflessioni, che tra l’altro lo scrittore siciliano covava da una vita, già presenti – anche se in modo più sparso – in decine di altre sue opere; quel che conta è appunto la filosofia. Un giovane, forse, davanti a tutto questo filosofeggiare potrebbe anche annoiarsi, e credo che una volta la pensassi anch’io così, pretendendo almeno un po’ di fatti, da un romanzo; ora che mi faccio vecchio, e che ai romanzi comincio a preferire spesso i saggi, invece mi scopro più vicino a Pirandello, e appunto non so se sia un bene, perché significa che la mia impazienza giovanile e la mia vitalità sono ormai un affare del passato. Comunque il libro, lo ripeto, mi è piaciuto e mi sentirei sicuramente di consigliarlo, almeno a chi ha un po’ d’età sulle spalle e ha messo da parte l’irruenza della gioventù per un po’ di amore per la riflessione. Lo potete comprare qui.
Quello che ho visto
Per quanto riguarda i film, in elenco questa settimana c’è un classico intramontabile del cinema americano, a cui aggiungo due serie comiche relativamente recenti.
Only Murders in the Building episodi 4.9-4.10 (2024), di Steve Martin e John Hoffman, con Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez: ho finito in questi giorni la quarta stagione di Only Murders in the Building, una serie che negli ultimi anni ci ha tenuto compagnia spesso su queste colonne. Ed è forse quindi giunto il momento di provare a fare un’analisi un po’ distaccata della qualità di questo show. Come ho detto altre volte, la trovo una serie simpatica e intelligente: verte infatti attorno a un paio di arzilli vecchietti che, assieme a una più giovane vicina di casa, iniziano a indagare su alcuni omicidi che si compiono nel loro palazzo newyorkese. Si tratta quindi di un giallo, ma vissuto con i toni della commedia, visto che i protagonisti non rischiano mai davvero nulla e anzi sono quasi delle macchiette, in parte incompetenti e incapaci, e in parte però dotati anche di uno strano talento nel riuscire, alla fine, a scovare il colpevole. La storia viene via via dipanata in maniera simpatica e leggera, diventando, almeno nelle prime stagioni, anche appassionante. Secondo me la quarta di queste stagioni ha però mostrato da un lato qualche slancio nuovo e intrigante, ma dall'altro anche una certa stanchezza: è difficile infatti dopo quattro anni continuare a inventare trame plausibili e a non ingarbugliare troppo la matassa. A mio avviso, infatti, l'aspetto più propriamente giallo di questa ultima stagione è quello più deludente, perché è stato onestamente difficile riuscire a seguire l'alternanza dei sospettati e appassionarsi al relativo mistero. Molto meglio sono andati, invece, gli aspetti collaterali: c'è stato un vero e proprio profluvio di star, da Meryl Streep a Paul Rudd, da Zach Galifianakis a Eva Longoria, da Eugene Levy a Scott Bakula, fino a Ron Howard e Téa Leoni, presenti nel finale di stagione. E poi, in generale, quest'ultima annata ha citato e omaggiato diversi film e registi del passato, a volte con scelte anche di montaggio piuttosto ardite per una serie TV, anche se non sempre funzionali alla trama. Insomma, luci ed ombre; e il mio timore è che, con l’andar del tempo, le luci cedano sempre più il passo alle ombre. Capisco il successo del format, ma forse poteva essere una buona idea fermarsi dopo due o tre stagioni, e magari creare qualcosa di completamente diverso, senza inflazionare troppo i personaggi e l’idea di partenza. In ogni caso, pare che ci sarà sicuramente anche una quinta stagione, e vedremo se varrà la pena di guardarla. Se volete recuperarla, la trovate su Disney+.
Manhattan (1979), di Woody Allen, con Woody Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway: se seguite la newsletter da un po’ di tempo (o se avete letto Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva), sapete già che sono appassionato dei film e delle opere di Woody Allen. La sua sterminata produzione ha avuto i suoi alti e i suoi bassi e non è tutta, ovviamente, dello stesso livello, ma i suoi film migliori sono indimenticabili. Tra questi c’è di sicuro anche Manhattan, che ho visto tre o quattro volte ma che ho recuperato proprio questa settimana, dopo un digiuno a dire il vero di diversi anni. E rivedendolo mi sono tornate alla mente cose che avevo già notato le altre volte, ma che in qualche modo ogni volta dimentico. Ad esempio, che la vita del Ross di Friends è palesemente ispirata a quella del protagonista del film, l’Ike interpretato da Woody Allen: entrambi sono ebrei newyorkesi, entrambi sono stati lasciati da una moglie che si è scoperta lesbica (e che comunque era già incinta di lui), entrambi poi hanno una relazione con una ragazza troppo giovane che va ancora a scuola, entrambi sono più o meno intellettuali. Insomma, quando gli autori di Friends hanno pensato a Ross, l’hanno abbastanza modellato su questo personaggio, anche se ovviamente con meno autoreferenzialità freudiane e con un tono più leggero. Segno di quanto con questo film a volte sottovalutato Woody Allen abbia in realtà inciso sull’immaginario americano, su come vediamo i newyorkesi. Io e Annie è spesso considerato il capolavoro di Allen, ma io l’ho sempre messo in realtà al terzo o quarto posto nella mia personale graduatoria (certo, bellissimo, ma forse un po’ disomogeneo). Manhattan, secondo molti, è il capolavoro vero. Io non lo so se lo metterei in cima alla lista, ma certo è un lavoro coi controfiocchi, e le inquadrature di Manhattan, il bianco e nero e l’immagine in widescreen sono la ciliegina sulla torta. La storia è appunto quella di Ike, quarantenne newyorkese in crisi, che decide di lasciare il lavoro in televisione per scrivere un grande romanzo sulla sua città, New York; solo che, invece di lavorare al libro, cerca di barcamenarsi all’interno di una frastagliata vita sentimentale, tra una diciassettenne che lo adora (interpretata molto bene da Mariel Hemingway, nipote di Ernest), una donna di cui si innamora che però è l’amante del suo migliore amico (Diane Keaton) e una ex moglie lesbica (Meryl Streep). E in tutto questo ci sono anche le battute del miglior Allen. Lo trovate su RaiPlay.
It’s Always Sunny in Philadelphia episodi 2.04-2.05-2.06 (2006), di Rob McElhenney, con Rob McElhenney, Glenn Howerton, Charlie Day: vi ho già detto nelle settimane scorse quanto adori la comicità scorretta e volgare di C’è sempre il sole a Philadelphia, la serie prodotta in America da FX che vanta ormai ben sedici stagioni in archivio, con la diciassettesima che, a quanto si legge, è in fase di registrazione. Non ho mai visto le ultime annate, sulla qualità delle quali ho letto comunque giudizi contrastanti, ma le prime stagioni erano dissacranti e da qualche tempo ho cominciato a rivederle con gusto, ora che sono comparse su Disney+. Sia chiaro: non si tratta di una visione adatta a tutti. Il linguaggio è volgare, i temi sono scabrosi (solo nelle tre puntate che ho visto questa settimana si parla di sesso per vendetta, ricatti, boxe, anfetamine, incontri di lotta clandestini e alcolismo) e i tre protagonisti sono il peggio del peggio: immorali, infidi e traditori. Insomma, è una serie che mette in fila delle vere e proprie mostruosità, spingendoci tra l’altro a riderci sopra. Così alla fine di ogni puntata ti scopri ancora col sorriso sulle labbra, e però subito dopo ti penti, perché ti dici: «Ma io sto davvero ridendo di gente che maltratta i ragazzini?» E la risposta è sì, e a quel punto oltre al divertimento senti anche il senso di colpa. Umorismo nero che funziona, all’ennesima potenza. La serie la trovate su Disney+.
Quello che ho pensato
Ho aspettato a lungo prima di scrivere questo testo, ma penso che ormai sia giunto il momento di farlo, e di esprimere quello che penso su Elon Musk. O, meglio, quello che penso sul nuovo ruolo politico che Elon Musk si è assunto negli ultimi mesi; anzi, sul peso che diamo alle uscite politiche di Elon Musk. Lo faccio, sia chiaro, non tanto perché mi interessi di Musk in sé e per sé, quanto perché questo caso mi pare ci consenta di riflettere sui rapporti di potere all’interno delle nostre democrazie, sul fine ultimo di questi sistemi di governo e magari anche, perché no, sulla natura politica delle persone.
Vorrei partire, infatti, da un assioma che ritengo di per sé autoevidente: una buona parte di noi tende, sempre e in ogni circostanza, a sovrastimare gli uomini o almeno una parte di essi. Siamo naturalmente spinti, forse per una innata speranza nel nostro prossimo o forse per ragioni evolutive, a fidarci degli altri; magari non di tutti, ma di qualcun altro sì, di un gruppo di persone sì. Ci fidiamo e speriamo che questo qualcun altro possa risolvere i nostri problemi, possa migliorare il nostro mondo, possa elevarci o salvarci.
Tutte le religioni, se ci pensate bene, nascono da questa speranza: dalla ricerca di un Messia che salvi l’umanità, dalla speranza di aver individuato un uomo migliore degli altri che possa, nella sua magnificenza, mondare i peccati del mondo. Sia esso Gesù Cristo, Maometto, Martin Lutero, il Buddha, un profeta o non so chi altro, siamo sempre alla ricerca di un uomo che ci risolva i problemi esistenziali e ci metta in contatto con una dimensione più alta.
Su questa speranza si basa anche ogni elezione politica: ci affidiamo a un partito, e quindi a un leader o a un candidato, e lo sosteniamo perché siamo convinti che sia la persona giusta per risolvere i problemi. Le dittature rappresentano, da questo punto di vista, quella speranza portata fino alle estreme conseguenze: quando quella fiducia diventa fede, quando quella speranza diventa certezza, allora ci si affida mani e piedi all’Hitler di turno, considerandolo infallibile e dotato di poteri semi-divini. E non ci passa neppure per la testa di poter contestare una decisione o una parola di quell’entità così alta e santa che abbiamo eretto a nostro protettore.
Certo, questo atteggiamento non è diffuso in tutti in ugual misura, e anzi esistono anche dei pessimisti – in genere burberi e asociali, tipo Schopenhauer o lo Scrooge di dickensiana memoria – che non hanno alcuna fiducia nel genere umano, che non si fidano di nessuno. Ma sono pochi, costituiscono una minoranza anche piuttosto esigua: i più tendono verso l’altra parte, vogliono aver qualcuno in cui credere, qualcuno in cui sperare.
Anzi, mi verrebbe anche da tentare un azzardo sociologico: la mia impressione è che più si abbassi il livello d’istruzione, più si alzi la ricerca di qualcuno in cui riporre ogni fede; più si abbassi il quoziente intellettivo, più si sia disposti a credere che esistano uomini infallibili e perfetti a cui dovremmo delegare il potere e le scelte.
Alcuni studi – seppur non conclusivi – sembrano indicare proprio una tendenza di questo tipo. Prendete ad esempio il lavoro di S.J. Ritchie e E.M. Tucker-Drob intitolato How much does education improve intelligence? A meta-analysis: lì, mettendo insieme tanti dati e tanti studi, i due ricercatori sono giunti a una conclusione che a noi può apparire scontata, ma che lo è solo fino a un certo punto, e cioè che gli anni di educazione impattano significativamente sul livello di intelligenza della persona. Ovvero, che più studi, meno sei propenso a credere in soluzioni semplicistiche. Ad esempio, a credere a figure messianiche.
Ancora più interessante è però lo studio intitolato Does intelligence foster generalized trust? An empirical test using the UK birth cohort studies di Patrick Sturgis, Sanna Read e Nick Allum. In quello studio si analizza il meccanismo della fiducia e la sua correlazione con l’intelligenza, facendo notare che la persona più intelligente tende a dare fiducia in maniera più consapevole, commettendo meno errori. Per semplificare, potremmo dire che lo stupido è quello che si fida di persone di cui sarebbe meglio non fidarsi, mentre l’intelligente sceglie con maggior cura chi beneficiare della propria fiducia. E fin qui, di nuovo, nulla di sconvolgente, sono cose abbastanza intuitive; ma lo studio evidenzia anche che le persone intelligenti, proprio per questi motivi, non delegano incondizionatamente la loro fiducia, e scelgono invece approcci più collaborativi. Detta in altri termini: non si affidano a occhi chiusi a qualcuno, ma vogliono delegare solo una parte della scelta, capendo fino in fondo i termini della questione. In ambito politico, questo vorrebbe dire che danno il voto, ma pretendono di sapere a chi lo danno, per cosa lo danno e come controllare poi l’operato del politico di turno; mentre gli stupidi tenderebbero a votare a scatola chiusa, ciecamente.
Gli studi, insomma, non dimostrano tutto, ma ci danno un’indicazione: più studi, più diventi intelligente, più capisci che le cose sono complicate e meno credi ai messia. Più studi, più sai che nessuno può risolvere i problemi con uno schiocco di dita, e che anzi è bene controllare come agisce. Sembra lapalissiano, scontato, eppure molti di noi agiscono stupidamente, continuando a credere che il salvatore della patria sia dietro l’angolo. Nonostante tutte le delusioni patite – perché i presunti messia che incontriamo sulla nostra strada ci deludono sempre, presto o tardi –, continuiamo a cercare qualcuno su cui riporre tutta la nostra fiducia.
Votiamo col cuore in mano per un leader, anche se sotto sotto sappiamo che – tempo un anno o due – quel leader ci deluderà e ne cercheremo uno diverso a cui affidarci; e se non ci deluderà, sarà solo perché avrà trovato il modo di scaricare la colpa dei suoi fallimenti su qualcun altro, sul suo entourage, su una minoranza etnica o religiosa, sul nemico interno o esterno o su chi volete voi. Ma è inevitabile che la delusione prima o poi arrivi: perché qualsiasi uomo politico, anche il più dotato, prima o poi fallisce, e quasi sempre fallisce molto miseramente.
La conseguenza è che continuiamo a cambiare persona di cui innamorarci, continuiamo a cambiare messia; e i messia precedenti, quelli a cui avevamo dato fiducia e che poi ci hanno delusi, diventano dei pària, dei lebbrosi, dei diseredati. Non sono neppure più uomini, per noi: sono imbecilli, imbelli, lordume. Come innamorati delusi, gettiamo su di loro tutto il fango e il disprezzo che possiamo radunare.
Questo fenomeno, di per sé, non è nulla di nuovo. Da millenni cerchiamo dei leader, e da millenni continuiamo a sbagliare, affidandoci a persone che poi non si rivelano quasi mai davvero degne di quel titolo. I filosofi se ne sono accorti da molto tempo, e ce lo hanno mostrato ampiamente, anche se non abbiamo voluto ascoltarli. Tra tutti, vi riporto solo due esempi che mi sono molto cari: il primo viene da Carlo M. Cipolla, il secondo da Michel de Montaigne.
Carlo M. Cipolla è stato un grande storico dell’economia, forse il più grande nel suo settore. Ve ne ho già parlato altre volte, sia per i suoi studi seri, sia per qualche piccolo divertissement che si divertì, in vita, a scrivere per gli amici, ma che poi ha avuto una notevole fortuna editoriale. Sto parlando ad esempio de Le leggi fondamentali della stupidità umana, breve scritto in cui Cipolla dà una sua definizione di stupidità (usando un famoso grafico ad assi cartesiani) e soprattutto enuncia una serie di leggi assiomatiche. La prima legge fondamentale è quella che oggi interessa a noi, e dice questo: «Sempre ed inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero di individui stupidi in circolazione». Che è come dire che sovrastimiamo le persone: non ci accorgiamo di essere circondati da una marea di stupidi, e tendiamo a scegliere come salvatore della patria solo un altro stupido.
Michel de Montaigne, invece, è un filosofo rinascimentale che però sui limiti degli esseri umani – in un’epoca in cui si tendeva a vederne soprattutto i pregi – ha scritto delle pagine memorabili. Ad esempio, nel libro III dei Saggi, capitolo XIII (Dell’esperienza), scriveva: «Così, abbiamo un bel montare sui trampoli, perché anche sui trampoli bisogna camminare con le nostre gambe. E sul più alto trono del mondo non siamo seduti che sul nostro culo». Come a dire: ci esaltiamo tanto, ma siamo pur sempre umani, e quindi fallibili, anche se facciamo finta di non ricordarcelo.
Direte: ma non dovevi parlarci di Elon Musk? Che cosa c’entrano Cipolla e Montaigne? Cosa c’entrano i messia? C’entrano, c’entrano, ora ci arriviamo.
Per qualche anno, Elon Musk è stato esaltato dai giornali come un vero e proprio genio, come il Prometeo moderno. E in effetti, in campo imprenditoriale e ingegneristico, Musk ha inanellato una serie impressionante di successi: PayPal, SpaceX, Tesla, OpenAI, Neuralink e chi più ne ha, più ne metta. Difficile trovare una persona che sia riuscita ad avere un tale successo in campi così diversi e in così poco tempo: e non per nulla Musk è oggi l’uomo più ricco del mondo e uno dei più ricchi della storia.
Quindi è il Messia? Ecco, qui casca l’asino. Perché, come dice Montaigne, anche «sul più alto trono del mondo non siamo seduti che sul nostro culo». Elon Musk è un essere umano come noi. Sì, esattamente come noi, sia dal punto di vista biologico che fisiologico: quando deve andare in bagno ci va, e magari ha anche lui i suoi problemi intestinali come noi; prima o poi morirà, esattamente come noi; è fatto di carne e sangue come noi.
Certo, non è del tutto come noi, altrimenti anche noi saremmo degli imprenditori ricchissimi: ve lo concedo. Ma è un mortale, non un semidio; e per quanto abbia sviluppato competenze straordinarie in certi settori, inevitabilmente ha dei difetti – magari anche gravi – in altri. Nessun uomo sulla faccia della terra, in nessun tempo, è riuscito ad essere perfetto, e dovremmo ormai saperlo.
Cosa significa? Che Elon Musk può essere geniale quanto vuole nel suo settore, ma sarà sicuramente pieno di difetti in altri campi. Per aver sviluppato al massimo grado le sue competenze imprenditoriali, infatti, avrà trascurato inevitabilmente le altre, e direi che gli ultimi mesi ce l’hanno dimostrato in maniera lampante. Per non parlare della sua vita privata, che pare francamente un disastro: almeno in quel campo, io personalmente posso vantare di essere mille volte meglio di Elon Musk, e probabilmente anche voi potete fare lo stesso. Essere un bravo marito o una brava moglie non vi farà finire sulle prime pagine dei giornali, ma non è – per la qualità della vita vostra e di chi vi sta attorno – una caratteristica poi così irrilevante, e non è detto che saper progettare grandi automobili o satelliti faccia per forza felici i propri cari.
Insomma, Elon Musk non è Dio e non è neppure un genio rinascimentale, capace di dire la cosa giusta in ogni ambito. A volte ci azzecca, e magari ci azzecca al massimo grado, ma altre volte dice delle stupidaggini colossali. Anzi, il tratto più caratteristico di questi presunti geni è proprio questo: che estremizzano ogni lato del loro carattere, quindi sono in grado di passare dall’intuizione più elevata alla cretinata più brutale. Se seguite Musk su Twitter (pardon, X), sapete cosa intendo.
E quindi? E quindi forse dovremmo smetterla di pendere dalle labbra delle persone, si chiamino Elon Musk, Giorgia Meloni, Donald Trump, Barack Obama, Taylor Swift o Greta Thunberg. Sono esseri umani, e dovremmo sottoporre sempre a critica quello che dicono, senza accettarlo per oro colato. Ricordate? Le persone intelligenti fanno questo: sono guardinghe nel decidere a chi dare fiducia, e valutano caso per caso, proposta per proposta, controllando poi quelle persone, rivalutando le loro scelte, ritornando eventualmente sui propri passi. Sembra quasi banale, ma occorre ricordarlo: non basta avere un buon nome per dire cose intelligenti.
E questo vale per i politici e per gli imprenditori, ma vale allo stesso modo anche per i filosofi. Il fatto che un pensatore abbia fatto qualcosa d’importante nel proprio campo non vuol dire affatto che dirà cose sensate anche in altri; banalmente, un bravo logico può anche sostenere stupidaggini in campo politico o sociale, senza per questo scandalizzarci. Che sia una star o l’ultimo dei professori, quello che dice dovrebbe essere sempre sottoposto a un certo vaglio, ricordando che, in quanto essere finito e fallibile, qualche scemenza può sempre dirla.
E lo stesso, infine, vale all’ennesima potenza anche per il sottoscritto. Mi fa molto piacere sapere che qualcuno qua e là si fida del mio giudizio e dei miei punti di vista, ma sono l’ultimo dei divulgatori: non mi fido troppo nemmeno io di quello che dico e di quello che penso, e ritengo che anche non dovreste esagerare nel concedermi troppa fiducia. Siate guardinghi, siate intelligenti; e apprezzate l’intelligenza altrui, ma sempre tenendo i piedi ben piantati per terra.
Quello che ho registrato e pubblicato
Facciamo ora il punto sui video e sui podcast che sono usciti questa settimana:
La nascita della polis: iniziamo a parlare della città-stato dell’epoca d’oro della Grecia antica, con tutte le sue caratteristiche
"Cuore di cane" di Michail Bulgakov - audiolibro spiegato parte 3: continuiamo a leggere il libro di Bulgakov ambientato nella Russia della NEP
Voltaire contro l'ottimismo di Leibniz (per il podcast “Dentro alla filosofia”)
Il fascismo tra leggi razziali e totalitarismo (per il podcast “Dentro alla storia”)
L’antifascismo negli anni '30 (per il podcast “Dentro alla storia”)
Umberto Eco e il rasoio di Occam
Quello che devi fare per seguirmi sui social
Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:
Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads
Quello che puoi fare per sostenere il progetto
Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.
Diario clandestino di Giovannino Guareschi: come vi ho raccontato altre volte, a scuola sto lavorando coi miei studenti a una piccola mostra dedicata agli IMI, gli internati militari italiani durante la Seconda guerra mondiale. Tempo fa, per avere qualche spunto ulteriore, lessi anche il Diario clandestino di Guareschi, forse il più famoso scrittore italiano che visse quell’esperienza. Oggi, a qualche mese di distanza da quella lettura, mi sento di consigliarvelo anche qui, nella nostra piccola biblioteca storico-filosofica, perché si tratta di un libro toccante che però investe prepotentemente una pagina di storia quasi dimenticata. Potete comprarlo qui.
sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):
C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.
Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!
È inoltre da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:
Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:
Quello che c’è in arrivo
E chiudiamo anche questa settimana con qualche anticipazione su cosa ci aspetterà col rientro a scuola (domani mattina si ricomincia). Questi i video e i podcast che ho messo in programma:
domani pubblicherò sul mio canale il video sulla parola-chiave “individuo” che ho già realizzato per la Fondazione Luigi Einaudi;
mercoledì vorrei proporvi un video della serie “Cosa direbbero i filosofi”, incentrato sull’etica della guerra (ammesso che ce ne sia una);
giovedì arriverà uno short incentrato nientemeno che su Richard Wagner;
venerdì e sabato torneranno i podcast, proseguendo il percorso su Voltaire e parlando però anche della crisi del colonialismo tra le due guerre mondiali;
domenica prossima, quindi, si terrà la riunione online del Club del Libro tra gli abbonati, per discutere di Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello;
e lunedì prossimo, infine, a grande richiesta arriverà (se tutto va bene) un video su Noam Chomsky e la sua filosofia.
E questo è tutto anche per questa prima newsletter del 2025. Cercate di mantenere i buoni propositi (almeno quelli più nobili, almeno quelli legati alla cultura e agli affetti) e tornate qui, puntuali, tra una settimana per il nostro prossimo appuntamento. A presto!




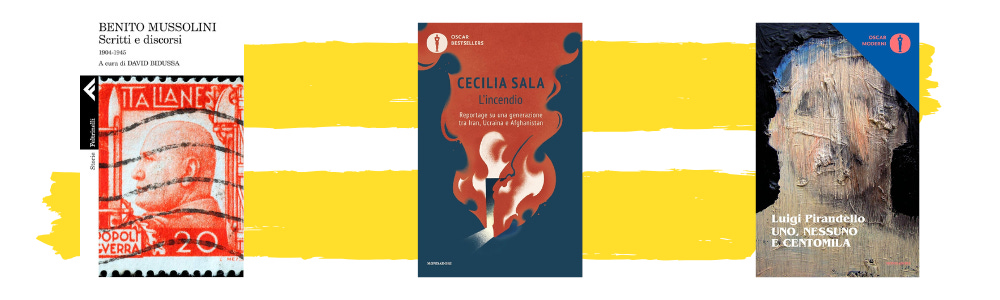

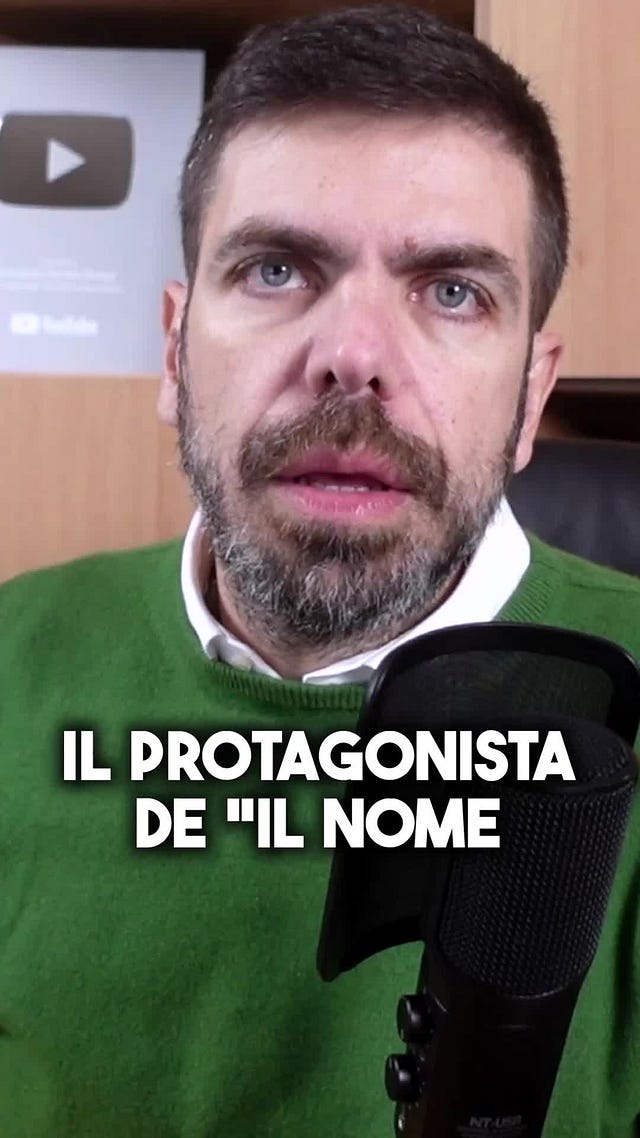



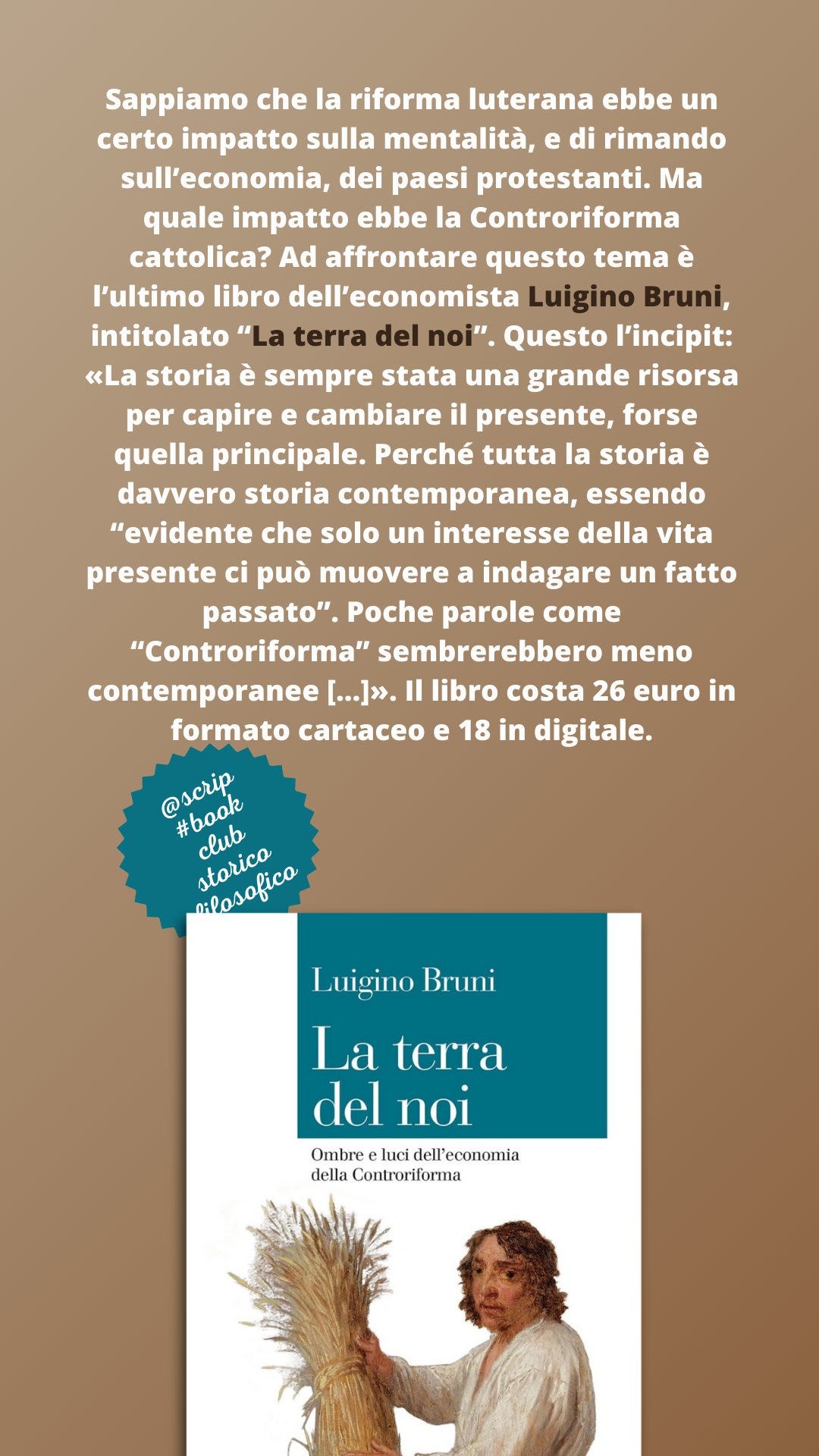
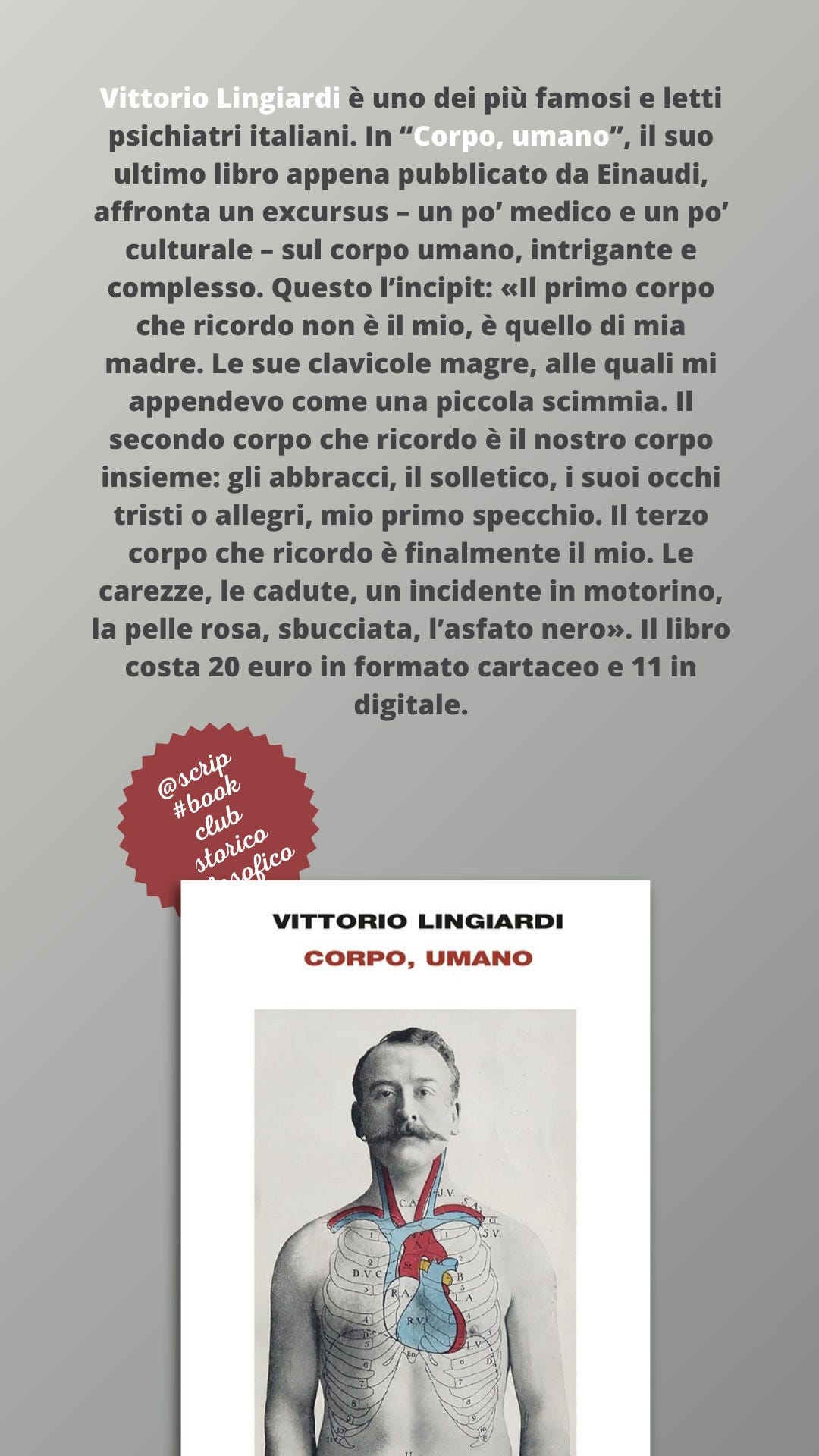
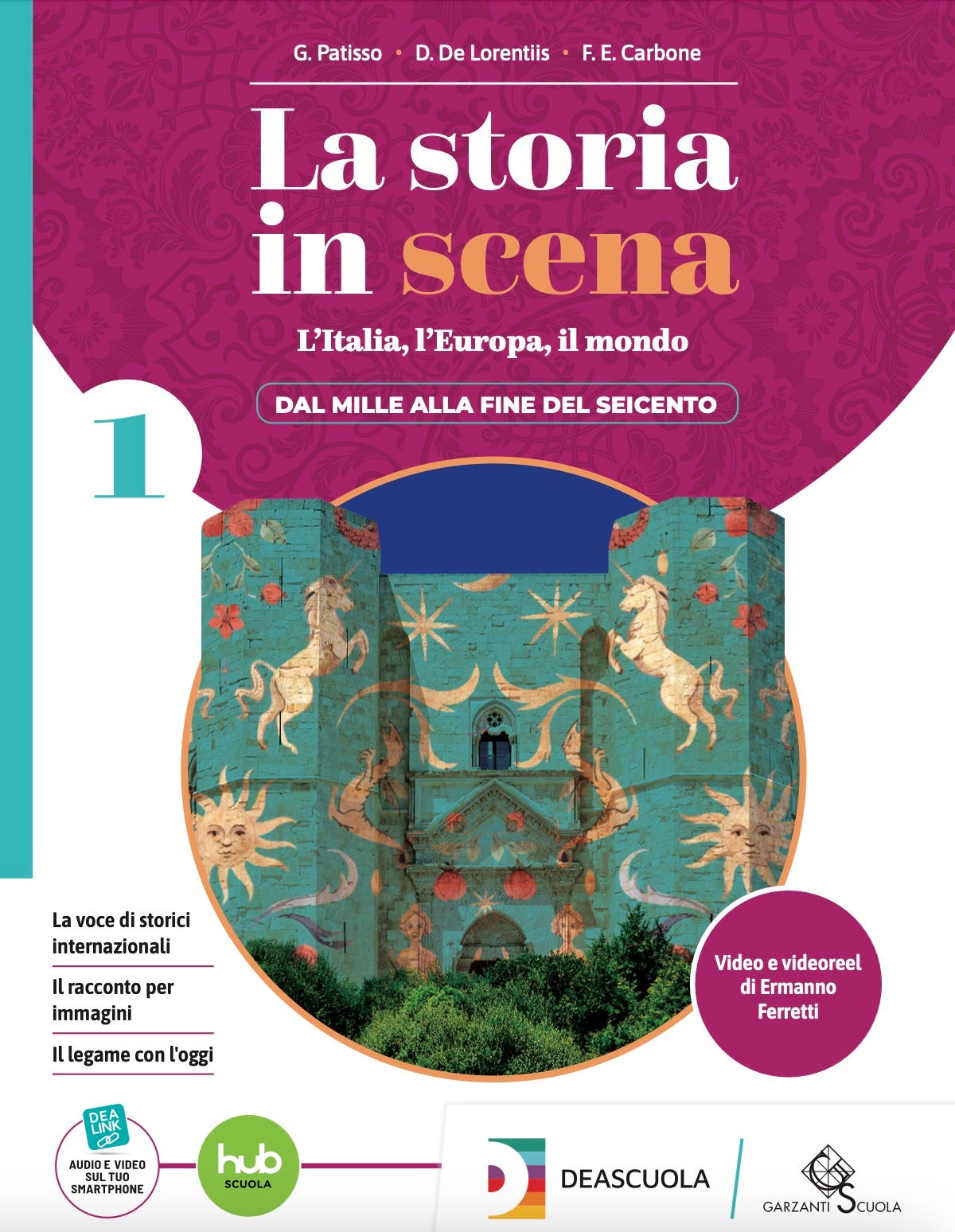
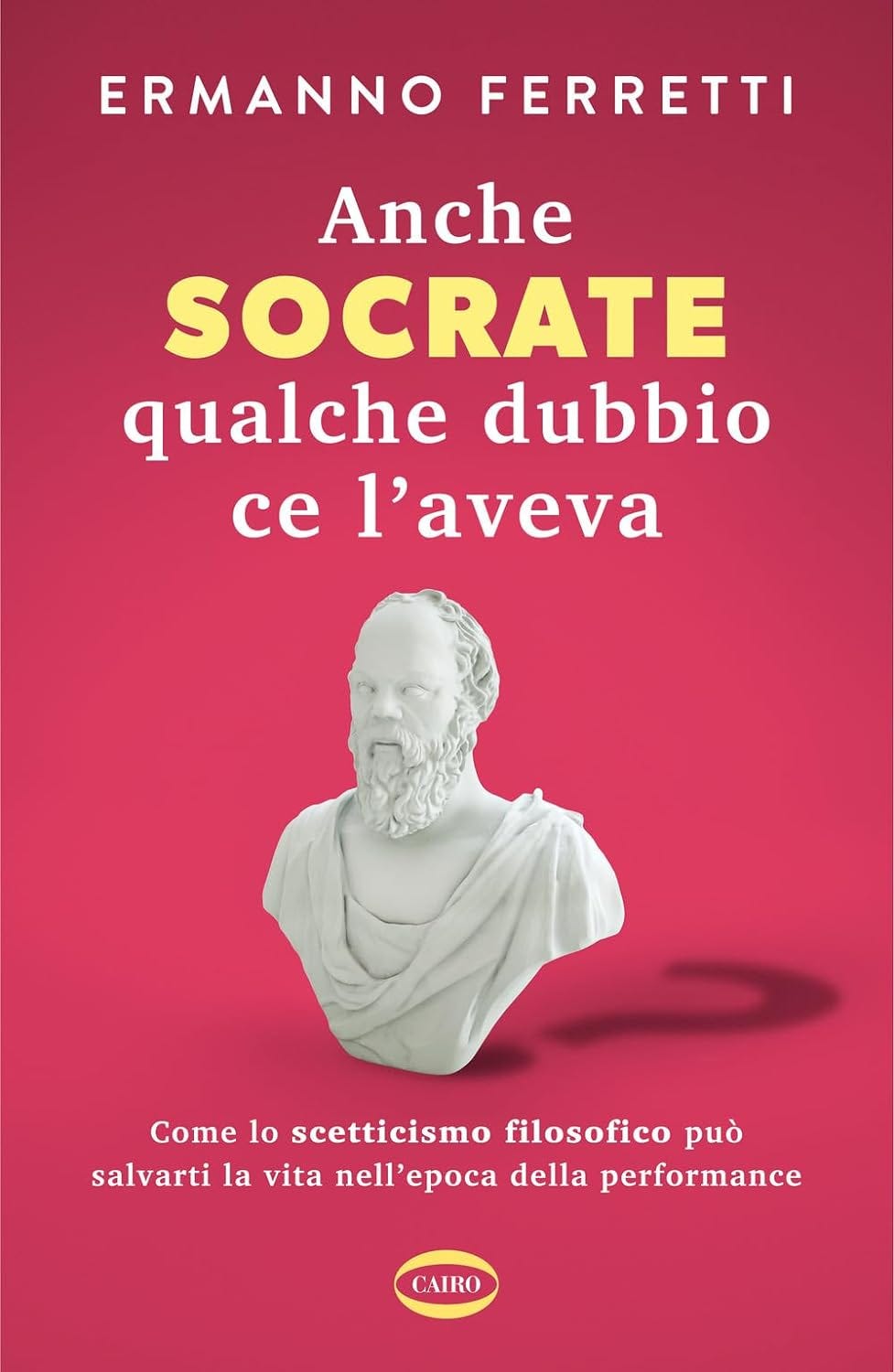
E' interessante quello che afferma , professore . Cercando di portare un contributo alla riflessione , vorrei postare questo articolo che ho appena trovato in Rete .
Cecilia Sala, l’orientamento politico della giornalista
Storia di Simone Frigerio
Cecilia Sala, giornalista d’inchiesta da sempre attenta a tematiche sociali, quindi teoricamente vicina a posizioni storicamente di sinistra, non ha però mai apertamente dichiarato un’appartenenza politica definita. In un’intervista rilasciata nel 2003 al programma Piazza Pulita, di Corrado Formigli su La7, l’allora giovane futura studentessa della Bocconi aveva espresso chiaramente le sue idee politiche, con un endorsement esplicito al giovane Matteo Renzi.
">
“Sono rappresentante di istituto nel mio liceo e mi sono sempre ritenuta una persona di sinistra. Però, sicuramente, non sono una conservatrice: non mi piacciono i conservatori e non darei il mio voto ai conservatori.
Credo che, all’estero, non votare i conservatori sia facile, perché c’è un partito conservatore che, di solito, è un partito di destra. Se non ti piacciono, voti gli altri. In Italia, l’alternativa al partito di destra, che effettivamente è conservatore, anche se con qualche ipocrisia forse (ad esempio partecipa ai Family Day, è contrario alle unioni gay, all’eutanasia e a tante altre cose tipiche di partiti conservatori), è rappresentata dal PD.
Per me, il PD fino ad oggi è altrettanto conservatore, ma lo è su altre posizioni. Ad esempio, è conservatore sul fatto che la spesa pubblica è totalmente intoccabile. E perché è intoccabile? Perché io so che il partito che non dovrebbe essere un partito conservatore in Italia, che si chiama Partito Democratico, è l’ultimo partito tra i giovani e il primo partito tra i pensionati e i dipendenti pubblici. Non tocca la spesa pubblica perché quella è la sua base elettorale.
Non tocca la spesa pubblica non perché vuole che lo Stato spenda — anche io voglio che lo Stato spenda — ma non voglio che spenda per accontentare gli elettori del PD affinché continuino a votare PD. Voglio che spenda per la mia scuola.
E credo che Renzi, oggi, porti qualcosa di diverso a sinistra, senza rinunciare alla sinistra. Renzi, infatti, dice che la prima infrastruttura d’Italia sono gli asili nido. Questa è una delle proposte del programma di Renzi.
Beh, credo che, se Berlusconi andasse a dire ai suoi amici imprenditori che hanno preso l’appalto per l’Expo da un miliardo che, da oggi, la prima infrastruttura dell’Italia sono gli asili nido, non reagirebbero benissimo. Credo che quello sia di destra. E quello che dice Renzi è un po’ meno di destra”.
Intrapresa la carriera giornalistica freelance, Sala ha poi scritto sia per testate ‘liberali’ come Repubblica o Il Post, sia per pubblicazioni di orientamento più ‘destrorso’ come Il Foglio
Ci vediamo alla libreria Lovat di Treviso allora! Io abito a Treviso 😉😎